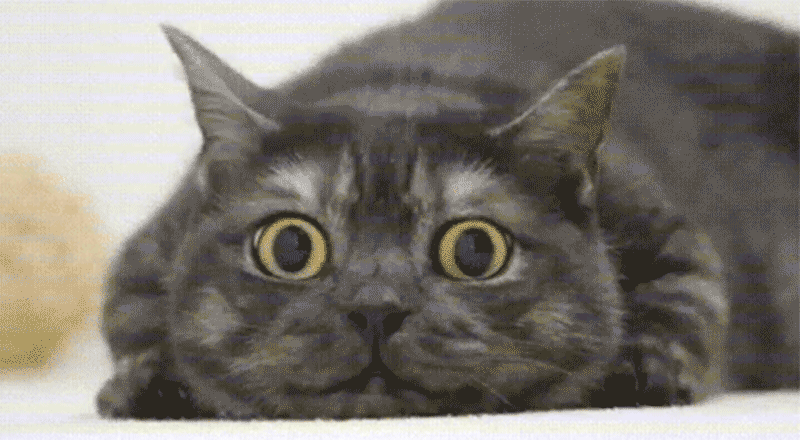Che cosa è stato il Concilio Vaticano II
50 anni fa la Chiesa vide il cambiamento, vi si avvicinò e lo ostacolò insieme, come fa tuttora
di Davide Maria De Luca
L’11 ottobre del 1962 cominciò a Roma il Concilio Vaticano II, una riunione di tutti i vescovi del mondo in cui vennero discussi i rapporti tra la Chiesa e la società moderna. Il Concilio durò – in quattro successive sessioni – fino al 1965, e fu il più grande tentativo compiuto dalla Chiesa cattolica di modernizzarsi dall’inizio della sua storia.
Con il Concilio cambiarono dei tratti fondamentali della liturgia come ad esempio la partecipazione attiva dei fedeli a una messa celebrata nella lingua nazionale e non più in latino e alla lettura e scelta dei testi. Ci furono anche cambiamenti dottrinali, ma soprattutto culturali, nella direzione di un maggiore avvicinamento alla società laica. La valutazione dell’eredità del Concilio, le critiche alle sue conclusioni e i suoi effetti hanno costituito il grande tema sul quale la Chiesa cattolica si è divisa negli ultimi cinquant’anni.
Perché Concilio, Vaticano e secondo
Un Concilio è l’assemblea suprema della Chiesa Cattolica ed è composto dal Papa, dai Patriarchi, dai Cardinali, dai Vescovi e dai capi degli ordini religiosi (solo quelli maschi). Un Concilio prende decisioni in materia di legislazione ecclesiastica, dottrina e liturgia, ma per essere valide le sue decisioni devono essere approvate dal Papa che resta il capo assoluto della Chiesa cattolica. In tutto la Chiesa cattolica ha tenuto 21 Concili Ecumenici in 1700 anni.
Ogni Concilio prende il nome dal luogo dove si tiene – ad esempio Concilio di Trento o Concilio di Nicea. Quello Vaticano si tenne nella basilica del Vaticano a Roma, trasformata per l’occasione in una specie di parlamento, con grandi gradinate di legno poggiate lungo le pareti. Come è facile immaginare, prima del Vaticano II ce ne fu un primo, sempre tenuto nella stessa Basilica: iniziò nel 1870 e fu interrotto dalla presa di Roma da parte del Regno d’Italia.
I papi
A inaugurare il Concilio Vaticano II fu Papa Giovanni XXIII, Angelo Roncalli, passato alla storia come “il Papa buono”. Roncalli era stato eletto Papa nel 1958, quando aveva 78 anni. Secondo alcuni storici venne scelto dai cardinali proprio per la sua età e per il suo carattere malleabile. Doveva essere un Papa di transizione, cioè un Papa con un regno breve che doveva servire soltanto a rimandare lo scontro tra le varie fazioni che dividevano la Curia. Giovanni XXIII morì nel 1963, prima di poter portare a compimento i lavori del Concilio. Gli successe Paolo VI e molti pensarono che il nuovo Papa avrebbe fermato i lavori del Concilio che stavano già cominciando a rivoluzionare molti aspetti della Chiesa. Paolo VI invece portò i lavori al loro compimento naturale e chiuse il Concilio nel 1965.
Il Concilio
La sera dell’11 ottobre 1962, il giorno in cui era stato convocato il Concilio, piazza San Pietro si era riempita di fedeli che chiedevano al Papa di affacciarsi. Non era previsto un discorso, ma Giovanni XXIII si sporse ugualmente dal balcone e parlò, improvvisando un discorso a braccio. Fu quello che passò alla storia come il “Discorso della luna” e che terminava con le parole: «Tornando a casa, troverete i bambini. Date una carezza ai vostri bambini e dite: questa è la carezza del Papa. Troverete qualche lacrima da asciugare, dite una parola buona: il Papa è con noi, specialmente nelle ore della tristezza e dell’amarezza». In quei giorni il Papa sapeva di avere un tumore allo stomaco che gli avrebbe impedito di portare a conclusione il Concilio.
L’idea di iniziare il Concilio aveva colto di sorpresa i cardinali della Curia, cioè dell’amministrazione romana. I primi atti del pontificato di Roncalli erano stati del tutto in linea con la tradizione dei Papi precedenti, che gli storici chiamano “intransigente”, nel senso che non accettava compromessi con la modernità. Negli anni subito prima del Concilio, ad esempio, il Sant’Uffizio, cioè la moderna inquisizione, vietò l’esperienza dei preti operai, quei sacerdoti che in Francia e in Italia avevano cominciato a lavorare in fabbrica per condividere la vita quotidiana e le fatiche degli operai. Alcuni studiosi di esegesi biblica furono sanzionati per le loro letture diverse dalla dottrina ufficiale e un’enciclica ribadì che il cristianesimo era centrale per permettere la creazione di una società giusta. La ricerca storica moderna attribuisce buona parte di queste decisioni proprio ai condizionamenti della Curia.
L’enciclica, scritta dallo stesso Roncalli, con cui venne dichiarato l’inizio del Concilio fu quindi una sorpresa. Il punto fondamentale dell’enciclica fu la richiesta di non guardare più ai cambiamenti che stavano avvenendo nella società come “profeti di sventura”. Da allora cominciò per il Papa quello che lui stesso chiamò la sua “solitudine istituzionale”, nel senso cioè che il Papa operò senza l’appoggio della Curia, schierata su posizioni più conservatrici e intrasigenti delle sue.
«Nelle attuali condizioni della società umana essi non sono capaci di vedere altro che rovine e guai; vanno dicendo che i nostri tempi, se si confrontano con i secoli passati, risultano del tutto peggiori (…) A noi sembra di dover risolutamente dissentire da codesti profeti di sventura, che annunziano sempre il peggio, quasi incombesse la fine del mondo»
Il Concilio cominciò a Roma l’11 ottobre del 1962 e si svolse nei tre anni successivi in quattro diverse sessioni. Tra vescovi, patriarchi, abati e dirigenti dei vari ordini furono in più di 2000 a partecipare. Per la prima volta nella storia gli europei erano in minoranza e costituivano solo il 33% dei delegati convenuti. Sempre per la prima volta, i progressisti erano in maggioranza sugli intransigenti e questo emerse chiaramente nelle decisioni prese dal Concilio.
Le conclusioni
Nella sua vita di tutti i giorni il Concilio operò quasi come un parlamento, con commissioni che lavoravano su argomenti specifici per preparare dei testi che poi avrebbero dovuto essere sottoposti al voto dell’assemblea. Dall’esterno del Concilio arrivava la pressione dei media, mentre al suo interno erano al lavoro le varie correnti. C’erano gli intransigenti, divisi tra chi era più o meno tradizionalista e il vero partito della Curia. Tra i progressisti i più attivi erano i delegati francesi e tedeschi, il movimento ecumenico, che chiedeva un’apertura nei confronti delle altre chiese, il movimento biblico, che chiedeva una maggiore libertà nello studio della Bibbia e il movimento liturgico, che chiedeva una riforma della liturgia, rimasta ancora alle regole del Concilio di Trento di metà ‘500.
Le più visibili e simboliche decisioni del Concilio furono proprio quelle liturgiche – come molte altre decisioni del Concilio furono più che altro “indirizzi”, elaborati poi da altri documenti successivi. Il Concilio decretò la partecipazione attiva dei fedeli alla messa, consentì che venisse recitata nelle lingue volgari e che il prete officiasse rivolto verso i fedeli. Le messe cantate con la chitarra e con interventi dei fedeli nascono con queste decisioni del Concilio.
Fu molto simbolica anche la riforma della Curia, con cui si decise di cambiare il nome del Sant’Uffizio, l’ufficio vaticano che dopo il Concilio di Trento aveva preso il posto della Santa Inquisizione e che aveva decretato il rogo di Giordano Bruno e il processo a Galileo. Il Sant’Uffizio divenne la Congregazione per la Dottrina della Fede.
Ci furono anche importantissimi cambiamenti dottrinali. Dal Concilio Vaticano II emerse l’idea che la “parola di Dio” era stata “comunicata nella storia” e quindi poteva essere compresa solo tenendo conto del contesto storico. Questa affermazione metteva definitivamente fine all’interpretazione letterale e atemporale dei testi sacri e apriva all’idea che la Chiesa dovesse, in qualche modo, adattarsi ai tempi.
In altri documenti la Chiesa cattolica apriva alle altre chiese cristiane, riconoscendo che c’era un po’ di verità anche in loro e che c’erano valori positivi e morali persino nelle chiese non cristiane. In un altro documento il Concilio accettava per la prima volta l’idea della libertà religiosa, riconoscendo che il perseguimento della verità – cioè credere nel Dio cattolico – non poteva essere imposto per legge.
Le conseguenze
Molte delle aperture del Concilio Vaticano II si vedono ancora oggi. I preti vestiti “in borghese”, la partecipazione alla vita politica da fronti più progressisti e di sinistra, l’ecumenismo e l’avvicinamento alle altre religioni, sono elementi figli in qualche modo del Concilio.
Questa secolarizzazione fu da molti considerata eccessiva e portò all’allontanamento dalla Chiesa di molte correnti. La più famosa è quella dei cosiddetti cattolici tradizionalisti o lefevriani. Prendono il nome da Marcel Lefebvre, un arcivescovo francese che si rifiutò di insegnare nel suo seminario le novità introdotte dal Concilio. Lefebvre grazie alle sue tesi intransigenti raccolse moltissimi fedeli e nel 1988 arrivò alla rottura con la Chiesa venendo scomunicato.
Ci sono molti altri tradizionalisti meno conosciuti, come ad esempio i sedevacantisti che credono che dal Concilio Vaticano II ad oggi non ci siano più stati Papi legittimi e quindi la sede papale sia vacante: da quelli che sostengono che Giovanni XXIII fosse un eretico a quelli che ritengono il Concilio un complotto dei nemici della Chiesa – in genere massoni od ebrei.
Un’altra conseguenza attribuita anche al Concilio fu la “crisi delle vocazioni”. In altre parole dagli anni ’70 ad oggi sempre meno persone si sono fatte avanti per diventare preti, suore e monaci. Secondo alcuni ricercatori la causa di questo fenomeno è che prima del Vaticano II la Chiesa insegnava al clero l’idea che essi avevano uno stato di “santità” superiore alle persone comuni – parlavano una lingua conosciuta solo da loro, non guardavano in faccia i loro fedeli. Con il Concilio Vaticano II divennero persone come tutte le altre, ma senza perdere il fardello del celibato e l’obbedienza alle alte gerarchie. Secondo questi ricercatori diventare sacerdoti divenne meno attraente.
Le interpretazioni
Il Concilio fu portato a termine da Papa Paolo VI che intervenne molto più del suo predecessore nei lavori conciliari e ribadì, anche dopo la fine del Concilio, il suo divieto a cambiare alcune regole che alcuni progressisti sembravano pronti a cancellare, come il celibato per i preti, il divieto per la contraccezione e la negazione di un ruolo attivo per i divorziati nella Chiesa.
Secondo molti storici il “riflusso” intransigente introdotto da Paolo VI è la chiave di lettura per comprendere la storia della Chiesa nei decenni successivi. Secondo questa visione il Concilio Vaticano II produsse una reazione da parte di tutti gli ambienti più conservatori. Proprio a partire dalla fine del Concilio acquistarono sempre più importanza i movimenti laicali e secolari di natura carismatica come l’Opus Dei, Comunione e Liberazione e i neocatecumenali. Questi movimenti hanno sempre avuto qualche difficoltà a riconoscere le conclusioni del Vaticano II – l’Opus Dei ad esempio ha continuato a celebrare le sue messe in latino, secondo la liturgia pre-Concilio.
Secondo alcuni il successo di questi movimenti è proprio dovuto al fatto che trascurano in parte, se non del tutto, alcune conclusioni del Concilio. All’interno dei movimenti carismatici sacerdoti e fedeli hanno ancora un ruolo “speciale” rispetto al resto del mondo. Nell’Opus Dei e nei Legionari di Cristo è molto sottolineata la convinzione di appartenere a un’elité della Chiesa cattolica. Sempre secondo alcuni storici del cristianesimo, questo rende più accettabili i sacrifici che comporta il sacerdozio – ma anche l’appartenenza stessa a quei movimenti che spesso costa sia in termini di tempo che di denaro – proprio in cambio di uno “status” speciale, di un sentimento di elezione.
Secondo molti anche l’azione dei Papi dopo il Concilio è stata mirata a contenere alcune conclusioni del Vaticano II. Papa Giovanni Paolo II fu un grande oppositore della cosiddetta “teologia della liberazione”, un movimento di sacerdoti che si sviluppò in Sudamerica in seguito al Concilio. Accusata di essere vicina al socialismo e di rischiare di creare una frattura tra una Chiesa dei poveri e una Chiesa dei ricchi, la teologia della liberazione fu emarginata e i suoi esponenti colpiti da sanzioni disciplinari. Giovanni Paolo II nominò anche diversi santi e beati tra i cattolici tradizionalisti e intransigenti, come i martiri della Guerra civile spagnola. Soprattutto a causa della crisi delle vocazioni, Giovanni Paolo II si appoggiò a quei movimenti carismatici che sembravano immuni dalla crisi. Fu lui a concedere all’Opus Dei lo status di prelatura personale – che significa in sostanza che l’Opus Dei non è sottoposto alla giurisdizione dei vari vescovi, ma risponde direttamente al Papa.
Oggi
Anche Benedetto XVI – che al Concilio Vaticano II partecipò trentacinquenne – è considerato molto vicino ai movimenti carismatici. E sempre Benedetto XVI ha ricomposto lo scisma con i lefevriani, ritirando la scomunica. Un gesto considerato da molti come il tramonto dello spirito conciliare. Un’altra visione del Concilio, radicalmente diversa, punta invece a sottolineare la visione “pastorale” del Concilio. In altre parole, il Vaticano II non riscrisse i dogmi fondamentali della Chiesa, creando una netta separazione con il passato, ma fornì alla Chiesa una serie nuova di indirizzi che potevano essere applicati in vari modi secondo le circostanze dettate dai tempi e dai luoghi. In questo senso il Concilio non rappresenta una rottura, o un cambiamento rispetto al passato, ma ha piuttosto fornito gli strumenti per il cambiamento: la Chiesa non ha cambiato la sua definizione, ma ha solo aggiornato ai tempi moderni il metodo con cui diffonde il suo messaggio. Modi che, se i tempi cambiassero ancora, potrebbero mutare di conseguenza.
Foto: Keystone/Getty Images