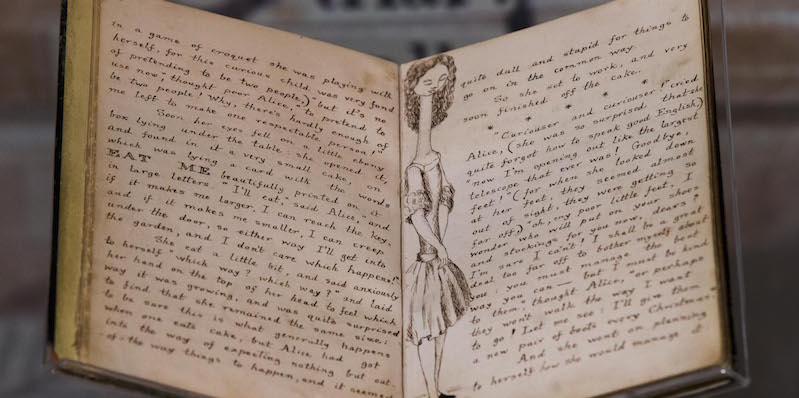Come sarà la pace fra Israele e Palestina
È da tempo che si sa quali saranno i termini della pace, che la facciano domani o fra cinquant'anni
di Giovanni Fontana

Il 2 settembre riprenderanno i colloqui diretti fra israeliani e palestinesi per provare a trovare un accordo di pace. Ci sono mille ragioni per essere scettici sulle reali possibilità di arrivare a una soluzione: in Israele è al potere il governo più a destra della propria storia, e la Palestina è divisa a metà fra Gaza, in mano a Hamas, e Cisgiordania in mano a Fatah.
Questi due fattori, però, potrebbero non essere totalmente compromettenti: è vero che Netanyahu è profondamente di destra, e guida una coalizione ancora meno disposta al dialogo di lui, però non bisogna dimenticare che spesso nel conflitto mediorientale sono stati gli uomini di destra – come Menachem Begin con l’Egitto o Ariel Sharon a Gaza – a potersi permettere le maggiori concessioni. In inglese c’è un’espressione precisa, Nixon goes to China: chi non può essere accusato di connivenza con il nemico evita le delegittimazioni del proprio schieramento, il primo ostacolo in processi del genere.
Anche la netta cesura fra Gaza e Cisgiordania potrebbe non andare così a detrimento del processo di pace: in Cisgiordania Hamas ha sempre meno séguito, anche a causa dell’embargo che ha subito da parte della comunità internazionale quando era al governo, con la conseguente impossibilità di pagare gli stipendi ai dipendenti pubblici. Un accordo di pace siglato dalla Cisgiordania sotto alla bandiera palestinese potrebbe costringere la leadership a Gaza a seguire Fatah ad accordo già fatto, biasimando il partito di Abu Mazen delle eventuali concessioni fatte.
C’è però un problema più grande: nell’ultimo decennio israeliani e palestinesi hanno dimostrato di non volerla, la pace. Come si può vedere, l’unica maniera per provare a ragionare obiettivamente di questo tema è con uno smaccato cinismo: sia a livello di leadership politica, che a livello di opinione pubblica, l’interesse per la pace – almeno da otto anni a questa parte – è proclamato (ogni tanto) a parole, senza che segua però nessun fatto concreto. È probabile che, nel corso dei prossimi mesi, Netanyahu dica che il processo di pace da parte israeliana è vincolato all’interruzione di qualunque atto terroristico, e che Hamas colga la palla al balzo per ricominciare il lancio di Kassam da Gaza, così da minare le trattative per chissà quanti altri anni.
Il problema riguarda certamente le leadership politiche di entrambi gli schieramenti, che traggono legittimità dalla perpetuazione del conflitto, ma – purtroppo – coinvolge anche l’opinione pubblica, sia in Israele che in Palestina: ed è per questo che chiunque passi del tempo in quelle aree ne ritorna pregno di sfiducia. La società israeliana è sempre più abulica, e sempre più spostata a destra: in molti emigrano, e la forte immigrazione dall’ex-Unione Sovietica sommata all’altissimo tasso di natalità fra gli ebrei ortodossi contribuiscono al trend. In più la costruzione del Muro e la conseguente fine del terrorismo suicida ha allontanato l’impellenza di una trattativa.
Dall’altra parte c’è un’opinione pubblica ancora legatissima all’idea di un’unica Palestina su tutto il territorio mandatario originale, che si scontra con l’impossibilità – proprio fattuale – di liberarsi di Israele. Qualunque riferimento politico, o geografico, a una convivenza con lo Stato ebraico è considerato un tradimento verso il proprio popolo e i martiri che sono morti per combattere. Qualunque sondaggio d’opinione dimostra che una larghissima parte delle persone non sarebbe disposta ad accettare neanche una Palestina entro i territori del ’67, lo scenario più roseo vista la situazione attuale. In altre parole, da entrambe le parti tutti dicono di volere la pace, ma nessuno è disposto ad alcuna concessione per ottenerla. Che equivale a non volerla.
Il problema è che come sarà questa pace lo si sa da anni, forse decenni. Che la si voglia o no, che sia giusta o sbagliata, che faccia torto agli uni o agli altri. I termini dell’accordo sono noti a tutti, perché sono l’unica strada percorribile. Ciò non vuol dire che questa verrà percorsa – né tantomeno che verrà percorsa a breve – ma che se una pace ci sarà, questa ricalcherà con piccolissime modifiche quella che è stata più volte ipotizzata, portata avanti, e messa nel dimenticatoio.
Quante volte abbiamo sentito dire che la questione mediorientale è irrisolvibile perché entrambe le parti hanno ragione? L’osservazione è assieme banale e scorretta, perché trascura un fatto ovvio: dato quel presupposto, è vero allo stesso modo che entrambe le parti abbiano torto. Ribaltare il punto d’osservazione è importante, perché aiuta a capire l’obiettivo che bisogna prefiggersi: non stiamo cercando la pace giusta, quella non c’è; stiamo cercando la pace possibile, se c’è. Spesso ciò che funziona è più giusto di ciò che sarebbe giusto.
Perché lo Stato unico non può funzionare
Negli ambienti dell’intellighenzia palestinese, e anche fra alcuni ebrei israeliani, viene sempre più spesso menzionata l’idea dello Stato unico. Questa soluzione non può funzionare per una ragione semplice: Israele non l’accetterà mai. Il presupposto su cui, a torto o ragione, è fondato lo Stato d’Israele è che questo sia uno Stato Ebraico: la piena cittadinanza a tutti i palestinesi dei Territori – per non parlare dei profughi – garantirebbe nel giro di due generazioni la maggioranza assoluta ai palestinesi, scenario che Israele vuole a qualunque costo evitare.
In Israele c’è una vera e propria ossessione nei confronti della questione demografica – nell’ultimo libro di David Grossman l’arabo-israeliano Sami fa ironicamente cenno ai suoi tre figli come «tre questioni demografiche» – ed è per questo che Israele mantiene questo sistema a due marce in cui porta avanti un’occupazione militare della Cisgiordania senza mai potersene permettere l’annessione – a meno di deportazioni di massa che, naturalmente, non sono in discussione.
Due Stati
Due popoli, due Stati. Ripetuto migliaia di volte, e mille ancora. È ancora l’unica soluzione sul tavolo ed è ancora la posizione ufficiale – almeno a parole – di entrambe le parti oltre che di tutti i negoziatori che si sono succeduti nel provare a trovare un bandolo a questa matassa. Come sarebbero, però, questi due Stati? I punti cardinali di un accordo sono sostanzialmente immutati da vent’anni e l’impressione è che qualunque pace si faccia, domani o fra cinquant’anni, non varierà molto da queste linee:
– I confini
La storia in breve: Il riferimento da cui si parte sempre sono i cosiddetti confini del ’67, in realtà quelli venuti fuori da quella che per gli israeliani è la Guerra d’Indipendenza e per i palestinesi è la Nakba (la catastrofe), e cioè la linea d’armistizio del 1949, nota come Green Line. Vengono dunque riconosciute ad Israele – da tutti gli organi internazionali, fra cui l’ONU – le conquiste territoriali ottenute nel ’48 ma non quelle successive, in particolare quelle della Guerra dei Sei Giorni quando Israele occupò – ma senza annettere formalmente – il Sinai e la Striscia di Gaza a sud, l’attuale Cisgiordania a est, e le alture del Golan a nord est. Fu perciò in quel momento storico che Israele si trasformò in una forza occupante a tutti gli effetti.
L’ONU, nelle risoluzioni 242 e 338 del Consiglio di Sicurezza, non ha mai riconosciuto agli israeliani alcuna annessione territoriale ottenuta nelle guerre del ’67 e del ’73 (chiamata dello Yom Kippur), e per questo in Israele c’è un latente sentimento di “vittoria mutilata”. Israele ha cominciato a costruire in Cisgiordania e a Gaza un numero sempre maggiore di insediamenti con l’obiettivo di strappare chilometri quadrati nella, e alla, pace che verrà.
Nel trattato di pace con l’Egitto, Israele ha restituito tutto il Sinai; ma il successivo accordo basato soltanto sul riconoscimento reciproco fra Israele e Giordania – che fra il ’49 e il ’67 aveva sostanzialmente annesso l’area a ovest del Giordano – è sembrato legittimare le aspirazioni israeliane in Cisgiordania. Nel 2005 Israele si è ritirato da Gaza lasciando aperta soltanto la questione della Cisgiordania, che è però sostanziosa: a oggi 300 mila coloni vivono oltre la Green Line in insediamenti illegali, e la popolazione continua ad aumentare. Inoltre la costruzione del Muro ha costituito una barriera almeno psicologica per un nuovo confine visto che, nonostante le dichiarazioni israeliane, in diversi punti oltrepassa il confine del ’67.
La pace possibile: la politica di Israele, almeno in parte, ha funzionato. Gli insediamenti più grandi, come Modi’in Illit e Ma’ale Adummim, non saranno mai smantellati. Discorso abbastanza simile per quelli nei pressi del confine. Nondimeno Israele dovrà concedere qualcosa meno del 90 per cento dei Territori Occupati, l’interezza di Gaza, e un piccola porzione di territorio israeliano. La mappa ricalcherà la proposta di Camp David, con qualche modifica a danno dei palestinesi. Il ragionamento è cinico ma veritiero: la soppressione della Seconda Intifada, con la costruzione del Muro e la fine del terrorismo suicida, ha tolto ai palestinesi molto del proprio potere contrattuale.
– Gerusalemme
La storia in breve: nella risoluzione 181 delle Nazione Unite, che prevedeva la spartizione fra Israele e Palestina nel 1947, Gerusalemme era considerata città sotto giurisdizione internazionale, anche se completamente all’interno del territorio palestinese. In conseguenza della guerra mossa dalle forze arabe, però, gli israeliani arrivarono a conquistare la fascia di terra che collegava i propri territori a Gerusalemme e ad annettere la parte occidentale della città. D’altra parte la Giordania, che aveva superato il Giordano per invadere Israele, si stanziò nella Cisgiordania e nella parte orientale di Gerusalemme.
Con l’invasione del ’67 Israele conquistò anche la parte orientale della città e tredici anni dopo la dichiarò parte della capitale, “unica e indivisibile”, dello Stato d’Israele. Questa proclamazione unilaterale non è riconosciuta a livello internazionale, e – per questo – tutti gli Stati che riconoscono Israele hanno la propria ambasciata a Tel Aviv, mantenendo a Gerusalemme Est il consolato che fa riferimento all’Autorità Nazionale Palestinese.
Gli israeliani – o, per meglio dire, molti ebrei-israeliani – non vogliono dividere la propria città santa, e a loro difesa dicono che Israele è l’unico Stato a maggioranza ebraica al mondo, mentre cristiani e mussulmani hanno moltissimi altri Stati. Da tempo Israele porta avanti una politica di ebraizzazione della città con legislazioni opinabili, e attuate su base etnica, che prevedono la sottrazione della cittadinanza per gli arabi – ma non per gli ebrei – che non risiedano stabilmente nella città: questo, assieme alla diversa attenzione alle infrastrutture, ha portato la più nota organizzazione israeliana per i diritti umani, B’Tselem, a definire questa come la “Politica delle espulsioni silenziose”.
La pace possibile: per quanto le pressioni israeliane cerchino di spingere in questa direzione, l’Autorità Nazionale Palestinese non accetterà mai uno Stato che non abbia Gerusalemme per capitale. L’opera di ebraizzazione della città è però in corso, e tutti i leader israeliani fanno a gara per parlare dell’indivisibilità di Gerusalemme. Si troverà una soluzione mediana che permetta di salvare la faccia di entrambe le leadership: probabilmente sarà istituita una capitale nella periferia della parte orientale, che permetta ai palestinesi di chiamarla al Quds, la Santa in arabo. Allo Stato palestinese sarà assegnata la giurisdizione sulla superficie della Spianata delle Moschee – ma non ai sotterranei – e la parte araba della Città Vecchia.
– I profughi
La storia in breve: la questione dei profughi è molto controversa, specie per quanto riguarda le ragioni dell’esodo: qualcuno parla di fuga, altri di arruolamento, altri ancora di espulsione. Riepilogando: all’indomani della dichiarazione d’indipendenza d’Israele (nel ’67, poi, ci fu una seconda ondata dello stesso fenomeno), gli Stati arabi dichiararono guerra allo Stato ebraico. I capi religiosi e militari arabi, incitarono mussulmani e palestinesi a venire via da Israele. Alcuni seguirono questi proclami, molti altri furono cacciati dagli israeliani con questo alibi, spesso mascherandolo come una necessaria azione di guerra. L’obiettivo era quello di ebraizzare la parte maggiore possibile di Israele: dopo l’evacuazione di interi villaggi, fu messa in atto una vera e propria “normalizzazione” – case nuove, onomastica nuova, etc.
Ovviamente, come in tanti altri casi, ognuno riconosce solo la parte di storia che fa tornare i propri conti: non si parla di dichiarazione di guerra o della “chiamata alle armi” fra i palestinesi, e non si parla delle espulsioni – se non, molto timidamente, negli ultimi vent’anni, per mezzo dei cosiddetti “nuovi storici” – in Israele. I 700.000 profughi palestinesi del tempo si dispersero fra Palestina, Giordania, Libano, Siria e (in misura minore) altri Stati arabi. Ma, invece di ottenere la cittadinanza lì, conservano questo particolare status, tramandandolo a tutta la progenie. A complicare la questione è l’occupazione (fino al ’67) da parte giordana dell’attuale Cisgiordania, cosicché la maggior parte degli attuali profughi ha un documento giordano. Nel frattempo tutti, Giordania, Libano, anche Israele, hanno cercato di strumentalizzare questa bomba demografica, innescandola come risultato.
Le persone che dispongono ora dello status di profugo sono 4 milioni, pochissimi dei quali sono mai stati in Palestina: molti di questi, però, conservano la vecchia chiave di casa ereditata dal papà o dal nonno. I palestinesi rivendicano il diritto di tutti i profughi a tornare in Israele e Palestina, gli israeliani obiettano che contestualmente alla dichiarazione di guerra del ’48 gli Stati arabi espulsero 600 mila ebrei che fuggirono in Israele e furono lì naturalizzati: nessuno di questi rivendica il diritto di tornare in Algeria o Iraq. L’obiezione è solo parzialmente valida, perché non è delle colpe algerine o irachene che deve rispondere il venturo Stato palestinese.
La pace possibile: l’ereditarietà della condizione di profugo – addirittura a chi ha soltanto un genitore con lo status – è effettivamente un’enorme anomalia, ma è vero che Israele non ha soltanto impedito l’immigrazione all’interno dei propri confini, ma anche quella in Palestina. Il compromesso sarà che 150 mila persone, dilazionate in dieci o quindi anni, rientreranno in Israele. Agli altri sarà permesso di immigrare in Palestina – probabilmente non tutti assieme – e riceveranno un condono economico (pagato da Israele e dalla comunità internazionale) per l’abitazione distrutta, con cui poter acquistare una nuova casa a Ramallah, Gerico o dove abitano ora.
– Le questioni minori
Ci sono diverse altre questioni in ballo, la maggior parte di queste riguarda la sicurezza israeliana, e c’è la faccenda delle risorse idriche. Per quanto spesso i negoziati si siano impantanati nella risoluzione di queste controversie, la verità è che le obiezioni sollevate sono sempre state pretestuose. Il vantaggio nella trattativa su queste faccende è che non sono temi sensibili per le varie opinioni pubbliche: se è vero che, specie fra colonie e Autorità Palestinese, c’è stata una lotta per l’approvvigionamento dell’acqua, è vero che un accordo che possa mettere d’accordo tutti non dovrebbe essere difficile da trovare, perché è difficilmente impugnabile come tradimento dagli estremisti.
Lo Stato palestinese sarà demilitarizzato, almeno per una cinquantina d’anni, e Israele conserverà qualche avamposto sul territorio senza però il diritto di interrompere la circolazione, come avviene oggi con i check-point. Sarà garantito ai palestinesi il proprio spazio aereo civile, con la possibilità per gli israeliani di sorvolare il Paese. I palestinesi erediteranno tutte le infrastrutture costruite dagli israeliani in questi anni per le colonie senza dover versare un indennizzo, e rimarrà necessariamente una piccola minoranza di ebrei nel futuro Stato palestinese, se – come probabile – alcuni coloni rinunceranno a lasciare luoghi religiosamente simbolici come Hebron. Quando sarà normalizzata anche la situazione con Gaza sarà costruito un passante di sicurezza da Beit Hanoun alla parte sudoccidentale della Palestina gestito dalle forze di sicurezza palestinesi, vigilato esternamente dagli israeliani.
Bene, è fatta allora!
No. La pace si farà quando ci sarà la volontà, vera, di entrambe le parti. Considerazione che potrebbe equivalere a rispondere “mai”. Delle volte l’impressione è che l’unico modo per fare sì che Israele e Palestina convergano sull’unica soluzione disponibile è che questa sia imposta dall’alto, cosa anche questa che non potrà mai succedere. Sicuramente, però, ci sarà bisogno di fortissime pressioni da parte degli Stati Uniti e di tutta la comunità internazionale.
Quello che sappiamo noi, su quale sia l’unica via percorribile per la pace, lo sanno anche le leadership politiche di Israele e Palestina e questo dovrebbe responsabilizzarle a cercare di accompagnare la propria opinione pubblica a comprendere la necessità delle concessioni. Negli ultimi anni è successo l’esatto opposto: i leader hanno conquistato la fiducia e il consenso delle persone sulla base dell’intransigenza, e convincerle ora della bontà di un accordo diventa sempre più difficile. Bisognerà vedere quanto nel prossimo futuro israeliani e i palestinesi saranno disposti a investire non solo nella propria immagine, ma anche in quella dei propri nemici. Ed è in questo margine che si deciderà se la pace si farà domani o fra cinquant’anni.