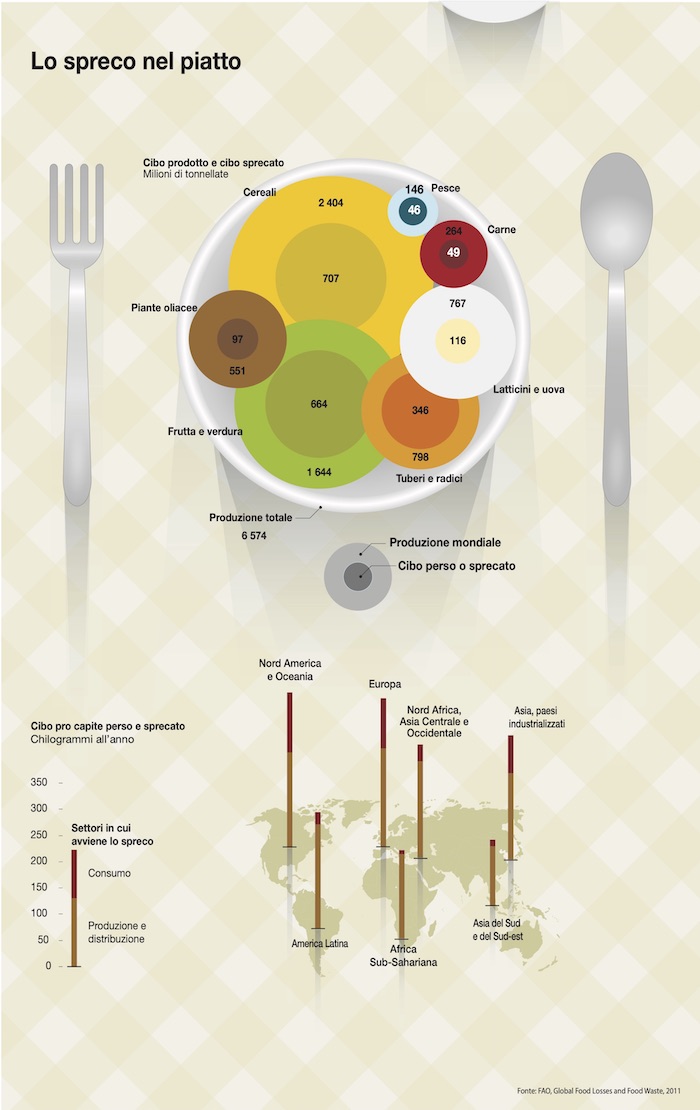Menu alla carta
Dieci anni e qualche mese fa mi ritrovai a dover preparare una presentazione convincente per un colloquio per un posto di lavoro che tutto sommato non volevo veramente ma che sarebbe stato sciocco rifiutare o non provare nemmeno a ottenere. La presentazione si sarebbe svolta durante il pranzo che ogni settimana l’organizzazione internazionale che mi aveva chiamato offriva ai suoi collaboratori. Serviva quindi qualcosa di abbastanza leggero da essere digerito anche durante quello che immaginavo essere un pranzo tra gente che lavora assieme e che quindi passa insieme molto del proprio tempo. Un po’ rumoroso, i commensali un po’ distratti, mi passi il sale per favore? Quello che feci abbastanza d’istinto, galeotta l’occasione, fu di mettere insieme due cose per me fondamentali. La cartografia e la cucina.

La cartografia tematica contemporanea che ammicca e fa allo stesso tempo gola all’information design ha dei notevoli tratti comuni con la cucina. Una mappa cosi come la vediamo è il risultato finale di un lungo processo che sintetizza e rende visibile grazie a delle tecniche appropriate una serie di elementi filtrati dalla mano di chi li compone per ottenere un prodotto coerente e soddisfacente per chi ne fruisce. Sostituite alla parola “mappa” nella frase precedente la parola “piatto” e accordate di conseguenza, la frase vi torna ancora? I punti in comune tra cartografia e cucina sono moltissimi, tanti quante le differenze, e sono forse evidenti solo a chi si occupa di una o dell’altra cosa. A un certo punto a me sarebbe piaciuto indifferentemente occuparmi dell’una o dell’altra cosa, ha prevalso la prima ma l’altra rimane sempre in agguato. E visto che in Italia tutti abbiamo un’opinione sulla cucina ma che in fatto di cartografia tematica siamo un po’ asciutti, provo a parlarne.
Per far la carta, oltre al legno, servono una serie di elementi necessari alla sua produzione: una o una serie di informazioni, degli strumenti per elaborarla, degli strumenti per renderla comprensibile a chi magari non ha una formazione specifica riguardo all’argomento trattato, degli strumenti per rendere questa informazione appetibile e faccia venire voglia di assimilarla a chi se ne imbatte. E qualcuno che abbia l’interesse, la capacità e l’intuizione di utilizzare quell’informazione per produrci una carta. L’informazione è l’ingrediente principale, che viene sottoposto a dei trattamenti più o meno lunghi e più o meno laboriosi a seconda del tipo di ingrediente e di cosa se ne vuole fare. Se volete è il grano necessario a fare un piatto di pasta, operazione in se relativamente semplice se non consideriamo tutti i procedimenti necessari a coltivarlo e a trasformarlo. Una volta ottenuta una forma consona (la pasta dalla lavorazione del grano) occorre organizzare quell’informazione in modo da essere fruibile per la maggior parte delle persone a cui ci vogliamo rivolgere, rendere cioè inizialmente commestibile un elemento che senza questo procedimento rimarrebbe difficile da gestire. Bisogna insomma cuocere quell’informazione fino a ottenere un composto che abbia un senso compiuto. Nel caso specifico della cartografia questo significa per esempio riassumere migliaia di dati climatici relativi alla temperatura per mostrare su una carta come si è evoluta la temperatura media giornaliera nel mondo per una determinata stagione.
La parte per me interessante inizia qui, nel punto in cui qualità della materia prima – l’informazione – e le tecniche da utilizzare si fondono con la capacità, la sensibilità e l’esperienza di chi deve servire la carta in tavola. Ci sono due cose da considerare: l’unicità del risultato, secondo cui partendo da ingredienti uguali si ottengono risultati estremamente diversi, e l’aspetto puramente estetico (che non è mai puramente estetico, se non altro in cartografia). Del secondo aspetto ne hanno parlato tra gli altri Roland Barthes, Marshall Mcluhan e Edward Tufte, tutti in modo e in contesti diversi. In quanto prodotto che veicola un’informazione, la carta ha un contenuto e una forma, ed entrambi questi elementi hanno dei livelli diversi di qualità. Possiamo avere una carta splendida che mostra un’informazione banale, povera, addirittura fasulla, o al contrario una carta con un’informazione molto accurata e unica nel suo genere ma una forma talmente ostica da rendere il suo contenuto inutile, perché pochi saranno interessati o in grado di leggerla e comprenderla. Una carta che non tiene conto di questo aspetto tradisce e quindi rende inutile il suo contenuto. La forma è il contenuto. Lo stesso fa, soprattutto oggi in cui siamo tutti critici gastronomici su Instagram, un piatto che magari utilizza ingredienti fantastici ma che è cucinato maluccio e soprattutto non ci eccita le ghiandole salivari quando ce lo servono. Passa tutto prima dall’occhio, in cartografia come a tavola. Quando finalmente l’occhio ha avuto la sua parte non c’è la bocca ma c’è l’orecchio. Il titolo di una carta ci dice di cosa stiamo parlando, ci anticipa cosa andremo a scoprire, ci fornisce il contesto e ci incuriosisce. Allo stesso modo un piatto che ci viene servito, a casa o fuori, suscita in noi delle attese in base a come ce lo introducono, a come ci dicono che si chiama, a cosa ci dicono che contiene, di quali ingredienti ci dicono che è composto.

(La mappa è realizzata insieme a LeMonde)
L’aspetto di un piatto o di una mappa ne determinano spesso il contenuto, la “composizione” di cui si sente sempre di più parlare con il diffondersi di trasmissioni televisive culinarie, è lo stesso procedimento in cucina e in cartografia, identico proprio. Non si tratta solo di eleganza o di smancerie in piatti pretenziosi, anche quelli più ruspanti devono seguire dei loro codici estetici e di equilibrio visivo oltre che di gusto. Questo ci porta all’altro elemento di cui si parlava poco prima, l’unicità del risultato a parità di ingredienti di partenza, di materiali e di tecniche. In cartografia come in cucina due professionisti (che non lavorano insieme e che quindi non hanno come obiettivo la riproducibilità) produrranno due risultati diversi. Se per parlare di forma e sostanza abbiamo strapazzato Barthes, per parlare di unicità o se volete di stile, di firma o signature dish scomodiamo mia nonna Maria e prendiamo come archetipo il suo “agnello imbattibile”. È questo secondo me il punto in cui la tecnica cartografica incontra l’arte, qualsiasi cosa questi due concetti significhino per ognuno di noi.
Si chiama imbattibile perché ne io ne mio padre ne altri parenti siamo mai riusciti a produrre una versione che ci si avvicinasse anche lontanamente. I nostri agnelli erano solo buoni, il suo era supremo. Prima che la Maria morisse, ricordo che dissi a mio fratello, dopo un pranzo da lei di quelli che poi non riesci nemmeno a guidare tanto che sei satollo “impara prima che sia troppo tardi, tu che abiti di fianco”. Non ci fu il tempo e il modo, e l’agnello imbattibile finì con l’ultima depositaria dei suoi segreti.
Ora, secondo me possiamo dire che quel piatto era oggettivamente e soggettivamente buono. Dove per oggettivo non si intente universale ma il fatto che chiunque lo abbia mangiato l’abbia ritenuto un agnello grandioso (anche se non toglieva i peccati del mondo, semmai ne promuoveva alcuni), e per soggettivo il fatto che oltre alla sua qualità intrinseca rimandava me e la mia famiglia a una serie di emozioni personali. L’agnello imbattibile era il risultato spontaneo dei circa 55-60 anni in cui mia nonna lo ha cucinato. Lo avrà cucinato migliaia di volte, e quasi tutte le volte rispettando quella che secondo lei era la “maniera”, il modo di farlo, che era suo e che derivava non da una ricetta ma da chissà quale parente che glielo aveva insegnato. La sua “maniera” era una serie di procedimenti che la nonna mi ha spiegato tante volte. Io ero troppo distratto o troppo comodo – che tanto lo fai tu – ma soprattutto troppo scettico.
L’agnello si faceva nel “tegamo” (era Lucana, la nonna), una teglia rettangolare di alluminio che va in forno, ma che lei utilizzava sui fornelli e che ricopriva con la carta d’alluminio a mo’ di coperchio. Si mettevano due tazzine d’olio, le patate le si tagliavano al coltello direttamente dentro, ci si metteva mezzo bicchiere d’acqua ma solo dopo che lo avevi guardato fisso nelle carni per mezzora, e il prezzemolo lo dovevi tagliare prima (o dopo?), poi ci dovevi mettere una “bella grattata di formaggio [pecorino]” e stare attento che “non prende troppo il bollo[re]”. Poi gli sollevi la carta, lo scopri mezzora prima, ma a volte anche no, – che io questi fornelli di tua mamma non li conosco. Morale, i passaggi li so tutti, i materiali ce li ho, la materia prima pure. Ma non viene come il suo. Mai. Quello che non so sono la serie di movimenti e attenzioni che io consideravo inutili perché li ritenevo alchimie che non influenzano il risultato, delle specie di gesti accessori inutili che si fanno giusto perché li hai sempre fatti.
Un cuoco professionista potrebbe arrivare a riprodurre il gusto di quell’agnello senza troppe storie suppongo, almeno la parte oggettiva di quel gusto. E lo farebbe probabilmente non nel “tegamo” e sicuramente senza la stessa cura e i gesti per me all’epoca inutili ma che nel sistema di valori della nonna -e finalmente nella riuscita del piatto imbattibile- erano essenziali. Quei gesti, quei passaggi unici sono simili a quelli che il cartografo compie per produrre la sua carta e che fanno in modo che la mano, lo stile, la firma sia riconoscibile e unica. Ci sono cartografe e cartografi oggi che producono mappe tematiche di una bellezza e profondità straordinarie, con tecnologie sofisticate o con il rilievo topografico fatto a matita, con pennello e acquerello o in bianco e nero, che appena si vede la mano la si riconosce. Come per l’agnello imbattibile, anche in cartografia ci sono dei procedimenti che si discostano dal dogma dei Sistemi Informativi Geografici, dalla cartografia quantitativa, dalla dittatura del “nord sempre in alto” o da quella della proiezione di Mercatore, per dirne solo alcuni (e senza per questo averne qualcosa contro). La diatriba sulla scientificità e accuratezza di una carta tematica prodotta a matita o con un acquerello è tanto sterile quanto quella sul vino biodinamico. Ma questa è una storia per un’altra volta
PS: Dieci anni fa la mia presentazione non creò particolare scandalo, i norvegesi sono gente mite. Ebbi il posto, probabilmente non grazie a né nonostante l’accostamento cartografia/cucina ma la cosa che ancora scuote la memoria era ciò che venne servito a pranzo in favore del fatto che l’ospite era italiano. Della pasta bollita molto a lungo e condita solamente con delle rondelle di porro, affettate grosse. Mi passi il sale per favore?