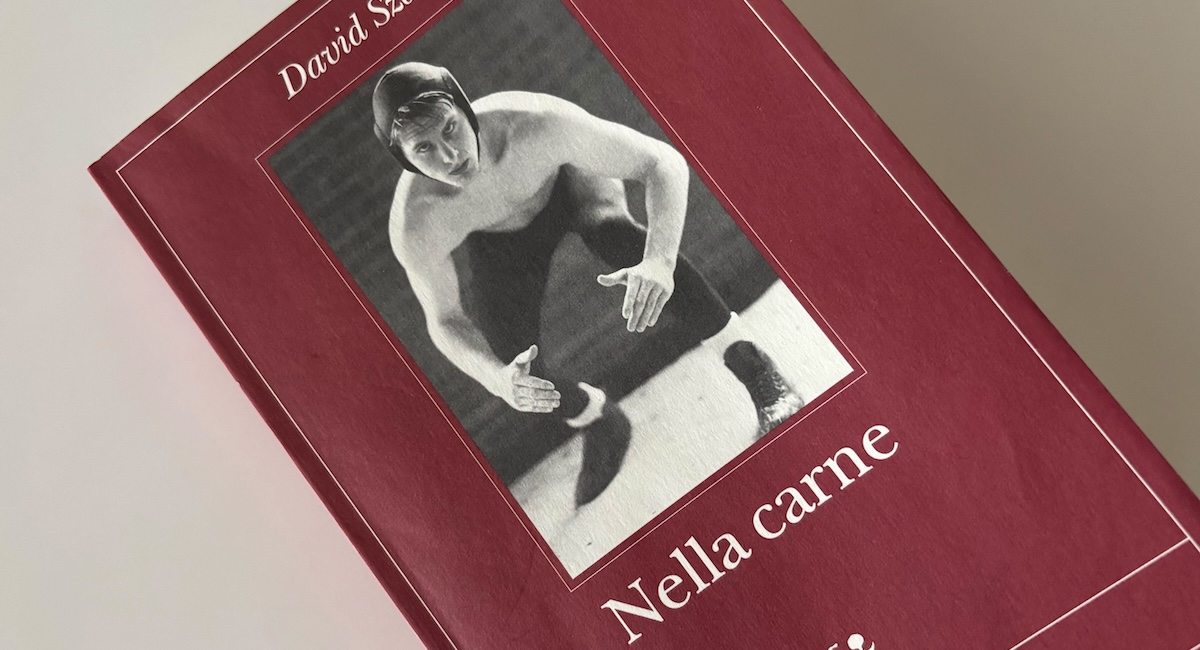Il senso del Tingo
Non credo esista in nessuna lingua una parola che indica “l’azione di parlare di un libro senza averlo letto”. E io in questo momento ne avrei un gran bisogno. Parlando con un’amica ho infatti scoperto che esiste un libro che si chiama “Il senso del tingo”, frutto della lunga ricerca di Adam Jacot de Boinod in giro per i vocabolari di tutto il mondo all’ossessiva ricerca di vocaboli . Ne è emerso un libro che non ho ancora letto e di cui sto parlando perché secondo me è uno dei più bei libri che non ho letto. Dalla presentazione di Amazon vedo che contiene per esempio “neko-neko”, una parola indonesiana per indicare “una persona che ha un’idea creativa che peggiora le cose” oppure il giapponese “koro,” usato per esprimere l’isterica convinzione che il proprio pene si stia accorciando nel corpo, o la bellissima parola Inuit “iktsuarpok,” che significa “ uscire fuori per vedere se qualcuno sta arrivando”. E c’è ovviamente anche “tingo”, un verbo usato nell’isola di Pasqua che indica “il prendere le cose in prestito, una alla volta, dalla casa di un amico finché non gli resta niente”. Ho anche trovato un tenerissimo elenco di parole che esprimono stati d’amore non presenti nella lingua inglese – e neanche in quella italiana- come il giapponese “Koi No Yokan”, cioè ciò che provi quando incontri una persona e hai la precisa sensazione che presto vi innamorerete. C’è anche l’indispensabile “cafunè”, che in Brasile indica l’atto di far scorrere con tenerezza le dita tra i capelli dell’amato. Le altre si trovano qui.
La tendenza a creare un linguaggio tribale in città è diffusa, una testimonianza lampante è il sito http://www.urbandictionary.com/ dove troviamo perle come “coffee face”, avere la faccia da caffè, cioè quel viso tumefatto che ci accompagna al mattino prima di bere il caffè o il fenomenale “E-void”, il verbo e-voidare, ovvero evitare qualcuno elettronicamente sui social media come Facebook o strumenti di comunicazione come mail e sms.
Quest’operazione d’indagine sul senso non è applicabile solo a esotiche parole di culture lontane. Cose strane con le parole succedono anche qua. Immagino che se l’autore del suddetto conoscesse i dialetti o i gerghi italiani scoprirebbe quanti sono gli “italiani” e quanti termini nascondono bizzarre intercapedini di senso. Un banale ma essenziale aggettivo come “bella”, che normalmente indica qualcosa attraente nell’aspetto e nella sostanza, è declinato spesso in giovine età come esclamazione generica ad esprimere uno o tutti dei seguenti stati d’animo o funzioni comunicative: “ciao”, oppure, “ riconosco in te uno che è come me”, oppure, “vedo che ce l’abbiamo fatta tutti e due a restare vivi finora nonostante la quantità di cazzate che riusciamo ad organizzare nel nostro inutile tempo libero”. In Italia ciò che avviene nel gergo giovanile si intensifica in combinazione con i dialetti regionali: mi spiegava un amico che l’adolescente della provincia romana usa con disinvoltura il termine “sgodo”. Sgodo indica una particolare circostanza in cui un gruppo di amici si trova a condurre un’attività che aggrada tutti tranne un soggetto. Quel soggetto che per qualche motivo personale non si sente coinvolto nell’attività del gruppo “sgode”.
Oppure un’amica genovese riportava un termine molto interessante nella sua qualità onomatopeica: “che pru!”. La suddetta esclamazione descrive “la reazione di sollievo di fronte a un’incombenza che viene inaspettatamente indirizzata su qualcun altro e non sulla propria persona oppure la felicità di aver scampato una malattia o un danno.
E non escludo che un giorno le circostanze e la modernità non ci portino a nuove frontiere di articolazione del senso: esisterà quella parola che indica l’ossessiva pulsione a controllare Gmail o la colonna centrale di Facebook ogni trenta secondi? Come si definirà l’azione di “controllare con un’applicazione dell’iphone quali persone sono compatibili con il mio profilo personale che posso conoscere nel raggio di due chilometri?”. Esisteranno emozioni che descrivono l’imbarazzo di quando si capisce dalle frasi di un conoscente che suddetto conoscente ha già studiato la nostra pagina Facebook? Si potrà dire una frase come: “mi sento googolato”? Saremo in grado di arginare quel fenomeno che trasforma delle applicazioni in verbi? Io ho ancora un po’ di pudore a dire “le ho fatto like” e ho visto che molti hanno cominciato a dire “le ho messo like”. Alcuni amici, persone sulla cui intelligenza non ho mai dubitato, usano con frequenza frasi come “l’ho whatsuppato”. Alcuni addirittura, ma parlo degli alieni nati negli anni Novanta, esclamano senza ritegno “che fail epico!”ad indicare situazioni di errore non rimediabile come per esempio un tatuaggio sgrammaticato o orrendo.
Con la lingua inglese si è ormai aperto l’argine e la nostra lingua accoglie sempre più piccoli colonizzatori semantici. Diversamente, oltre a pizza e Berlusconi poche parole invece fanno ingresso nel mondo anglofono e forse è anche un fenomeno comprensibile. Mi ricordo ancora quando tentai di spiegare a un’amica inglese il significato di “non ci sto dentro”. E non so per quale motivo, non riusciva a comprendere la mia meravigliosa traduzione: I don’t stay inside.
– Sarah Barberis – http://letimofuggente.blogspot.it/