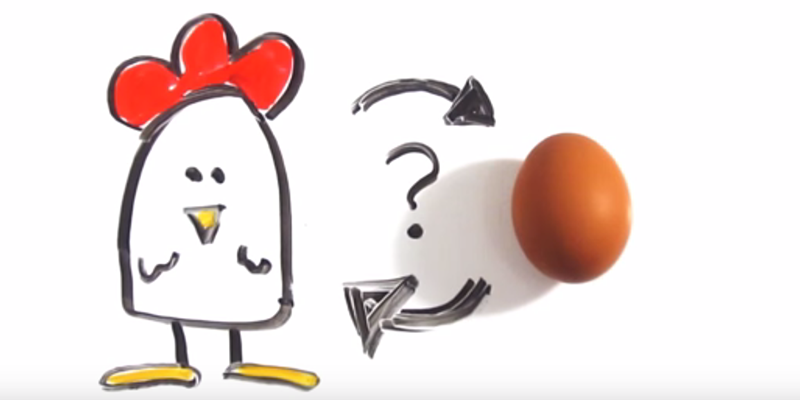Parasite
Non ci sono buoni o cattivi in “Parasite” di Bong Joon-ho. Ma ci sono gli ultimi e i disperati; ci sono quelli accecati dalla fame e quelli rintontiti dal benessere. C’è una famiglia che vive in uno scantinato, che ogni sera deve stare attenta a chiudere la finestra della cucina altrimenti rischia che qualche disgraziato ci pisci dentro. E poi c’è una famiglia che sta bene, che fa finta di avere dei problemi, che se li cerca, che se li crea, che è superficiale, felice, innocente, e che è, sopra ogni cosa, ricca. La casa in cui abita è la sintesi del successo e del benessere.
I due mondi, a tratti, si toccano. Perché la prima famiglia si infiltra nella seconda. I figli cambiano nome, lui si mette a insegnare inglese, e lei si mette a insegnare arte; i genitori si improvvisano autista e governante. Cacciano via i vecchi dipendenti, li spingono nel buio dei loro buchi, nei bassifondi, li distruggono, e per un po’, solo per un po’, sembrano stare bene. Sono felici. O almeno, ecco, pensano di essere felici. Perché finalmente mangiano, finalmente possono rilassarsi; finalmente non devono più arrangiarsi per racimolare qualche soldo, per rimanere a galla, per evitare che l’ennesimo cretino liberi la vescica sui loro calzini appesi ad asciugare. Addio casa-scantinato, pensano; e sorridono, ridono, si ubriacano, abbassano la guardia.
Sono arrivati nel Paradiso terrestre, dove non c’è più male; approfittano dei padroni che vanno in campeggio, e si trasferiscono per qualche giorno nella loro casa. Poi, però, succede qualcosa, e comincia una guerra tra poveri ferocissima, sanguinolenta, fisica, dolorosa, dove i problemi degli uni fanno a gara con i problemi degli altri, il gioco d’azzardo contro la fame, la fame contro la solitudine; e la famiglia di disperati diventa di disperatissimi, e la commedia si trasforma in tragedia.
Bong Joon-ho confeziona un film potente, fatto di immagini bellissime, che parla di tutto e di niente, che ci parla di noi, della nostra società, ma che si diverte anche nel prendere in giro i benestanti, i borghesi (come lui, del resto), facendoli apparire come dei bambini. Forse, sono gli effetti collaterali dei soldi. O, molto più probabilmente, è la differenza che c’è tra le due dimensioni, tra il bassissimo e l’altissimo, tra quelli che vivono con la fame, e quelli che la fame, semplicemente, non sanno più che cosa sia.
Siamo nella Corea del Sud, e va bene; si vede, si capisce, c’è un’altra mentalità, un’altra cultura. Bong Joon-ho non insiste, dove non serve. Dà un’idea, solo un’idea. Una percezione di quello che è (lui, il pater familias dei benestanti, è un dirigente: ma di cosa, o dove o come ci sia arrivato o se è da molto che occupa quella posizione non lo sappiamo); e di quello che potrebbe essere (lei, la figlia dei benestanti, si innamora di lui, figlio dei disperati, e potrebbero stare insieme, e vorrebbero stare insieme, ma lei è minorenne, lui povero e bugiardo, e tutto si perde). E questa percezione ci viene data non solo dalla regia, dallo studio dei luoghi e della loro architettura, della luce e – di nuovo – delle immagini. Ma anche dagli attori: dagli straordinari attori di cui Bong Joon-ho si è circondato.
Song Kang-ho, che interpreta il padre della famiglia dei disperati e che alla fine si lascia andare alla rabbia per chi è ricco, per chi tratta gli altri, i poveri, i più sfortunati, male, è l’essenza stessa del film; incarna quella disperazione, quella felicità infelice, quella soddisfazione momentanea che i disperati sembrano raggiungere a un certo punto. Nella sua espressione – che sfuma velocemente dall’ingenuo, dal rintontito, al presente, al feroce, al padre che soffre – passa l’intero “Parasite”.
E in questo film, poi, contano anche gli oggetti, la pietra che si passano di mano in mano, la pietra che, alla fine, diventa arma, e le case, soprattutto le case: lo scantinato sa di liberazione; e la villa, la reggia, diventa una prigione. Come una prigione, poi, lo diventa la ricchezza, mentre la povertà, a modo suo, diventa quasi una liberazione. Avere tanto non significa avere tutto, e sicuramente non significa essere felici. In una delle scene più belle, più concitate, quando il bassissimo e l’altissimo si mischiano, si capovolgono e finiscono per ribaltarsi, suona “In ginocchio da te” di Gianni Morandi, e “Parasite”, se possibile, guadagna ancora un’altra dimensione.
Si respira un po’ del neorealismo italiano; si respira un po’ di quel “Borghese piccolo piccolo” con Sordi; e si respira soprattutto la tragedia che c’è nella commedia della vita. E che film è questo. Passano gli anni, le stagioni, il caldo afoso viene scacciato via dal freddo glaciale, c’è un’inondazione, che lava via ogni cosa, e che prepara una ripartenza. Alcuni personaggi muoiono, altri scappano, altri ancora vanno in galera, e Bong Joon-ho riesce, così, a fotografare la vita. E non è solo la vita di ogni giorno, quella fatta di piccoli gesti e di piccoli momenti. Bong Joon-ho fotografa soprattutto la vita macroscopica di una società, piena di eccessi e di estremi, e la fotografa in tutta la sua fragilissima e patetica umanità. Siamo tutti scarafaggi: ricchi e poveri, benestanti e affamati; e siamo tutti a rischio, in frontiera, in prima linea, alla ricerca della felicità, o almeno: di qualcosa che le somigli abbastanza per smettere – anche se solo per un istante; anche se solo per il tempo di un ritornello di una canzone di Gianni Morandi – di pensare.