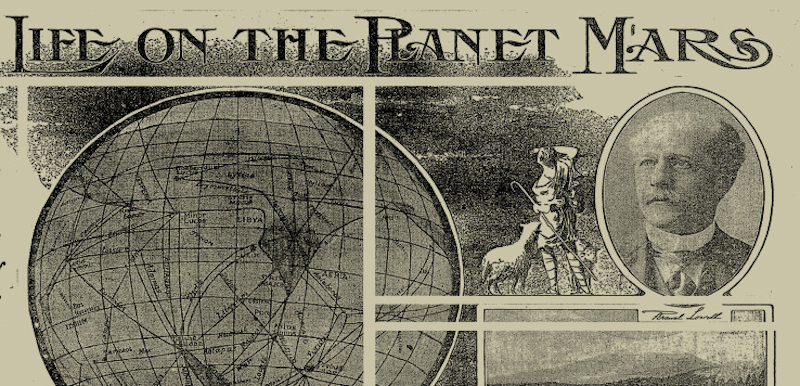Cos’è veramente la sostenibilità
Ciao, presentati
Sergio Saia, laureato in Scienze e Tecnologie Agrarie, ho un dottorato in Agro-Ecosistemi Mediterranei e nella mia formazione annovero anche un master su erosione del suolo e uno sulla spettrometria di massa (una raffinata tecnica analitica). Sono ricercatore presso il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria (CREA) e lavoro presso il Centro di Ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali (CREA-CI, Foggia), ma ho lavorato molto anche presso altri centri e sedi del CREA (a Monterotondo, Vercelli, Acireale e Bagheria) e diverse università.
Quali?
Pisa, dove attualmente insegno, Ancona e Palermo.
Insegni?
Agronomia e coltivazioni erbacee, ma ho insegnato anche Orticoltura. E non è mancata nemmeno l’attività di imprenditore agricolo e quella di dipendente presso aziende private. Ho vissuto in molti posti e viaggio molto (ahimè troppo). Per ricerca, mi occupo prevalentemente di colture erbacee e ortive, ma talvolta ho sconfinato nelle arboree e nella tecnologia alimentare. In particolare, studio aspetti di nutrizione vegetale e gestione del suolo, delle infestanti e dei patogeni che riducono la necessità di principi attivi e fertilizzanti di sintesi.
Allora, andiamo subito al punto, perché tutti i tuoi studi gravitano attorno a una parola: sostenibilità. Una parola molto usata. Tuttavia, a volte temo che sia un abuso. Per esempio, alcune grandi aziende non sanno bene come misurarla, non esiste un parametro fisso per tutti, insomma si naviga un po’ a vista. Dunque, la sostenibilità in agricoltura cos’è? C’è un metro per misurala?
Concordo, è spesso abusata. E anzi l’abuso del termine è in crescita. Esistono modi per misurare alcuni aspetti della sostenibilità. Alcuni di questi vengono misurati con molta precisione (ad esempio le voci di impatto ambientale del Life Cycle Assessment o della Water Footprint, perdona i termini).
A proposito, desideravo chiederti una cosa sulla Water Footprint, poi ci torniamo, ma dimmi…
Per altri la misura è più complessa, quali ad esempio gli aspetti economici o sociali a scala territoriale. Inoltre, tutte queste misure possono essere dirette, oppure stime con vari modelli più o meno buoni. Cosa di preciso sia in agricoltura la sostenibilità è difficile dire. Non voglio lanciarmi in dibattiti sugli aspetti economici e sociali, sebbene i primi a scala aziendale siano relativamente semplici.
Altri aspetti problematici?
Attualmente pur misurando la sostenibilità di un sistema (agricolo o meno), non ha grosso senso fornirla tal quale. L’unica cosa davvero interessante è fornire le differenze nelle stime per condizioni diverse in modo da poter scegliere.
Cioè?
Cioè non è facile dare un bollino di sostenibilità (di cui le tre componenti, voglio ricordarlo, sono gli impatti ambientali, economici e sociali) come se fosse l’asticella per entrare nei giochi del luna park: sotto non puoi, sopra sì. Non c’è un riferimento che valga per tutti i luoghi e contesti. Siccome gli indicatori sono molti, una condizione ne favorisce alcuni e sfavorisce altri e viceversa. Sta poi al dibattito politico concertare il giusto mezzo.
E per quanto riguarda l’aspetto ambientale?
Una delle definizioni che più preferisco è la seguente: la sostenibilità è la possibilità di produrre derrate, ma anche bioenergie, con un minor impatto per unità di prodotto ottenuto e salvaguardando due componenti ambientali di immane importanza: la superficie disponibile e la quantità di suolo per unità di superficie.
Quindi, volendo usare un’euristica, meno terra più unità di prodotto?
Beh, direi piuttosto: più prodotto in meno terra, invertendo i termini. In parole povere, oltre a impattare di meno per unità di prodotto, dobbiamo fare in modo da ottenere questo prodotto da meno superficie, in modo da lasciare più spazio per gli usi naturali e semi-naturali (es. boschi, pascoli, etc.) e mantenendo il terreno dove sta. Purtroppo, entrambi questi punti sono spesso ignorati sia dai tecnici del settore, sia dai cittadini.
Perché?
I primi spesso dimenticano che l’impatto per unità di superficie è una misura parziale: è necessario infatti considerare quanta superficie usiamo per ottenere una data quantità di prodotto, altrimenti rischiamo di mettere in coltivazione tutta la superficie, a danno dei boschi e quindi della biodiversità. Poi si dimentica che la produttività di una unità di superficie dipende da quanto suolo c’è (oltre che dalla sua tipologia e qualità) e che l’erosione porta via il suolo migliore, con più sostanza organica, attività microbica, nutrienti, etc.
E i cittadini?
Quando non traviati dalla disinformazione (e ce n’è tantissima) ignorano che l’impatto dell’agricoltura a scala territoriale non dipende solo dalla superficie agricola, ma anche dalla superficie non agricola che può mitigare gli impatti della prima.
Sento che questa cosa è importante…
A parità di produzione complessiva in due territori di pari dimensioni, generalmente c’è un minor impatto in quello che localizza la produzione in meno superficie, sebbene questa sia una indicazione che richiederebbe approfondite specificazioni su dove queste superfici sono localizzate. Qualcuno avrà bollato la risposta come un evasivo panegirico, ma è purtroppo tutto ciò che abbiamo in mano: ipotesi, confronti, misure, stime, incertezze e di nuovo ipotesi, in sintesi il lavoro della scienza prima di arrivare ai fatti.
Va bene, ma sull’impatto ambientale, non abbiamo parametri più concreti?
Sull’impatto ambientale dei prodotti agricoli posso darti qualche info in più: per convenzione viene diviso in sei fasi. Le prime due rappresentano la produzione dei mezzi tecnici e la produzione agricola in azienda, dalla terza alla quinta tutte le fasi di post-produzione (stoccaggio, trasporto, trasformazione e consumo) e la sesta lo smaltimento. Ebbene, dalle misure disponili, le prime due parti impattano molto più delle altre 4. Le voci di impatto sono diverse e riguardano l’emissione di gas a effetto serra, l’uso del suolo già citato, l’uso dell’acqua dolce (irrigua), di energia, il potenziale di cambio climatico, di eutrofizzazione delle acque dolci e salate, il rilascio di composti che possono causare malattie di vario tipo (cancro o altro, in genere). È un lavoro certosino.
A questo proposito, per fare un esempio e cercare di orientarci in questo mare magmum della complessità, possiamo tornare alla water footprint? Quando diciamo che per produrre un chilo di carne servono 15mila litri d’acqua, cosa intendiamo? Cioè se non mangiassimo quel chilo di carne (io sono quasi vegetariano), risparmieremo 15mila litri d’acqua? Per farne che? Voglio dire esistono vari tipi d’acqua E perché lo diciamo solo per la carne, e non per il latte (7mila litri d’acqua), anche per il riso? Ecco, mi spieghi un po’ questi calcoli?
L’impronta idrica (o water footprint) tiene in conto di tutte le voci utilizzate per un processo. Nel caso dell’agricoltura c’è l’acqua verde (le piogge, non le mettiamo noi), quella blu (l’irrigazione) e quella grigia, ossia la quota che serve a riportare le acque di falda, fiumi, laghi e mare a una concentrazione di residui sotto la soglia di legge. L’acqua grigia non è sempre necessaria, talvolta le piogge apportano più acqua del necessario e quindi fanno fronte all’esigenza in acqua grigia. Quindi, se non producessimo quella carne, purtroppo non risparmieremo 15mila litri d’acqua, ma molto meno. Ma comunque un piccolo risparmio ci sarebbe. Quei litri sono tutti quelli utilizzati, anche quelli provenienti dall’acqua piovana, che cadrebbe comunque. Inoltre, nell’ipotesi di produrre qualcosa al posto dei foraggi, dovremmo considerare l’acqua blu e grigia della nuova produzione, che potrebbe anche essere di più della somma dell’acqua blu e grigia dei foraggi (e spesso lo è purtroppo). E voglio sempre ricordare che tutto va misurato in funzione della resa! Le nuove colture potrebbero produrre poco e male.
Dunque, se io smettessi del tutto di mangiare carne (cosa che voglio fare) e se tutti lo facessero, dovremmo considerare altre fonti proteiche, che so, la soia per esempio, che è una cultura che richiede acqua, in parte anche gli altri legumi. Il latte pure richiede acqua e insomma, questo intendi quando parli di complessità nel definire la sostenibilità?
Ovviamente nell’ipotesi di smettere di mangiar carne dovremmo considerare altre fonti proteiche e l’impatto delle stesse. In termini di acqua, al momento attuale, altre fonti hanno anche meno esigenze delle carne, ma questo vale solo perché vengono prodotte in luoghi diversi. Nello stesso luogo potrebbero avere più esigenze. E peggio, oltre che l’acqua, dovremmo considerare l’impatto sul suolo e sul sistema agricolo: la produzione di carne è anche fatta in pascoli, la cui messa in coltura ha un forte impatto e inoltre la produzione di foraggi aiuta enormemente a diversificare gli agro-ecosistemi e fornisce il letame, il cui ruolo, credo, non ha bisogno di spiegazione. Il punto è quindi la diversificazione. Ridurla fa sempre danno. E quel danno va poi mitigato.
Secondo te i cittadini hanno idea di cosa sia la sostenibilità, voglio dire, di come è complesso il problema? Temo che il rischio sia quello solito: parliamo per sentito dire.
Lungi da me voler passare per severo, altezzoso, distante dai cittadini, etc., ma, francamente, la risposta è no! Assolutamente no. E ne sono molto dispiaciuto.
Puoi spiegare?
Come dicevo, l’opinione pubblica percepisce vagamente cosa sia la sostenibilità (almeno fino al cancello dell’azienda, o “cradle-to-farm gate” in gergo tecnico) e confonde l’impatto ambientale con i prodotti applicati alle piante, soprattutto se di sintesi (ignorando i carburanti, l’uso del suolo, la perdita di suolo e quanto ogni tecnica influenzi la resa). Se il leggero aumento d’uso di un fattore tecnico (e relativo impatto) mi aumenta molto la resa, allora la sostenibilità è aumentata. Se l’impatto aumenta più della resa, allora la sostenibilità si riduce. Come dicevo, i cittadini non ne percepiscono nemmeno la dimensione geografica (quantomeno territoriale, spesso nazionale). Il “sentito dire” è poi frequente e particolarmente gravoso anche quando vengono mostrati i dati a supporto, i quali smentiscono “il sentito dire” e chi se n’è fatto latore li rifiuta. A quel punto è facile invocare un “dacci oggi il kitipaka quotidiano”, che arriva sicuramente. Altro problema gravoso nel “sentito dire” è anche l’incapacità dei cittadini di coniugare il dibattito sugli impatti con quello sugli aspetti economici e sociali e le loro scale temporali.
Realisticamente che strumenti abbiamo oggi per mitigare il peso delle nostre orme?
Parlo di quelli a diretto controllo dell’agricoltura. Gli strumenti sono diversi, ma non di semplice attuazione. Il più importante in Europa è ridurre l’intensità delle lavorazioni, magari omettendole completamente. Tale riduzione fa risparmiare notevoli quantità di carburante e riduce moltissimo l’erosione del suolo. A sua volta ciò si ripercuote sulla remunerazione per l’agricoltore e il mantenimento della fertilità del terreno.
Mi fai un esempio, che significa riduciamo le lavorazioni, come faccio se non pratico un’aratura?
Per le colture erbacee, si può seminare direttamente su terreno non lavorato con adeguate seminatrici (si chiama “No tillage” o “Direct drilling”, ma ha anche altri nomi) anche in presenza di residui colturali. Tuttavia, spesso gli agricoltori pensano che basti cambiare la seminatrice. Purtroppo, la tecnica è complessa e vanno ristrutturati tanti aspetti gestionali, tra cui rotazioni, scelta del genotipo, concimazioni, controllo degli stress, etc. Se non si agisce su tutto ciò contemporaneamente, la possibilità di successo si riduce molto. E spesso gli agricoltori non sono in grado di gestire tutto. In altri casi non hanno la disponibilità della seminatrice.
Altri strumenti?
Certo. E non meno importanti. Abbiamo la sfegatata esigenza di diversificare le colture e gli agro-ecosistemi: spesso si fanno pochissime specie, anche una sola (e spesso non ci sono nemmeno corridoi ecologici). L’omogeneità gestionale è acerrima nemica della sostenibilità. Far sempre la stessa specie obbliga a usare molti fertilizzanti e principi attivi e un intento, condivisibile, è ridurne l’uso ai soli casi di reale esigenza.
Aspetta, questo punto mi sta a cuore, perché le monoculture erbacee (mais, soia) sono giudicate meno sostenibili delle monoculture (spesso secolari) di melo, vite, olivo ecc.? C’è differenza, e si si cosa si può fare per allentare la morsa della monocultura?
Non direi che una monocoltura erbacea sia meno sostenibile di una arborea. Gli studi di settore non evidenziano grandi differenze per l’impatto ambientale. Spesso la coltura erbacea è più intensiva e richiede una maggior quantità di mezzi tecnici, ma produce molta più biomassa organica. Le specie arboree sono però consociabili (con inerbimento o colture da reddito) e producono più radici grosse, che diventano più facilmente sostanza organica, ma se gestite male possono perdere molto suolo. Inoltre, normalmente le arboree forniscono più reddito. Credo molti considerino le colture arboree meno impattanti di quelle erbacee solo per un retaggio colturale: le arboree richiedono ancora molta manodopera, come un tempo, le erbacee no. E le “cose antiche” sono considerate a torto meno impattanti.
Va bene, come allentiamo la morsa della monocultura?
Se proprio non si vuol fare rotazione, un valido aiuto arriva dalle tecniche di agricoltura di precisione. Purtroppo tutto ciò (agricoltura conservativa e di precisione) costa tanto, soprattutto in termini di risorse umane: gli agricoltori spesso non riescono ad accedere a tali innovazioni e la promozione da parte del legislatore è praticamente omeopatica [in sintesi, inefficace]. Voglio aggiungere che diversificare significa sia coltivare specie diverse, sia in modo diverso e sia avere spazi non coltivati (es. boschi, macchia mediterranea, etc.) insieme a quelli coltivati.
In Italia, anzi in tutta Europa, i boschi sono in aumento, solo che purtroppo alcuni boschi sono inaccessibili.
È vero. Il fatto che siano inaccessibili non è un grosso problema per la sostenibilità ambientale. Ma l’inaccessibilità ha un costo economico. Il problema non riguarda comunque solo la superficie a bosco, ma come dicevo il fatto che sono localizzati solo in certi ambienti. Ma francamente non consiglierei a un agricoltore mai un impianto arboreo per produzione di legno in una zona di pianura intensamente coltivata: ci perderebbe un sacco di soldi. E non sono perdite che nemmeno il legislatore può permettersi, almeno al momento.
E altri aspetti?
Due: uno che mi cruccia è la pessima distribuzione degli animali allevati: attualmente sono troppo concentrati, per cui l’allevamento comporta problemi sia dove presente (eccesso di reflui e altri materiali di risulta) sia dove assente, per impossibilità di avere letame e diversificare le colture grazie alle foraggere, il cui ruolo nell’agro-ecosistema è importante. L’altro è la rinuncia, almeno in Italia, alla ricerca sugli OGM (sensu latu) e loro uso, che aiuterebbero non poco ad aumentare la sostenibilità dei sistemi agricoli, non senza potenziali inconvenienti purtroppo. Oltre ai summenzionati, comunque, esistono anche altri strumenti sebbene meno importanti per aumentare la sostenibilità.
Visto che ci siamo parliamone, per esempio, pregi e difetti del bio?
Non ho riserve a risponderti con una domanda provocatoria: quale bio?
Cioè?
Quello europeo? Il messicano? L’australiano? Quello di oggi o di 15 anni fa? Il bio è (solo) un sistema di certificazione di processo. Tale certificazione cambia nel tempo, prevede alcune limitazioni presenti in quasi tutti i sistemi, ma la parte non comune influenza molto la sostenibilità dei sistemi.
Fammi un esempio.
Pensa che in bio si può coltivare in serra e perfino usare alcuni prodotti di sintesi, ad esempio alcuni ormoni, ammessi perché considerati uguali alla molecola naturale. Come se lo ione ammonio rilasciato dai batteri del suolo fosse diverso da quello di sintesi, che invece non è permesso. Volendo sorvolare sull’ipocrisia normativa del bio, non c’è alcuna evidenza che impatti meno per unità di prodotto ottenuto del convenzionale (es. Environ. Res. Letters 2017:064016). E per certi aspetti impatta di più.
Però dei pregi ci sono…
Sì, pregi (molto) indiretti che non vanno ignorati: per fare bio si è costretti a diversificare di più e questo può aiutare. Inoltre, le persone sono più disposte a pagare per il bio e quindi può far acquisire più valore aggiunto all’agricoltore, il che è fondamentale per mantenere la popolazione in certi territori. Inoltre, la presenza di colture bio in mezzo a convenzionali può aiutare a ridurre i carichi di residui a scala territoriale.
Ok, sento che c’è un ma…
Tuttavia, il reddito degli agricoltori biologici è molto più sostenuto dalla PAC rispetto ai convenzionali (il 45% contro il 30% secondo i dati del bioreport 2017) il che implica che, almeno in UE, il bio è pagato anche da chi non lo acquista. Come sai bene, il dibattito sul bio e sugli aiuti europei è complesso e spesso un’esigenza è stata giustificata con un’altra per via di una ipocrisia normativa che personalmente non amo (lo stesso si fa nei confronti degli OGM in Italia) ma che investe direttamente la percezione del settore da parte dei cittadini. Voglio specificare che ho un conflitto di interesse al contrario. Come già detto, io faccio ricerche che fan bene molto più al bio che al convenzionale: avrei convenienza a dire il contrario di quanto sostenuto. Ma preferisco riportare le evidenze scientifiche.
Non credi che quando diciamo bio, sottolineiamo un aspetto importante: cioè provare in campo (testarli alla ricerca di evidenze scientifica, non di chiacchiere) gli strumenti che ci permettono di abbassare i costi e gli impatti e aumentarne i benefici nonché il reddito degli agricoltori (fondamentale). Ora, come sai ho un ruolo ispettivo al Mipaf, da 31 anni, giro in lungo e largo le campagne italiane, qui ci sono problemi atavici ma anche tante potenzialità. Quello che ci rovina è la monocultura dell’immaginario, cioè crediamo che esista solo una soluzione, o fai il bio o fai le biotecnologie, e se fai il bio non parli, anzi attacchi i biotecnologi, o fai le rotazioni o l’agricoltura intensiva, o fai morire le api o favorisci la biodiversità, o compri dal contadino sotto casa o sei servo e pagato dalle multinazionali. Nei miei sogni immagino che il bio sia un contenitore nel quale entrano nuovi modi (ripeto testati e con evidenze scientifiche) di fare agricoltura, e in effetti mai come oggi abbiamo una nuova cassetta degli attrezzi.
Quanto auspichi sul bio vale per tutta l’agricoltura, sia bio, sia non bio. Le affermazioni fondate sulle evidenze dovrebbero esistere per ogni settore. Nei fatti le sperimentazioni ci sono, ma lungi da me dire che siano tanti. La ricerca nel settore (agricolo, non solo bio) gode di finanziamenti modesti, soprattutto da parte delle aziende. E lo stato non si spreca. E concordo: la rovina è proprio quella che chiami “monocoltura dell’immaginario”. Ad esempio, i miei sogni corrispondono ai tuoi, ma applicati a tutto il settore, non solo al bio. Il bio ha più esigenze di innovazione solo perché rinuncia deliberatamente a parte della stessa innovazione.
Cioè?
Pensiamo al bio in confronto al convenzionale (termine che amo) di 70 anni fa, ma né bio, né convenzionale sono quelli di un tempo. E la cassetta degli attrezzi cui fai riferimento potrebbe essere applicata integralmente in bio. Torno volutamente alle tecniche di intervento genico: il bio li rifiuta per ideologia, ma non rifiuta la progenie di genotipi nati da radiazioni che hanno subito modifiche causali e non rifiuta incroci che in natura sarebbero impossibili. Eppure le attuali tecniche di intervento genico consentono modifiche mirate, riducendo (quasi eliminando) le modifiche non controllabili che possono portare non pochi problemi. E questo è solo un esempio, ma la casistica dell’ipocrisia delle scelte in agricoltura è ampia e, ahinoi, investe anche il convenzionale.
Riusciremo a parlarne? Spiegare al cittadino in maniera chiara costi e benefici? Portare l’agricoltura in prima serata, per usare un termine televisivo.
Sono disfattista, temo di no. Il racconto dell’agricoltura (come di tante altre cose) è fortemente contaminato da Ignoranza, Disonestà e Ipocrisia (le IDI del nostro tempo…). E la cosa è decisamente sfruttata a fini politici e di share televisivo, con pochissime esclusioni purtroppo (Elena Cattaneo, Piero Angela, Gerardo D’Amico, pochi altri). Francamente, credo che per riuscire a parlare al grande pubblico serva l’impegno di portare nelle scuole elementari la cultura scientifica. Ma l’investimento in istruzione, ricerca e sviluppo in Italia ha numeri, anch’essi, omeopatici. E le informazioni sulla percezione sociale del settore sono carenti ma necessarie per poterne parlare. Per far parzialmente fronte a ciò, con alcuni colleghi del CREA e alcune università italiane abbiamo lanciato un questionario compilabile da tutti, anche senza competenze nel settore, sulla sostenibilità in agricoltura (lo trovate qui). Sarebbe bello i lettori lo compilassero e ci dessero una mano a diffonderlo.
Scarso investimento in istruzione, ricerca e sviluppo, forte presenza di Ignoranza, Disonestà e Ipocrisia… sono aspetti che travalicano l’agricoltura, non credi?
Si, pienamente. Ma in agricoltura sono particolarmente gravosi: gli agricoltori sono mediamente più anziani e meno scolarizzati di altri lavoratori e, temo ma non ho dati a supporto, a parità di scolarizzazione e luogo di provenienza sono anche meno acculturati.
Come vedi l’agricoltura italiana del futuro?
Futuro? Quantifichiamo. Facciamo 30 anni, che son già tanti. Non ho la sfera di cristallo, ma vedo nella UE l’unico spiraglio di speranza. La UE ha talvolta comportamenti apparentemente contrastanti: ad esempio sostiene di voler favorire il bio o ridurre i principi attivi di sintesi senza un supporto scientifico, ma, al contempo, la Corte di giustizia europea nel 2018 ha emesso una sentenza che potrebbe addirittura favorire gli OGM in Italia. In Europa le legislazioni sono abbastanza avanzate ma un po’ disomogenee, l’impatto ambientale per unità di prodotto è basso e perfino in riduzione, ma tali comportamenti rischiano di comportare maggiori impatti altrove.
E allora che si fa?
Spero nei prossimi 30 anni avvenga un maggior trasferimento di competenze dalle sedi nazionali a quella comunitaria e una maggiore armonizzazione dei sistemi, oltre che maggiori collaborazioni con i paesi-extraeuropei. Tutto ciò investirà pesantemente il settore agro-alimentare, che non per nulla è stato il primo normato in sede comunitaria: in pochi anni dovremmo dare da mangiare a 10 miliardi di persone, ridurre la denutrizione, evitare che l’impatto ambientale dell’agricoltura aumenti e fare tutto ciò salvaguardando il potere di acquisto di chi è ricco e aumentando quello dei poveri: trovare un unicorno alato è più semplice.
Per fare tutto ciò, l’unica (purtroppo) via è l’istruzione, ricerca e sviluppo e ogni spazio dato a chi propala disinformazione riduce drasticamente le chance di successo.