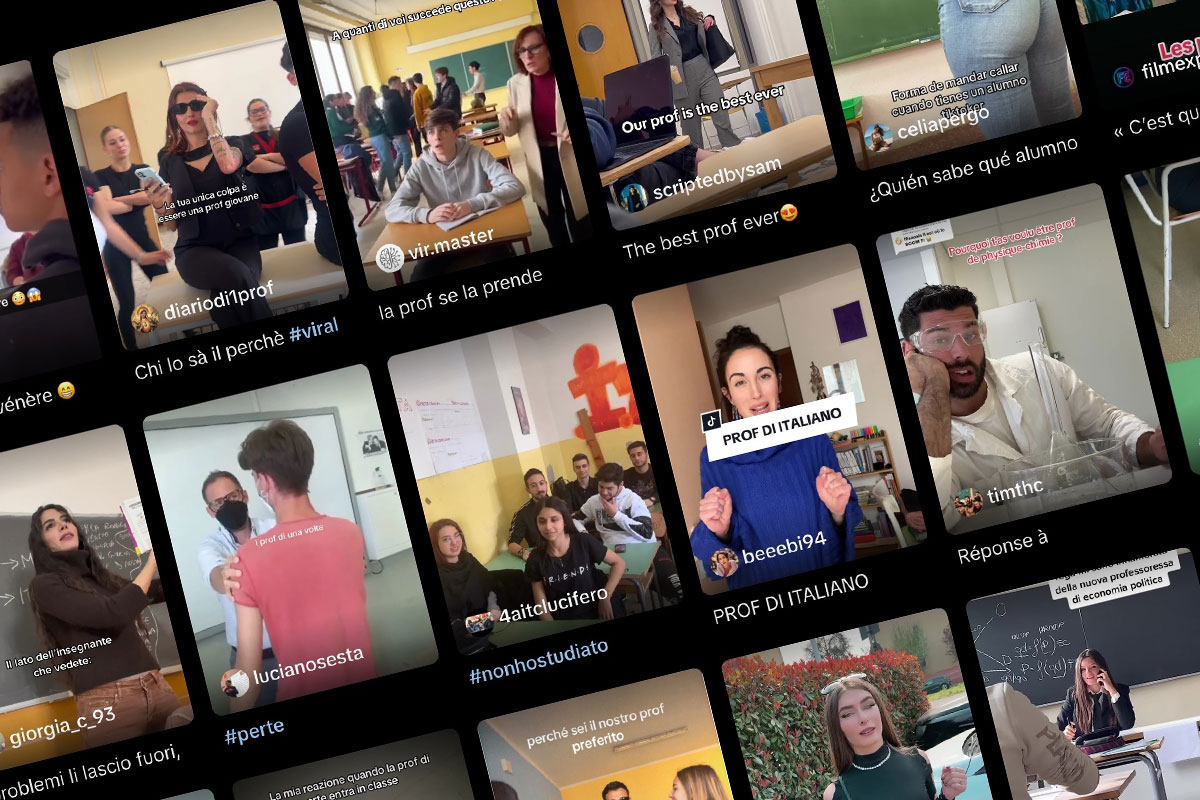L’italiano che si parla nei film e nelle serie
Dopo decenni di dizione e assenza di accenti le cose ormai sono cambiate, e quando non ci sono i regionalismi lo si nota

Per decenni nei film e nelle serie televisive italiane non si è parlato la stessa lingua che si parlava nella vita di tutti i giorni, e in molti sensi quell’italiano da cinema ha influenzato la lingua reale. È stato un fenomeno a lungo intenzionale, cominciato negli anni del fascismo per diffondere l’italiano, e poi spontaneo. Negli ultimi decenni però è cambiato molto nella lingua che si parla in film e serie: la ricerca del realismo nei dialoghi e nella recitazione, quindi sia nelle parole e nelle frasi pronunciate sia nelle intonazioni, negli accenti e nel ricorso al dialetto, è diventato un obiettivo di molte produzioni. Questo processo è evidente quando ogni tanto si sente ancora un italiano molto corretto e poco sporco in bocca a personaggi che per estrazione, formazione e provenienza non dovrebbero parlarlo. Invece che sembrare normale come una volta, oggi può apparire particolarmente strano.
È accaduto recentemente in Il mostro, la serie di Stefano Sollima su Netflix, che racconta una parte delle indagini sugli omicidi riconducibili al “mostro di Firenze”. Sono storie ambientate nell’Italia di provincia di fine anni Sessanta e anni Settanta, che raccontano l’impatto che la modernizzazione dei costumi, soprattutto per quanto riguarda i rapporti tra generi, ebbe su un paese che era per molti versi ancora contadino. Molti hanno notato come i protagonisti di questa stagione di Il mostro siano persone di estrazione povera, prossime all’analfabetismo e provenienti dalla Sardegna, quindi poco legate all’italiano, eppure parlano in linea di massima un italiano molto pulito con una leggera inflessione sarda. E che in generale nella serie si senta pochissimo accento toscano. È un aspetto che peraltro stona con l’enorme lavoro di ricostruzione che ha fatto la serie sugli altri aspetti.
Mostrare personaggi di regioni specifiche che parlano con piccole sporcature che segnalano la loro provenienza, senza voler rispecchiare esattamente il parlato stretto, è stata la regola per decenni nel cinema italiano, almeno da quando negli anni ‘80 si iniziò a girare in presa diretta, cioè registrando l’audio sul set. L’uso del doppiaggio italiano anche per i film italiani, infatti, aveva importato dal doppiaggio di film stranieri molti artifici e l’idea di una dizione pulita e chiara. Il dialetto era usato in modi espressivi per finalità comiche o grottesche (come faceva per esempio Federico Fellini, enfatizzandone il lato macchiettistico). Siccome i film italiani erano quasi sempre doppiati dagli stessi attori che li recitavano (e in casi più rari da doppiatori professionisti), spesso questi ne approfittavano per enfatizzare la buona dizione. L’uso della presa diretta è stata una reazione a questa consuetudine che portò a una rappresentazione sempre maggiore dei regionalismi. Ma è negli anni Duemila che l’enfasi sul realismo si fece più radicale.
Questo non vale tanto per le produzioni molto commerciali o per le televisioni generaliste, come quelle per i canali Rai o Mediaset, che usano ancora l’italiano più standard e pulito possibile, perché attente alla chiarezza e a non escludere nessuno dalla comprensione. Ma è ormai la norma per le produzioni in cui gli autori hanno più potere decisionale. L’emergere nell’ultimo decennio di un nuovo tipo di serie e film polizieschi o di storie criminali ha poi enfatizzato ancora di più la ricerca del dialetto reale, anche quando poco comprensibile. Lo stesso Stefano Sollima, con le serie Romanzo criminale e Gomorra, è stato un pioniere dell’abbandono dell’italiano più scolastico o del dialetto più pulito.
– Leggi anche: “Il mostro” ha deciso di ricostruire tutto
È stato un grande cambiamento perché uno dei fattori cruciali nella modernizzazione dell’italiano fu proprio il cinema, che quando divenne sonoro (nel 1927 in America e nel 1930 in Italia) si pose il problema di quale italiano adottare. Sfruttò l’occasione per fondare la versione moderna della lingua e diffonderla, «andando nella direzione di semplicità e freschezza», come spiega Fabio Rossi nel saggio Lingua italiana e cinema. La fine del fascismo poi aggiunse a questo italiano anche la rappresentazione dei regionalismi, spesso in chiave comica e macchiettistica, ma sempre con una grande pulizia e comprensibilità, con un risultato che il linguista Giovanni Nencioni descriveva come il «parlato-recitato». Tra gli anni ‘50 e i ‘90 questa lingua del cinema ha influenzato l’italiano reale, come testimoniano le parole o locuzioni inventate dai film o inusuali ed entrate nell’uso comune: alba tragica, gioventù bruciata, i soliti ignoti, Amarcord, dolcevita, paparazzo, vitellone e pinzillacchera, per dirne alcune.
La lingua italiana del cinema e della serialità oggi però è molto diversa e aspira al realismo. Sia a livello produttivo, cioè quando a monte si progetta un film con una lingua così verosimile da essere incomprensibile in certe parti del paese, sia a livello attoriale. Sono sempre di più gli attori che, per formazione e scuola di pensiero, rifiutano di recitare in un italiano pulito, esattamente l’opposto di quella che per decenni era stata invece l’impostazione dominante. Agli attori è sempre stato insegnato, e ancora succede, a rimuovere i difetti di pronuncia e a cancellare le inflessioni del proprio dialetto di provenienza, per aspirare a un italiano impersonale, che era quello richiesto dalle produzioni una volta. Oggi invece quel lavoro di rimozione dei difetti o delle inflessioni di provenienza è usato per non essere vincolati a una cadenza sola, e saperne imitare diverse.
Sebbene il dialetto sia la caratteristica più evidente di un maggiore realismo nella lingua parlata nei film e nelle serie, solitamente è accompagnato anche dall’uso di una lingua gergale o substandard (la lingua artificiale dei dialettofoni analfabeti che tentano di esprimersi in italiano). Questo si faceva già tra gli anni ‘70 e ‘90 per identificare personaggi di classi svantaggiate, come per esempio nei film di Pier Paolo Pasolini. Ora invece quel tipo di lingua è usato come un marchio d’appartenenza e come segno di attaccamento alle radici locali, specialmente nelle produzioni per le piattaforme globali. Anche per questo il dialetto e la lingua substandard sono entrati in generi che prima non li avevano mai previsti, come il musical (Ammore e malavita), l’animazione (Gatta Cenerentola, Strappare lungo i bordi) e il film storico (L’uomo che verrà).
Attori e attrici che lavorano in produzioni commerciali continuano a non usare il dialetto o a limitare l’accento, se non per commedie e film comici (che dal dopoguerra, anche per la forte influenza di Totò, sono spesso legati al regionalismo). Attori e attrici che invece lavorano nel cinema drammatico o in quello con aspirazioni più intellettuali cercano il dialetto e la cadenza regionale, spesso anche quelle che non gli appartengono. Pierfrancesco Favino, uno di quelli che più ci fanno attenzione, ha spiegato di non recitare mai in italiano pulito perché nessuno, in contesti informali, lo usa: tutti hanno un’inflessione di provenienza, e la forza di questa inflessione cambia a seconda dell’epoca e della classe sociale. Per ogni personaggio, insomma, va creata una sua lingua.
– Leggi anche: «Andiamo a sfumare il nostro risotto»
Questo fa sì che oggi esistano diverse tipologie di italiano nei film e nelle serie. C’è quello molto fedele al parlato vero, e lo si sente nella serie Gomorra o nei film d’autore come A Chiara, Le città di pianura, o ancora in quelli di Alice Rohrwacher e Matteo Garrone, sempre attenti al realismo. C’è quello il cui realismo è moderato per esigenze commerciali, come il romanesco anni ‘40 presente ma addomesticato di C’è ancora domani di Paola Cortellesi o quello che usa Marco Giallini anche in ruoli drammatici, oppure il napoletano pulito di Toni Servillo in film come Qui rido io.
Esistono poi casi più estremi ma comunque frequenti, come Le otto montagne, in cui il romano Alessandro Borghi parla con un’inflessione marcatamente settentrionale, o la serie Il Gattopardo, ambientata in Sicilia a fine Ottocento, in cui tra gli attori principali non ci sono siciliani ma tutti parlano con una lieve inflessione siciliana. O anche M. Il figlio del secolo, in cui ogni attore principale parla in un dialetto che non è il proprio. Senza contare lavorazioni ancora più ardite per ricerca linguistica come Martin Eden o Fuori di Mario Martone, in cui si cerca l’inflessione e la lingua dialettale di una certa epoca che non è quella di provenienza di chi recita.
Chi studia il rapporto tra la lingua italiana e la sua rappresentazione al cinema e in televisione descrive il legame che le due intrattengono oggi come “caotico”, perché convivono molti approcci e forme di sperimentazione. Ci sono infatti anche casi isolati di film italiani in altre lingue (Io capitano) o in cui convivono più lingue diverse (Nostalgia) o addirittura in lingue morte ricostruite (Il primo re).