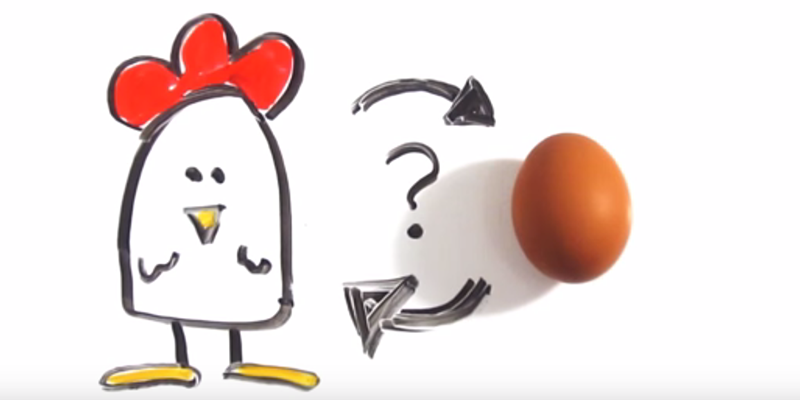Di cosa parleremo per i prossimi sei mesi
Siete pronti per una lunga campagna sul referendum costituzionale?

Tra mercoledì e giovedì il Senato approverà in via definitiva la riforma costituzionale della giustizia. A quel punto si avvierà il processo che porterà nella primavera del 2026 al referendum confermativo, probabilmente il momento decisivo della legislatura sul piano politico, che determinerà in buona misura anche l’avvicinamento alle successive elezioni politiche, previste nel 2027. Di conseguenza ci aspetta una lunga campagna referendaria vivace e caratterizzata da aspre polemiche, non solo e non tanto sul merito della riforma, ma sul giudizio nei riguardi del governo che l’ha approvata e in particolare sulla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.
– Leggi anche: La riforma costituzionale della giustizia, spiegata
Prima, però, un po’ di tecnicismi. Dal momento in cui la legge verrà pubblicata in Gazzetta Ufficiale, qualche giorno dopo il voto al Senato, ci saranno 3 mesi di tempo per indire un referendum confermativo, come è previsto per le riforme costituzionali che non siano state approvate da una maggioranza di due terzi dei deputati e dei senatori. Quasi sicuramente saranno i partiti di opposizione a organizzarsi in tal senso: basterà infatti che almeno un quinto dei componenti dell’una o dell’altra camera sottoscriva questa richiesta (che altrimenti può essere avanzata anche da cinque consigli regionali o da 500mila elettori). Da lì in poi, entro un periodo massimo di quattro mesi e mezzo, dovrà svolgersi il referendum (secondo le prime stime preliminari fatte dai vari partiti sarà tra metà aprile e inizio giugno).
Mancano ancora più di sei mesi, dunque. Ma buona parte della dialettica politica già si sta sviluppando avendo in mente quella scadenza. E i vari leader hanno già da qualche settimana iniziato a rivelare quale sarà il loro atteggiamento, su quali argomenti punteranno, su quali sorvoleranno.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro della Giustizia Carlo Nordio alla Camera il 17 dicembre 2024 (Roberto Monaldo/LaPresse)
Lo si è capito anche dal dibattito che c’è stato alla Camera e al Senato. E anzi, per certi versi si può dire che questo è stato l’unico valore di un dibattito parlamentare peraltro del tutto svilito, visto che, con una scelta senza precedenti per una simile riforma costituzionale, deputati e senatori sapevano fin dall’inizio che non avrebbero potuto apportare alcuna modifica al testo approvato dal Consiglio dei ministri il 29 maggio del 2024. Ciò è avvenuto per una precisa scelta del governo, e in particolare di Meloni e del suo sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano.
Per scongiurare il rischio che acconsentendo ad alcuni emendamenti si potesse poi complicare il percorso di approvazione, o si potesse stravolgere l’impianto generale della riforma, si è deciso di proibire, di fatto, qualsiasi cambiamento. E i deputati e i senatori di maggioranza hanno abbastanza passivamente obbedito, compresi quelli che avevano detto di voler presentare emendamenti migliorativi, come il deputato Enrico Costa o il senatore Pierantonio Zanettin, entrambi di Forza Italia. Perfino il sottosegretario alla Giustizia di Fratelli d’Italia, Andrea Delmastro Delle Vedove, ha ammesso in un colloquio con Ermes Antonucci del Foglio le sue grosse perplessità sulla bontà della riforma nel suo complesso.
– Leggi anche: Le molte proteste dei magistrati in tutta Italia
E così per circa un anno e mezzo, a più riprese, il parlamento si è esercitato in una discussione piuttosto surreale, nella consapevolezza condivisa della vanità di tutto quanto. Anzi, quanto più i toni si facevano accalorati, tanto più emergeva l’insensatezza del confronto in aula intorno a un testo immodificabile. Almeno, però, ci si è potuti fare un’idea di come i vari partiti pensano di sostenere le proprie ragioni a difesa o in opposizione alla riforma.
Da un lato c’è il merito della legge. La novità più rilevante, che è quella su cui si è concentrato e si concentrerà il dibattito, consiste nella separazione delle carriere tra magistratura inquirente e magistratura giudicante, cioè tra il pubblico ministero che conduce le indagini e il giudice che emette la sentenza. Per i favorevoli, introdurre dei percorsi differenziati fin dall’inizio, con concorsi appositi, e vietare il passaggio dall’una all’altra funzione rafforza l’indipendenza dei giudici dai pubblici ministeri, e consente a chi deve giudicare di avere competenze specifiche che non sono in alcun modo condizionate da una sua eventuale precedente attività di inquirente.
Per i contrari, invece, questa riforma ha il fine di rendere il pubblico ministero troppo potente, una sorta di «super poliziotto» che finirebbe per rispondere, in modo più o meno diretto, proprio al governo. Anzi, l’accusa in questo senso è esplicita: le opposizioni dicono che questa separazione delle carriere non è che il preludio a una successiva riforma che porterà i magistrati inquirenti alle dipendenze del ministro della Giustizia, come del resto avviene un po’ in tutti i paesi europei in cui le carriere dei magistrati sono distinte.
Peraltro, questo è a sua volta un argomento che torna comodo utilizzare a chi sostiene la riforma. Premesso che l’eventuale subordinazione dei pubblici ministeri al governo non c’è, e che laddove dovesse essere introdotta dovrebbe comunque avvenire tenendo conto dei vincoli dell’articolo 104 della Costituzione («la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere»), chi non disdegna l’ipotesi, in futuro, fa notare come in Francia o in Germania, dove vige questo principio, non c’è affatto un sistema meno democratico di quello italiano, o un equilibrio dei poteri meno bilanciato.
Ma qui siamo già molto addentro alle questioni di merito. Per lo più, l’impressione è che i partiti vogliano tenere il confronto sul piano più politico. Il centrodestra tenderà a presentare la riforma come un atto con cui si ridefiniscono virtuosamente i poteri di una categoria, come quella della magistratura, che negli ultimi anni ha mostrato enormi limiti nella propria condotta: eccessiva ingerenza nella politica, divisioni per correnti politiche, clientelismo e corruzione. E che dunque è percepita dai cittadini come una sorta di casta.
Il centrosinistra, con toni diversi a seconda dei suoi esponenti, tende a evidenziare come in realtà già con la riforma Cartabia del 2022 si siano introdotti consistenti limiti ai passaggi di carriera (ce ne può essere solo uno, e solo nei primi 9 anni dall’entrata in servizio), e che su un organico di oltre 10mila magistrati, i passaggi di carriera sono, mediamente, una ventina all’anno. A fronte dell’esiguità del fenomeno, dunque, la volontà di approvare la riforma si spiegherebbe solo con il tentativo di limitare i poteri della magistratura, ridimensionarne la capacità di esercitare le sue prerogative, e dunque compromettere l’equilibrio tra il potere esecutivo e quello giudiziario a favore del governo.
Il tutto, poi, col consueto ricorso, di per sé piuttosto retorico, a illustri sostenitori dell’una o dell’altra soluzione. E così, in questi mesi, si è più volte sentita la destra citare un grande magistrato di orientamento progressista, come Giovanni Falcone, notoriamente favorevole alla separazione delle carriere; dall’altro lato, il centrosinistra ha recuperato alcuni interventi di Paolo Borsellino, amico e collega di Falcone ma di cultura conservatrice, contrario alla separazione delle carriere. E il gioco dei rinfacci non si è concluso qui.
La destra ha rimproverato infatti a vari esponenti del PD di avere, in passato, proposto al loro partito la separazione delle carriere (e tra questi c’è l’attuale responsabile Giustizia della segreteria di Elly Schlein, Debora Serracchiani); il PD ha dato grande risalto a delle vecchie prese di posizione del ministro della Giustizia Carlo Nordio contro la separazione delle carriere. E poi Forza Italia esalta questa riforma perché realizza un vecchio sogno di Silvio Berlusconi, e dunque è apprezzabilissima; per lo stesso motivo, il Movimento 5 Stelle dice che la riforma è da condannare.
Insomma, anche solo restando sulla principale novità della riforma, e tralasciando per ora altri aspetti comunque controversi, è chiaro che il dibattito sarà estremamente politico, per così dire, e il referendum rischia quindi di diventare una specie di plebiscito a favore o contro il governo. È proprio quello che Meloni, almeno per ora, sembra voler evitare, memore del precedente più significativo, cioè quello del referendum costituzionale del 2016 promosso dall’ex leader del PD Matteo Renzi. A differenza di Renzi, Meloni ha già detto che, indipendentemente dall’esito della consultazione, lei non si dimetterà, né riterrà di mettere in discussione l’operato del suo governo. È un modo per disinnescare la prevedibile mobilitazione che, al contrario, verrà promossa dai partiti di opposizione, che inviteranno quante più persone possibili ad andare a votare contro l’entrata in vigore della riforma per mettere in crisi il governo.