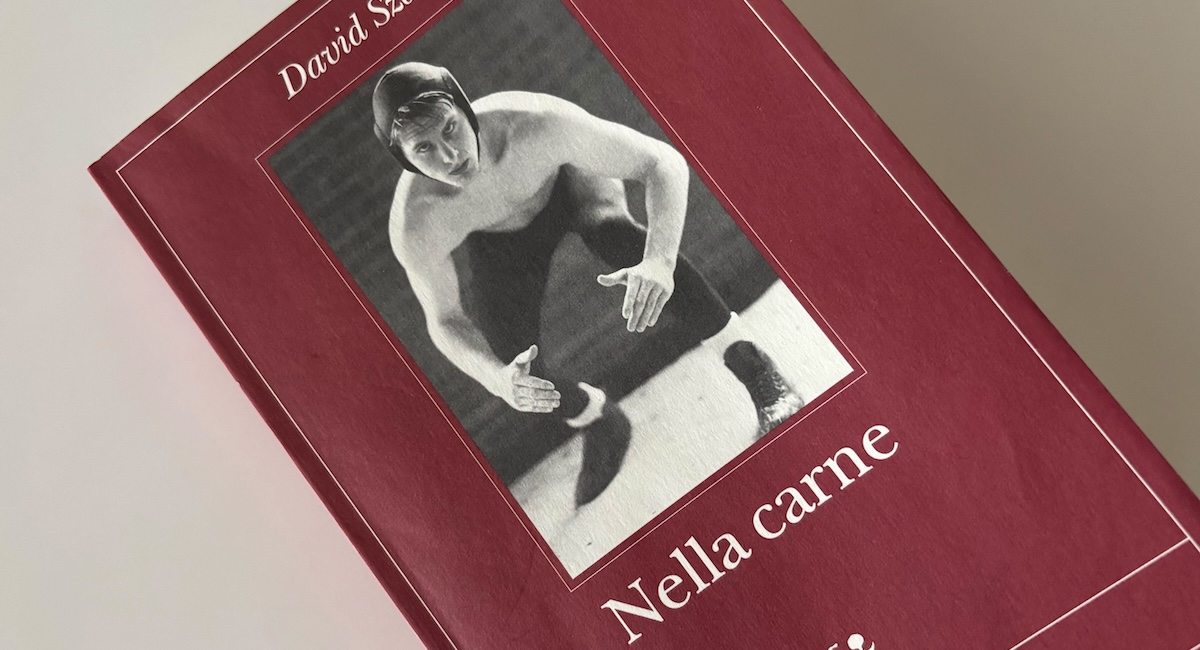In Nepal, prima della rivoluzione
«La prima volta che ci sono venuto, nel 2001, i ricchi non esistevano o quasi. C’era solo il re con la sua corte. Al terzo viaggio ho deciso che volevo andare a conoscere i guerriglieri maoisti. Un giorno sono salito su un tuktuk a pedali e il conduttore ha cercato l’indirizzo su Google Maps»

Mal consigliato dal mio amico Sudarshan, due settimane fa sono andato a cena nel ristorante più amato dai nuovi ricchi di Kathmandu, appena fuori città. Un po’ è colpa mia: gli avevo chiesto un posto diverso dai soliti locali turistici – e poi quella sera la mia compagna aveva voglia di vestirsi bene. Quindi mi sono fidato dell’indirizzo che lui mi ha scritto su un bigliettino. Si mangia male ma non sono pentito, perché anche lì ho capito qualcosa di ciò che è successo e sta succedendo in questi giorni in Nepal, tornato sulle prime pagine dei giornali occidentali dopo un ventennio di silenzio e indifferenza.
Alle otto, per trecento rupie, il taxi ci porta quindi alla nostra meta. Aperta la portiera mi sono trovato davanti a una surreale e gigantesca architettura a tetti spioventi, tipo una catena di baite alpine cresciute a dismisura, attorniata da un tripudio di lampadine colorate, colonne illuminate e automobili europee (quindi, qui, di lusso). Dentro c’è una specie di giardino, anzi una piazza all’aperto piena di camerieri che corrono da una parte all’altra passando davanti a un maxischermo: una famiglia sta facendo proiettare foto e video della figlia di cui si festeggia il compleanno.
Negli altri tavoli gli astanti sono tutti maschi tra i quaranta e i sessanta. Non so una parola di nepalese ma immagino che stiano parlando d’affari, o almeno questo è quanto traspare dai volti seriosi e dai gesti assertivi; di certo tutti esibiscono anelloni e bracciali d’oro massiccio. Prendo confidenza con un esemplare della specie, seduto al tavolo accanto. Mi chiede in inglese da dove vengo, insomma le solite chiacchiere, poi riesco a portare il discorso su quello che più mi incuriosisce, cioè i suoi robusti ori al collo e ai polsi, per cui falsamente mi complimento. Il mio vicino se ne schermisce con un sorriso: «Serve per lavoro, come da voi un abito firmato. Se mi presento a un banchiere o a un politico senza questi addosso, non mi darà mai retta. Devo far vedere che sono ricco per diventare ricco».
– Leggi anche: Le enormi proteste antigovernative in Nepal
La prima volta che sono venuto in Nepal, nel 2001, i ricchi in effetti non esistevano o quasi. C’era solo il re con la sua corte, circondati dai latifondisti che schiavizzavano i contadini, più un manipolo di lucky few – come venivano chiamati – che di solito maneggiavano superalcolici, qualche traffico con l’India e la produzione di sigarette: le Yak, senza filtro, terrificanti, consumate solo dai poverissimi, poi proibite per motivi di salute, e le Surya, che erano un po’ come da noi – tempo fa – le MS.
Già, le MS, con il loro fascino anni Settanta. Anche in Nepal, all’inizio di questo millennio, sembrava di stare ancora negli anni Settanta. Non tanto per gli ultimi occidentali che in vacanza si travestivano da hippy quanto per l’atmosfera sociale e politica, i manifesti e le scritte per strada, la rivoluzione maoista che dalle campagne si avvicinava sempre di più alla città, i sei o sette diversi partiti comunisti legali che si scindevano e si ricomponevano davanti a grandi ritratti di Marx e Lenin, il tutto comunque denso di speranze e illusioni. A tavola, la sera, i miei amici di diversi gruppi e fazioni litigavano tra loro come facevamo noi un quarto di secolo prima. Forse il Nepal mi affascinava anche per questo, mi sembrava di tornare ragazzo – e che non fosse mai arrivato il tempo del disincanto.
Di tutto il fermento politico che agitava il paese, la guerriglia maoista era l’aspetto più estremo, ma anche quello di cui si parlava di più. A Kathmandu ci si sentiva come in una bolla, circondata da montagne dove a volte i maoisti prendevano il controllo di intere vallate o regioni, uno stato nello stato con un capo-fantasma, il mitico “comandante Prachanda” di cui non circolava nemmeno una foto.
– Leggi anche: Le foto e i video delle violente proteste in Nepal
Al terzo viaggio in Nepal, ho deciso che volevo andarla a vedere da vicino, questa rivoluzione fuori tempo massimo in nome di Mao, e ho convinto la mia direttora a mandarmici in mezzo o almeno a provarci, nemmeno fossimo nella Cuba dei barbudos.
Come sempre nella vita, mi sono state preziose le coincidenze fortuite: un amico che aveva un cugino guerrigliero sulle montagne vicine a Dang, una fotografa tostissima che mi accompagnava, un fixer locale che pure sapeva il fatto suo. E così siamo entrati nei territori controllati dai maoisti come innocenti trekker, superando i posti di blocco dell’esercito grazie a qualche migliaio di rupie.
I primi due guerriglieri che abbiamo incontrato su un poggio non sembravano nemmeno maggiorenni e brandivano fucili di legno inglesi del tempo in cui l’India era colonia britannica. Via radio, hanno comunicato al loro capo l’arrivo di questi tre tizi, un giornalista italiano, una fotografa americana e una guida locale. Ci hanno detto di aspettare e io ho pensato che si trattasse di due o tre ore, invece siamo rimasti in una casupola due giorni. Erano gentili e una mattina un paio di loro sono partiti a cavallo – gagliardi e di ottimo umore – per andare a caccia di qualcosa di carnivoro. La mia prima figura da cretino è stata chiedere a un ragazzo armato dov’era il bagno – lui ovviamente mi ha risposto «everywhere».
Al terzo giorno gli adolescenti maoisti ci hanno svegliato presto e ci hanno detto di seguirli a piedi, su un sentiero che andava su e giù. Dopo sei o sette ore siamo arrivati in un villaggio preceduto da un arco rettangolare costruito con cassette della frutta e rivestito di bandiere rosse. Siamo stati ricevuti dal capo locale, che si chiamava Surya come le sigarette, ma in realtà la parola significa soltanto “sole” ed era il suo nome di battaglia, «comrade Surya», compagno Sole. Aveva una cinquantina d’anni e ci ha fatto subito una specie di esame per capire se eravamo ostili alla loro causa. Me la sono cavata grazie ai cortei degli anni Settanta, appunto: mi ricordavo ancora a memoria l’Internazionale – le parole sono diverse ma le note le stesse – quindi l’ho persuaso cantando.
I dieci giorni trascorsi tra i maoisti sono stati di pura propaganda, di messe in scena per noi. Esercitazioni militari (alcuni, privi di fucile, agitavano bastoni di legno) e arruolamenti in massa dei contadini: se non erano d’accordo con l’idea di assaltare basi dell’esercito non lo davano certo a vedere, ma molti si rifiutavano di giurare davanti a un’ufficiale donna e cambiavano fila per trovarsi di fronte un maschio. Di pomeriggio c’era il teatro, con un palco di legno in mezzo a una radura e attori-guerriglieri che impersonavano buoni e cattivi in una vicenda di sfruttamento agricolo al termine della quale il crudele latifondista veniva ucciso tra gli applausi.
Ogni tanto, la sera, il compagno Sole portava da non si sa dove la videocassetta di un film di Bollywood per svagare il popolo. Veniva proiettato in una grande stanza spoglia di una casa contadina ma doveva essere preceduto da un videodocumentario di un quarto d’ora sull’eroica guerriglia nepalese. Il pubblico aveva pazienza e si sorbiva la propaganda senza fiatare pur di godersi poi il film indiano, ma tutti si arrabbiavano quando all’improvviso la batteria del pannello solare si scaricava, in sala diventava buio e bisognava andare a letto senza sapere come andava a finire il film.
Poi con Surya siamo diventati quasi amici. Parlava un buon inglese, conosceva non solo i classici del marxismo ma anche Gramsci e Sartre. Continuava a paragonare la sua battaglia alla lunga marcia di Mao Zedong. Si era laureato in India e aveva due figli grandi che studiavano in Europa. Lui invece, lì in montagna, cambiava letto ogni notte per paura degli elicotteri del re, che qualche volta venivano su a sparacchiare senza concludere granché. La moglie lo seguiva ovunque e gli preparava il tè con lo zenzero. Alla fine ci siamo salutati con un abbraccio e un beneaugurante «arrivederci a Kathmandu». Mentre lo dicevo, consideravo irreale la sola ipotesi che quei soldatini scalzi, analfabeti e malarmati un giorno prendessero la capitale protetta da cingolati e aviazione.
Invece tre anni dopo i rivoluzionari di campagna si sarebbero messi d’accordo con la borghesia di città per mandare via il re, spartirsi il potere, alternarsi al governo, insomma chiudere gli anni Settanta e far soldi – un po’ come da noi negli Ottanta, in sostanza.
Ma anche a rivoluzione finita, a Kathmandu non sono mai riuscito a ritrovare Surya in nessuno dei miei viaggi successivi. Del resto nemmeno conoscevo il suo vero nome. A volte mi chiedo se è morto in battaglia o se invece è vivissimo e frequenta anche lui il ristorante a forma di megabaita, come altri ex guerriglieri diventati uomini d’affari.
Ogni tanto mi chiedo anche che fine abbiano fatto i suoi ragazzi con i fucili di legno, quelli che avevo conosciuto sulle montagne di Dang. Mi ricordo che una volta, a guerriglia ancora in corso, avevo parlato a lungo con uno di loro, si chiamava Bishnu e aveva 19 anni, era esaltato dalla guerra e dalla certezza della vittoria. Gli chiesi: ma tu cosa farai dopo che avrete vinto? Lui rispose: «Continuerò a combattere per espandere la rivoluzione maoista in tutto il mondo, in Europa, in Africa, negli Stati Uniti». Era il 2003, non i primi del Novecento, quindi la sua risposta era evidentemente marziana. Non ribattei, comunque. Aveva 19 anni, ormai deve aver quindi passato la quarantina. Chissà cosa fa e che cosa pensa. So che, per un accordo, molti ex guerriglieri sono entrati nelle forze armate regolari nepalesi: mi chiedo se oggi Bishnu è tra gli uomini in uniforme che bastonano i ragazzi della Gen Z in piazza.
Ancora più spesso mi domando che fine ha fatto Hari, un contadino che di anni ne aveva 23. Nelle campagne di Dang aveva ucciso a bastonate la moglie dopo una lite, da ubriaco. Poi era scappato per non finire in carcere e non sapendo dove andare era salito in montagna per chiedere riparo ai maoisti, a cui aveva confessato il suo delitto. Il compagno Surya aveva consultato il codice dei territori liberati e aveva deciso che di notte Hari sarebbe rimasto in cella, di giorno però si sarebbe addestrato per combattere con la guerriglia, a fine pena. Al mattino, in effetti, lo vedevo far ginnastica insieme alla truppa con i bastoni di legno, sognando di andare un giorno a combattere per diventare, da criminale, un eroe. Di nuovo, mi chiedo dov’è ora quel femminicida che nel maoismo aveva cercato la sua salvezza personale.
Quanto al “mitico” comandante Prachanda, la fine che ha fatto è invece nota: è stato due volte primo ministro, oggi è il leader dell’opposizione in un partito che si chiama ancora maoista ma quando è stato al governo ha fatto le consuete politiche per attirare capitali indiani, cinesi e occidentali. Ha 71 anni, non usa più il nome di battaglia ma quello anagrafico di Pushpa Kamal Dahal e come tutti i politici nepalesi è accusato dalla vox populi di arricchimenti illeciti e di corruzione, anche se non è mai stato ufficialmente indagato.
La prima volta lo avevo intervistato a rivoluzione appena vinta, in una camera di un appartamento anonimo di periferia in cui i suoi uomini mi avevano portato con mille cautele ma orgogliosi di mostrarmelo: per anni la propaganda del re aveva sostenuto che Prachanda non esistesse nemmeno, che era un Che Guevara di cartone creato a tavolino per regalare un mito alla guerriglia. Invece non solo era lì in carne e ossa ma discettava senza interprete sui mille socialismi possibili, da quello di Lula in Brasile a quello di Stalin in Russia, sostenendo che il Nepal avrebbe trovato il suo, diverso da tutti gli altri, fatto di funivie per unire i villaggi di montagna, di idroelettrico da vendere all’India e naturalmente di riforma agraria.
La seconda volta, un paio d’anni dopo, mi ha ricevuto nella nuova sede del partito, ci siamo fatti un selfie in terrazzo e mi ha annoiato moltissimo parlandomi di alleanze e litigi con i leader delle altre forze parlamentari, insomma pura politique politicienne. Sembrava un doroteo italiano e, infatti, alla fine l’intervista era venuta soporifera.
Negli anni successivi alla rivoluzione, passata la curiosità per i sedicenti maoisti al governo, il Nepal è sparito dai radar mediatici, almeno quelli occidentali. Io continuavo però a tornarci per raccontare altre storie, di cui pure il paese era generoso: il traffico di reni gestito dalla malavita organizzata in combutta con i medici corrotti indiani; oppure i falsi orfanotrofi che rubavano o compravano bambini piccoli dalle famiglie più povere e poi li rivendevano ad agenzie che a loro volta li facevano adottare in Europa; o, ancora, le decine di migliaia di poverissimi convinti con truffe e inganni a emigrare nei paesi del Golfo, dove gli veniva ritirato il passaporto e dove restavano schiavi dell’edilizia anche cinque o sei anni. Ah, credo che non ci sia gradinata di uno degli stadi costruiti per i mondiali del Qatar che non contenga sudore e sangue di quei nepalesi.
Una volta, per caso, due di queste vergogne mi si sono intrecciate davanti, in una storia tuttavia a lieto fine. Deepak, un ragazzo che mi era stato venduto dalla malavita come “donatore” di reni (e che al termine della mia inchiesta avevo ovviamente riportato a Kathmandu intatto), dopo un paio d’anni aveva finito i soldi e quindi si era fatto turlupinare da un’agenzia di lavoro in affitto. Caricato su un aereo per gli Emirati, lo avevano messo a lavorare sedici ore al giorno in cambio solo di cibo e una branda in una baracca. Era scappato di notte, lo avevano preso per strada e rinchiuso in un capannone con altre dozzine di fuggitivi. Lì gli era stata concessa una telefonata e lui aveva chiamato un nostro amico comune – nepalese, benestante, alfabetizzato – il quale a sua volta aveva telefonato a me per chiedermi se potessi fare qualcosa dall’Italia. E io sì, avevo fatto qualcosa, abusando di quelli che erano di sicuro privilegi di casta: ho chiamato la Farnesina, sono riuscito a parlare con una sottosegretaria del PD che mi conosceva di nome avendomi letto sull’Espresso, la sottosegretaria a sua volta aveva chiamato non so chi nel Golfo sostenendo che il ragazzo arrestato era un collaboratore di un’importante testata giornalistica italiana. Insomma con un po’ di fortuna e di balle, quarantotto ore dopo Deepak era su un volo per Kathmandu, libero, con tanto di passaporto. Ovviamente, tutto molto ingiusto per gli altri deportati – quelli senza santi in Farnesina – ma non mi vergogno di averlo fatto. Quando torno in Nepal chiedo sempre di lui: il mese scorso mi hanno detto che ora fa il rider per Tarkari, una specie di Glovo locale – sempre proletario, quindi, ma con entrambi i reni e lontano dai lager emiratini.
Sempre proletario, Deepak, ma non solo lui, anche perché in quasi vent’anni di repubblica e democrazia la crescita del PIL è stata bruscamente interrotta due volte: prima per il catastrofico terremoto del 2015 e poi, soprattutto, per il covid, che ha azzerato gli introiti dal turismo per due anni.
Un po’ di ricchezza però è arrivata, rispetto al 2006, ma si è riversata tutta su una fascia attorno al dieci per cento della popolazione – i miei vicini al ristorante con i tetti spioventi. Il restante 90 per cento si sente (e in parte è) povero come prima, quindi vive con rabbia il confronto con India e Cina, i due giganti le cui economie corrono molto più in fretta senza procurare grandi vantaggi al loro piccolo vicino. E dal Nepal ogni anno emigrano centinaia di migliaia di persone, che nel 2025 potrebbero superare il milione. I più poveri vanno sempre a fare gli schiavi nei paesi del Golfo, le famiglie con un po’ di soldi spediscono i figli in India, Malesia, Singapore, quando va bene anche Giappone ed Europa.
Qualcosa è andato storto, dunque, da queste parti. Sì, ma cosa? Due dei miei amici di lì, il giovane ingegnere informatico Rahul e il cinquantenne imprenditore Sudarshan, hanno entrambi pochissimi dubbi: è stata la corruzione, insieme al consociativismo politico che ha creato un’élite di malaffare trasversale a tutti i maggiori partiti – il Congresso, i sedicenti Marxisti-leninisti, i sedicenti Maoisti, più altri centristi. In gran parte collusi, mi dicono, con un mondo degli affari fatto soprattutto di edilizia selvaggia (oggi la valle di Kathmandu è un oceano di cemento) e di grandi progetti turistico-alberghieri ad alto target. Il tutto spesso al limite della legalità e unto da pesanti bustarelle.
È questo il contesto in cui ho visto scoppiare il movimento Gen Z, quello che ha riportato il Nepal sulle prime pagine dei quotidiani occidentali. Sono ragazzi di vent’anni o poco più che la rivoluzione del 2006 non l’hanno mai vista, che se non sono ancora emigrati pensano di farlo, che considerano i vecchi partiti tutti uguali e corrotti, che vedono il vicino indiano correre mentre il Nepal sta fermo. «La sommossa è stata inaspettata solo per chi non si è accorto di quello che stava succedendo da tempo», mi scrive Yagya, che chiude i suoi messaggi con gli hashtag #gen-Z (cioè loro, i giovani scesi in piazza) e #nepokids, che invece è l’etichetta affibbiata all’avversario, alla cupola di nepotismo. Yagya è contento della nuova premier ad interim, un’anziana e stimata giurista lontana dai partiti e benvoluta dagli studenti, ma alle elezioni anticipate di marzo pensa che voterà per Balen, un rapper diventato famoso su YouTube, «né di destra né di sinistra», buddista, contro tutti i partiti, autore di brani di denuncia sulla corruzione. Tre anni fa è entrato in politica e, da indipendente, ha vinto a sorpresa la corsa a sindaco di Kathmandu, surfando su un’ondata antisistema che forse ricorda qualcosa anche a noi.
– Leggi anche: Chi sono i giovani che protestano in Nepal
“Balen” in realtà è solo un nickname, per quanto in Nepal tutti lo conoscano così. All’anagrafe il sindaco-rapper fa Balendra Shah, un cognome che evoca aristocrazia e antiche dinastie, di cui quindi è stato opportuno sbarazzarsi. Ha 35 anni, cioè la metà dell’ex guerrigliero maoista Prachanda, che dal palazzo ha condannato con sdegno la rivolta delle settimane scorse. Balen invece si è schierato con i ragazzi, inondando di post i social network appena questi sono stati riattivati, alla fine della vittoriosa rivolta. La cui miccia è stata proprio la stupidissima decisione del governo di censurare i servizi social e di messaggistica, considerati pericolosi serbatoi di malcontento dei nepalesi esclusi dalle consorterie politico-affaristiche. A quel punto, per paradosso, i temuti tumulti sono scoppiati proprio contro la censura digitale, con tanto di palazzi delle istituzioni a fuoco, scontri di piazza, una cinquantina di morti e infine la retromarcia del governo, che si è dimesso liberando tutto – WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube, Telegram, Viber e così via.
E qui forse c’è bisogno di una piccola spiegazione finale, per provare a capirne un po’ di più. Grazie ai device indiani o cinesi a basso costo e a una rete internet efficiente (pure quella creata dai vicini del sud) quasi il 50 per cento della popolazione nepalese vive e comunica con gli smartphone. Non male, considerando che prima il servizio di telefonia fissa era fragile e riservato a pochi. E non male per un paese dove l’analfabetismo è ancora attorno al 30 per cento. Il risultato è che oggi, in Nepal, internet è tutto o quasi per milioni di persone, comprese quelle che non fanno politica. Ad esempio, quando sono salito su un tuktuk a pedali, nel quartiere di Thamel, il conduttore vestito di stracci ha cercato l’indirizzo della mia meta con Google Maps sul telefonino attaccato al manubrio del suo catorcio. Ogni nepalese, poi, ha almeno un parente che lavora all’estero, quindi le famiglie si possono ritrovare solo in videocall. Ci sono coppie di coniugi che portano avanti il loro matrimonio così da anni, il marito nel torrido deserto del Golfo e la moglie all’ombra fresca dell’Himalaya.
E quando un mese fa sono andato a vedere la cerimonia per il dio Shiva, sul fiume Bagmati, mi sono accorto che migliaia di cellulari la riprendevano non per i loro proprietari ma per farla vivere in diretta anche a un cugino, un fratello o un figlio, chissà se a Dubai, Vancouver o Melbourne. Nel loro minuscolo riquadro sul monitor, i nepalesi lontani sembravano felici e inebriati di sentirsi in qualche modo ancora lì con noi, al tramonto, tra le pire del tempio di Pashupatinath, mentre i bambini con i piedi nell’acqua cercavano un gioiello o un dente d’oro delle persone appena diventate cenere.
– Leggi anche: In Asia le proteste le fanno i giovani