Non è così facile evitare i dazi spostando le aziende negli Stati Uniti
Le regole consentono di delocalizzare parte della produzione, ma servono soldi, tempo e soprattutto certezze, che Trump tende a non garantire
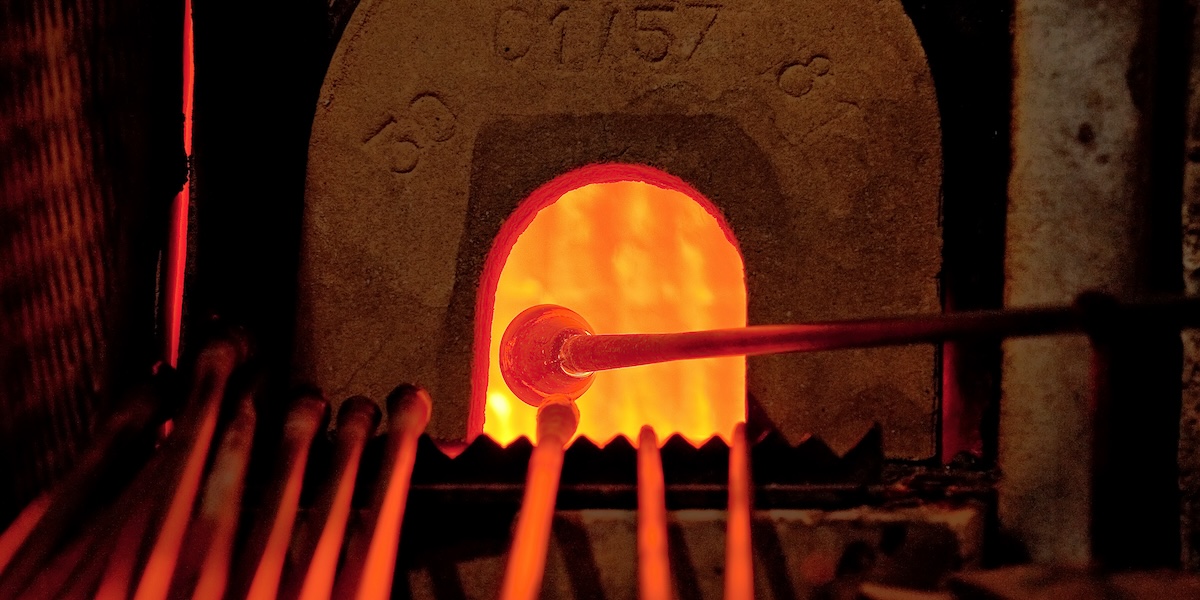
Già dall’inizio dell’anno, quando il presidente statunitense Donald Trump iniziò a minacciare dazi sull’importazione delle merci dall’Unione Europea e dal resto del mondo, molti imprenditori italiani si sono messi a studiare possibili contromosse per evitare un aumento dei prezzi dei loro prodotti e un’inevitabile riduzione delle vendite e degli affari. La soluzione più ovvia è tra l’altro auspicata dallo stesso Trump: per evitare i dazi si può spostare parte della produzione negli Stati Uniti aprendo lì nuove aziende, oppure acquisendo aziende americane. Servono però tempo e molti soldi, due risorse che non tutte le aziende italiane hanno. «Ci vogliono anni di lavoro: non si deve valutare a caldo», ha detto alla Stampa Simone Crolla, consigliere delegato della Camera di Commercio americana in Italia.
In questo momento è molto complicato programmare investimenti così importanti soprattutto perché mancano certezze: gli annunci di Trump sono improvvisi, spesso contraddittori e non definitivi, non basati su informazioni e dati attendibili. Nemmeno le eventuali conseguenze sul lungo periodo sono così chiare.
Le regole doganali dicono che per evitare i dazi non serve spostare tutta la produzione: basta dimostrare che la “componente essenziale” della merce che si vuole esportare venga prodotta nel paese di destinazione. I dazi europei sulle auto cinesi, per esempio, hanno convinto BYD ad aprire due stabilimenti in Turchia (che ha un accordo doganale per cui non paga i dazi per le esportazioni nell’Unione Europea) e Ungheria: le auto prodotte da BYD in questi due stabilimenti, realizzate con moltissimi componenti inviati dalla Cina, evitano il dazio del 17 per cento introdotto dall’Unione Europea alla fine di ottobre.
Allo stesso modo un’impresa può scegliere di spostare parte della produzione in paesi a cui gli Stati Uniti hanno imposto un dazio inferiore rispetto all’Unione Europea, come il Regno Unito che dovrà sopportare solo il 10 per cento. Negli ultimi giorni i giornali hanno parlato molto anche della possibilità di sfruttare i dazi al 10 per cento imposti a San Marino, tuttavia non è così semplice aprire una nuova azienda a San Marino, banalmente perché è uno Stato con un territorio molto piccolo.
L’alternativa all’apertura di un nuovo stabilimento all’estero è comprare una piccola o media società americana dello stesso settore per spostare parte della produzione. In questo modo si evitano molti passaggi: la ricerca di un posto dove delocalizzare, le autorizzazioni, la ricerca di personale, l’acquisto o lo spostamento di macchinari, il trasferimento di competenze dall’Italia. Il governo americano sostiene programmi di investimenti mirati: uno si chiama SelectUSA e aiuta le società estere a scegliere lo Stato americano migliore dove investire e garantiscono incentivi fiscali, investimenti a fondo perduto e contributi per la formazione dei lavoratori.
Secondo i dati diffusi dal centro studi di Confindustria e aggiornati al 2022, le multinazionali italiane che hanno sedi negli Stati Uniti sono 3.194 e danno lavoro a poco più di 156mila persone, di cui 75mila nell’industria e 80mila nei servizi.
Crolla ricorda il caso del pastificio Rana, che nel 2012 aprì il primo stabilimento negli Stati Uniti, a Chicago. Oggi gli stabilimenti sono due, con circa mille addetti, ed è stato comprato un terreno per costruirne un terzo, sempre a Chicago. Nel 2023 Rana ha raggiunto un fatturato di 602 milioni di euro negli Stati Uniti, metà del fatturato mondiale. «Quando Rana decise di costruire il suo stabilimento a Chicago lo fece alla luce di analisi di mercato chiare e impiegò due anni per renderlo operativo», ha detto Crolla. Anche per un’azienda strutturata come Rana, quindi, non è stato semplice aprire negli Stati Uniti.
Le aziende italiane più grandi si sono già attrezzate anni fa, molte durante il primo mandato di Trump. Nel settore della componentistica delle auto, uno dei più rilevanti per l’export negli Stati Uniti, tutti i gruppi più importanti hanno già stabilimenti negli Stati Uniti: Pirelli (pneumatici), Brembo (freni), Marelli (componenti elettriche, illuminazione, sospensioni), Sogefi (sospensioni), Landi Renzo (impianti GPL), Brugola OEB (viti).
Anche grandi aziende controllate dallo Stato hanno delocalizzato una parte della produzione negli Stati Uniti: nel 2008 Leonardo, azienda specializzata nelle tecnologie per la difesa e nelle armi, e di cui il maggior azionista è il ministero dell’Economia, comprò l’americana Drs Technologies, ora chiamata semplicemente DRS. Negli Stati Uniti Leonardo è arrivata ad assumere circa ottomila dipendenti: il fatturato americano è di 3,2 miliardi di euro. Fincantieri ha invece quattro cantieri con circa tremila dipendenti: negli Stati Uniti è uno dei principali costruttori di navi di medie dimensioni e lavora per la Marina militare e la Guardia costiera.
C’è poi un intero settore per cui delocalizzare è impossibile o quasi o comunque marginale: la produzione agroalimentare è infatti legata per definizione al territorio italiano.
«L’Italia non può permettersi di farlo perché il nostro è un saper fare strettamente legato al territorio, cioè alla cultura e al paesaggio che esso esprime», ha detto al Sole 24 Ore Gianpiero Calzolari, presidente del gruppo Granarolo che ha uno stabilimento in Connecticut dove produce ricotte, mozzarelle e burrate. Gli affari del gruppo sono però concentrati in Italia: dagli Stati Uniti arrivano solo 30 milioni di euro sul totale del fatturato, che è di 1,6 miliardi. «I dazi di Trump ci potranno colpire, sì, ma in modo non importante», ha detto Calzolari, che ha anche offerto una prospettiva piuttosto inedita per chi fa impresa: «Se i dazi aumentano i costi bisogna ridurre i costi altrove, anche sapendo sacrificare la marginalità», ossia accettare di guadagnare di meno.



