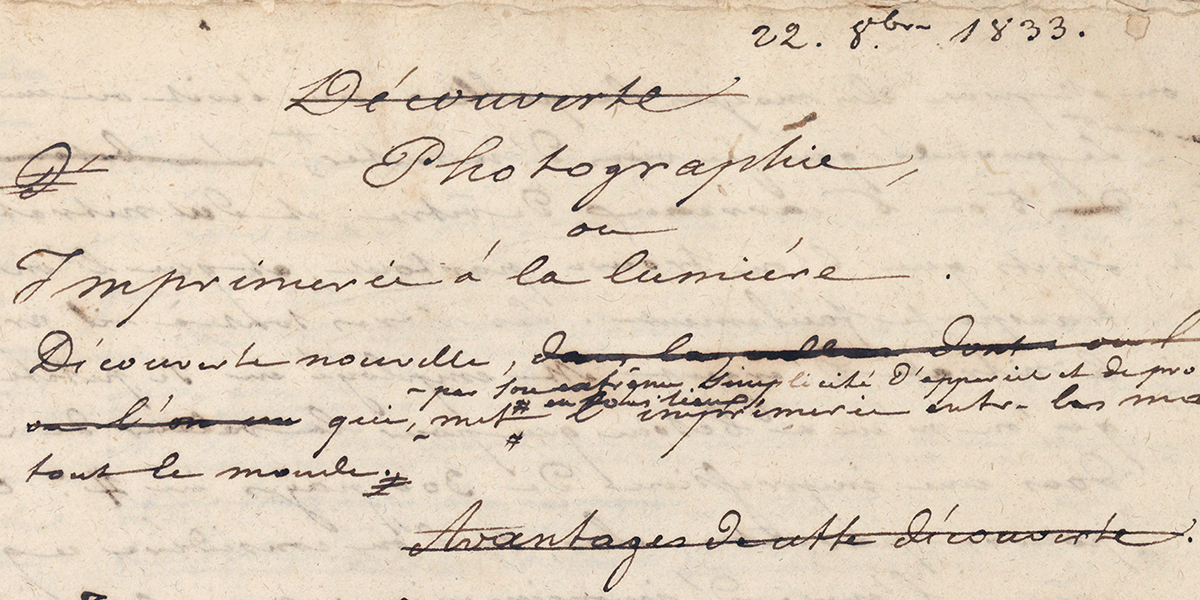Contro il messaggio
«Romanzi con un “messaggio” più o meno esplicito sono stati scritti (basti pensare al realismo socialista) e vengono scritti tutt’oggi. Ma leggere pensando che l’autore avesse in mente fin dall’inizio una replica a qualche grande domanda, e l’abbia distillata in forma romanzata, è un modo di leggere che non riesco nemmeno a concepire. Quale sarebbe il messaggio delle "Memorie di Adriano", o di "Gita al faro"? E di "Anna Karenina"? "Non suicidatevi"? E della "Metamorfosi"? "Non trasformatevi in insetti"?»

Nel pubblico dei festival letterari o delle presentazioni di libri c’è sempre una piccola ma tenace minoranza che chiede all’autore quale sia il “messaggio” del suo romanzo. Allergico a una visione per cui il testo è un mezzo e non un fine in sé, mi sono sempre affrettato a dire che no, non c’è assolutamente nulla di simile nei miei libri; e del resto lavorare per anni a un romanzo mi pare un metodo alquanto laborioso per fare quel che si può fare con qualsiasi profilo social. Talora mi capita di citare una battuta di Nabokov («Se avessi voluto mandare un messaggio avrei fatto il postino»), tutti ridiamo, e finisce lì.
Ma forse la domanda nasconde qualcosa d’altro. Resto convinto della conclusione — ogni retorica del “messaggio” è di per sé dannosa — ma vorrei saperne di più sulla premessa; indagare le ragioni di un modo di leggere che ai miei occhi appare tanto sbagliato.
Perché c’è un dettaglio sorprendente: la domanda mi è stata posta da intervistatori maldestri (ricordo uno che la propinò a Michele Mari durante il tour del Campiello 2014, provocando la sua costernazione) ma anche e soprattutto da persone sinceramente innamorate della letteratura. Affermare che esse abbiano sempre letto male è assurdo: deve esserci sotto qualcos’altro. Ma cosa?
Prima di tutto occorre esplorare questa entità opaca, il “messaggio”.
Detta in modo un po’ spiccio, le storie si muovono da un inizio a una conclusione dove si risolve un conflitto e si getta luce su un tema particolare. Nel corso di questo viaggio i personaggi avranno subito una metamorfosi cognitiva e personale, senza produrre risposte definitive a particolari domande ultime, ma piuttosto incarnandone l’urgenza. Essi non sono “tipi” o esempi di categorie — lo Studente, l’Imperatrice, la Manager — ma singole vite finzionali, che devono cavarsela come noi poveri mortali con mezzi limitati e conoscenze lacunose.
– Leggi anche: Per una storia universale delle trame
Insomma: non leggiamo Dostoevskij per sapere che uccidere le persone è sbagliato; ma leggendolo ascoltiamo le ragioni dell’assassino. La buona letteratura mette alla prova i limiti della nostra flessibilità immaginativa attraverso quel che chiamerei un’odissea morale senza approdo a Itaca. Non può fornire un terreno solido per l’etica, semplicemente perché non è attrezzata per farlo; e il desiderio contemporaneo di ricavarne una mappa per comportarsi meglio nasconde forse una protervia: la volontà di imporre alla letteratura quel che noi pensiamo già sia meglio.
Ma se potessimo influire sul fato dei personaggi, ha scritto Umberto Eco,
«sarebbe come andare al banco di una agenzia di viaggi: “Allora dove vuole trovare la Balena, alle Samoa o alle Aleutine? E quando? E vuole ucciderla lei, o lascia fare a Quiqueg?” La vera lezione di Moby Dick è che la Balena va dove vuole». Questa libertà può irritare anche il lettore benintenzionato, ma è il punto di partenza per qualsiasi forma d’arte. Potete dire che Melville vi disgusta ma non potete cambiare la rotta della Balena — né sperare di ricavare messaggi evidenti dal suo vagare.
Ciò ovviamente non vuol dire che Moby Dick sia privo di significati; ne è anzi intriso fino a scoppiarne. Se però è questo che i lettori in questione hanno in mente, un significato, allora si tratta solo di vaghezza lessicale: il loro “messaggio” non sarebbe altro che il tema principale della storia, l’oggetto dell’indagine narrativa: l’amore, la malattia, il terrorismo, l’esilio, la pace; una risposta alla domanda “Di cosa parla questo libro?”.
Ma dubito che sia l’interpretazione corretta. È più probabile che per “messaggio” i suddetti lettori intendano un precetto di vita facilmente estraibile dal testo — una risposta a cosa siano l’amore o il terrorismo o l’esilio, e come ci si deve comportare in questi casi. L’odissea morale è obbligata a concludersi: ecco affiorare l’Itaca di una norma: sotto la coltre narrativa deve pur esserci qualcos’altro, e allora chiediamo all’autore cosa sia questo “qualcos’altro”. Che ce lo dica una volta per tutte.
Condivido il timore di fondo che le storie, senza un “di più”, siano oggettini innocui. Non lo sono, non dovrebbero esserlo: la posta in gioco che offrono le migliori fra esse ha una caratura immensa. Ma leggere un romanzo pensando che l’autore avesse in mente fin dall’inizio una replica sferzante a qualche grande domanda, e l’abbia distillata in forma romanzata, è un modo di leggere che non riesco nemmeno a concepire.
Del resto, quale sarebbe il messaggio delle Memorie di Adriano, o di Gita al faro? E di Anna Karenina? «Non suicidatevi»? E della Metamorfosi? «Non trasformatevi in insetti»? In quest’ottica tutti i problemi stilistici e strutturali — tutto ciò che fa la pratica quotidiana della scrittura, ovvero la frizione tra l’idea e la lingua — sono inghiottiti o ritenuti secondari; il mero piacere della lettura inteso come sottoprodotto; la complessità estetica del testo, cancellata: la narrativa stessa finisce per essere un veicolo.
Certo, romanzi con un “messaggio” più o meno esplicito sono stati scritti (basti pensare al realismo socialista) e vengono scritti tutt’oggi. Forse vi agisce anche un’eco del passato: prima del terremoto romanzesco le storie — non solo le fiabe, ma anche l’epica classica — contenevano un modello di comportamento ed erano usate per scopi educativi. Il fatto che ancora oggi si chieda un messaggio può avere a che fare con il modo in cui è insegnata la letteratura a scuola (lo scrittore vuole dirci questo: conta più l’intenzione del testo) o con il rimpianto per la missione didattica della narrazione.
– Leggi anche: Le fiabe sono più antiche di quanto pensiamo
In ogni caso dobbiamo ricordare che un terremoto è di fatto avvenuto, e difficilmente si può rivestire il romanzo moderno di compiti arcaici; gli esiti del realismo socialista sono ancora un buon monito. Insomma, concordo con Javier Cercas quando afferma, nel suo saggio Il punto cieco, che i romanzi sono un genere «che si prefigge di proteggere le domande dalle risposte». Tuttavia ancora non siamo venuti a capo del problema. Come ho detto ci sono lettori appassionati e attenti, che colgono chiaramente il valore estetico di un’opera finzionale (leggendola come tale e non come un saggio di auto-aiuto) i quali tuttavia chiedono conto del “messaggio”. Perché?
– Leggi anche: La fine della fine
Ho solo ipotesi, e forse nemmeno troppo convincenti; ma proviamoci.
Da un lato mi pare ci sia una surrettizia riduzione dell’arte a bene etico, forse perché cerchiamo ideali e risposte a bisogni profondi quando la politica non è più in grado di darle. (Aggiungo: il fatto che una nicchia chieda tali risposte al romanzo, fidandosi così tanto di esso, mi riempie di commozione benché ritenga sbagliato l’approccio).
Dall’altro lato abbiamo alcuni autori che seguono questa tendenza — in ottima fede o per opportunismo — dimenticando però che il primo dovere di uno scrittore, in quanto scrittore, dovrebbe essere quello di scrivere bene e non di prendere posizioni nette in ambito finzionale. Promuovere la migliore delle cause non genera automaticamente narrativa migliore. Persino Jean-Paul Sartre, di certo non un amante dell’art pour l’art, consigliava ironicamente agli autori contemporanei di
«lanciare dei messaggi, cioè di limitare volontariamente i propri scritti all’espressione involontaria dell’animo. […] Devono, prima di tutto, disarmare i loro ragionamenti, come ha fatto il tempo con quelli dei classici; i ragionamenti, poi, si riferiranno a temi che non interessano nessuno o a verità tanto generiche, che i lettori ne siano già convinti in partenza; le idee, sembreranno profonde, ma a vuoto, e formulate in modo da potersi spiegare con evidenza mediante un’infanzia infelice, un odio di classe o un amore incestuoso. E non si azzardino a pensare sul serio: il pensiero nasconde l’uomo ed è proprio l’uomo che ci interessa». [da “Che cos’è la letteratura”, 1947]
Ma il romanzo moderno non è nato per esprimere sé stessi né per fornire verità definitive: è per mettere alla prova quelle verità che apparivano, appunto, incrollabili e in mano a pochi. È nato con l’invenzione di un hidalgo spagnolo che pensava di essere un cavaliere errante, rifiutando il mondo intero e i suoi nudi fatti, primo fra tutti il nome: addio Alonso Quijano, benvenuto Don Chisciotte. La sorprendente comicità tinta di malinconia del capolavoro di Cervantes è il segno di un neonato scetticismo; la sua magnifica sovrabbondanza, il suo rifiuto di stringere il personaggio nel cappio dell’allegoria, è il segno di una libertà festosa che porta a compimento quella di Boccaccio.
Milan Kundera lo disse bene nei Testamenti traditi: «Sospendere il giudizio morale non costituisce l’immoralità del romanzo bensì la sua morale. Una morale che si contrappone alla inveterata pratica umana che consiste nel giudicare subito e di continuo tutto e tutti, nel giudicare prima di e senza aver capito».
Mi rendo conto che oggi si tratta di una posizione minoritaria, e che può facilmente essere scambiata per volgare disimpegno. Ma perché chiedere ai libri di essere impegnati, e non alle persone con la loro pratica quotidiana?
– Leggi anche: Ispirato a una storia vera
Cercando un “messaggio” si rischia di pensare che gli scrittori — in quanto scrittori, lo ripeto — abbiano sempre una risposta netta su un dato tema, e si finisce col prenderli per qualcos’altro: vati, politici, sociologi, opinionisti o preti. (Offrendo così altra legna al già enorme falò del loro ego). Allora la bussola morale che si può trarre da un’opera conta più dell’opera stessa. La forma è abbandonata. Content is king, come amano dire gli esperti di marketing: e più è prescrittivo, meglio è.
Lo dico con la massima chiarezza di cui sono capace: tutto ciò non significa affatto che siamo destinati al puro relativismo morale, o che non dobbiamo lottare per ciò che è giusto. Dobbiamo farlo. Semplicemente non sento l’obbligo di difendere questa verità — tantissimo pretesa, poco praticata — piegando la letteratura a scopi che non le pertengono; così come da lettore non mi irrito se un libro mi lascia sospeso nell’ambiguità. Perché mai? Voler essere imboccati con una verità preconfezionata è un infantilismo che ci spoglia del dovere di interrogare le pagine, e della libertà — e responsabilità — di trarne una nostra idea.
La letteratura offre certamente un tipo di conoscenza ed è in grado di illuminarne i tratti più nascosti dell’umano, siano essi orrendi o deliziosi: ma si tratta di una conoscenza altamente problematica, sempre sfuggente, che non può essere imbrigliata in formule: l’esatto contrario del “messaggio”, parola che propongo di cancellare dal nostro vocabolario di lettori — o almeno di trattare con la massima attenzione.
– Leggi anche: C’è reale e reale, coi libri