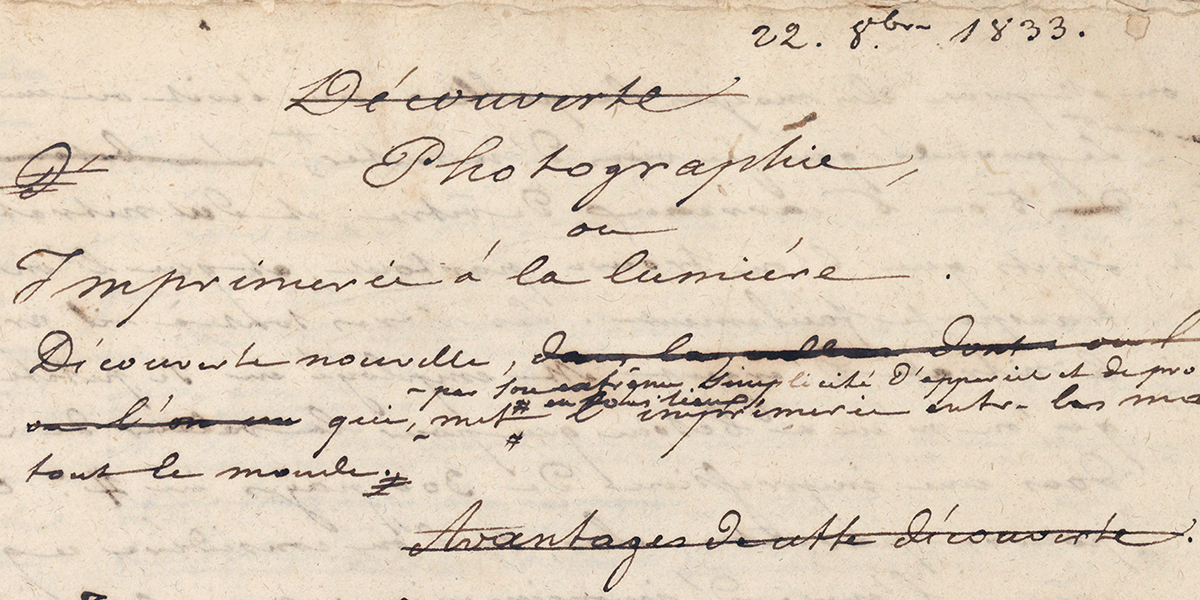Come parlano d’amore e di sesso le ragazze e i ragazzi
«Fuori le cose stanno cambiando. Dentro la fluidità, la parità dei diritti (e dei compensi) tra uomini e donne, il femminismo e l’inclusività non ci sono. Quella che ascolto ogni giorno tra i banchi è una robusta prassi linguistica che sconfina nel moralismo e in un sessismo inconsapevole e pericoloso perché agito come se fosse naturale, come se tutti i discorsi che vengono dall'esterno non fossero un’alternativa da prendere in considerazione»

Non ho mai saputo realmente cosa fosse la scuola finché, tremante, non ho messo piede in una classe. Solo in quel momento le ragazze e i ragazzi per me non sono stati più incomprensibili. Certo, ascoltando le loro confidenze, i loro scambi, le battute, il modo in cui spontaneamente si esprimono per definire sé stessi in relazione agli altri – laddove in relazione agli altri significa nell’amore, nel sesso e nell’amicizia – mi sono sentita profondamente disorientata. Il principio di realtà si è imposto in tutta la sua ferocia.
Il mondo esterno continua a sembrarmi diverso da quello che vedo ogni giorno in classe. E questo anche se l’incanto che provo al cospetto della gioventù è pari allo stordimento che mi dà il profumo della Nutella: quando parlano dei loro amori, tendo a dimenticare come ne parlano. Li guardo ipnotizzata, ho un acquario nella testa, i pesci che nuotano placidi dietro gli occhi. Creature perfette che, però, con le parole continuano a innalzare muri e agganciare catene, invece di sottrarsi alla ferita del possesso e della paura.
Fuori è evidente che le cose stiano cambiando: la fluidità, la parità dei diritti (e dei compensi) tra uomini e donne, il femminismo e l’inclusività, le riflessioni sul maschile sovraesteso permeano i dibattiti della nostra vita quotidiana. Ma è una vita che la gran parte di noi non conduce a scuola. Dentro, nelle relazioni e nella scelta delle parole, mi sembra resista tra i giovani una robusta prassi linguistica che sconfina nel moralismo e nel sessismo. E mi pare un fenomeno trasversale, in cui c’entrano poco la classe sociale e il territorio: a certe routine linguistiche i ragazzi sono abituati.
Chi pensa e parla male vive male, e Wittgenstein ha ragione quando sostiene che i limiti del nostro linguaggio – e quindi del modo in cui nominiamo la realtà che ci circonda – sono i limiti del nostro mondo. Per questo sono sempre più convinta che la scuola sia il posto in cui stare e che entrare in classe sia il primo atto politico. Il secondo, però, il più difficile, è insegnare alle ragazze e ai ragazzi una lingua nuova. Quello che vedo e ascolto ogni giorno tra i banchi non è solo un moralismo di ritorno, bensì un inconsapevole sessismo. Sottolineo inconsapevole e aggiungo pericoloso proprio perché è agito come se fosse naturale, come se non ci fosse alternativa, come se tutti i discorsi sulla parità che vengono dall’esterno non fossero un’alternativa da prendere in considerazione.
I social giocano un ruolo fondamentale nelle relazioni degli adolescenti: la stragrande maggioranza delle mie studentesse e dei miei studenti fidanzati in età giovanissima – già a quattordici anni – dichiara con orgoglio di controllare il cellulare della propria ragazza (e del proprio ragazzo, ma con meno frequenza). I profili di coppia sono la regola: “marco_paola”, oppure “paola_marco”. La platea degli amici deve sapere che quelle persone sono blindate e che chiunque provi a scrivere in privato a uno dei due con intenzioni poco “specchiate” sarà sfidato a “duello”.
Lui ha quindici anni, ha il nome della madre tatuato sull’avambraccio sinistro – «perché il lato sinistro è il lato del cuore» – ed è talmente alto che quando mi guarda deve abbassare la testa. È fidanzato da un anno con una quattordicenne ed è geloso: lei non può vestirsi come vuole quando esce («E che la mando in giro con i pantaloncini corti? Così le guardano il culo! Non esiste. Poi mi tocca menare tutti.»), e deve mettersi una felpa che arriva almeno a coprirle il sedere, se è inverno, altrimenti una t-shirt larga e lunga. Lui e lei, formosa malgrado l’età, stanno sempre insieme. Anche lei gli fa scenate di gelosia, anche lui non può uscire da solo. Si controllano a vicenda i cellulari, perché non si sa mai, e poi «Giulia sta con me, e io voglio un figlio da lei». Hanno già rapporti sessuali e spesso non prendono precauzioni. Gli ho chiesto perché si comportasse così e lui mi ha risposto che è giusto, che le donne vanno protette e che lui protegge la sua donna. Ma forse il rapporto dovrebbe basarsi sulla fiducia, ho insistito. L’amore non può essere una gabbia. A quel punto si è inalberato. «E che la lascio andare in giro da sola? Ma su dai, professore’, con tutto quello che capita, una bella ragazza come lei non può andare in giro da sola, non può fare tardi la sera».
I genitori di lei lo conoscono e lo trattano come un figlio. «Quando esce con me loro si fidano». E, naturalmente, qualsiasi ragazzo si comporti in modo diverso è un coglione a cui piacciono le corna. E, naturalmente, le ragazze che sono fidanzate ma che escono con le amiche anche senza il fidanzato sono tutte poco di buono (uso un eufemismo). «Esce se glielo permetto. Gli devo dare il permesso io». Quel “gli” è testuale: nessuno prende in considerazione il “le” perché è faticoso ricordarsi la regola grammaticale. Tutto il gruppo di amici, a scuola e fuori, la pensa nello stesso modo. Il discorso che il ragazzo ha tenuto in classe quando mi ha spiegato le regole dei rapporti uomo-donna non è stato accolto da un’ondata di sdegno da parte delle studentesse. Anzi. I ragazzi gli hanno dato man forte, le ragazze annuivano perché «se un maschio non fa così vuol dire che alla ragazza sua non ci tiene».
Nella classe di questo ragazzo bello e alto c’è solo un’eccezione ed è la fidanzatina di uno dei suoi più cari amici, il quale viene benevolmente deriso per la disgrazia che gli è toccata, ossia innamorarsi follemente di una quattordicenne libera, che esce anche senza di lui, che va in gita scolastica e si addormenta sulla spalla di un suo compagno di classe, che se ne frega del fatto che il suo fidanzato la minacci di lasciarla se fa questa o quell’altra cosa. Lui ha quattordici anni, viene a scuola sempre con la camicia a maniche lunghe «perché sono più eleganti» e grosse cuffie wireless per ascoltare musica indie. Ma è disperato, la ama troppo, non vuole perderla ma ha paura che, assecondando la sua libertà, lei non avrà più bisogno di lui, incontrerà qualcun altro e se ne innamorerà. La parola più gentile che gli rivolgono i suoi amici è “cretino”. Certo, con affetto, con rispetto.
Il rispetto mi sembra un altro punto cardine delle loro relazioni con le donne, a partire dal loro rapporto con la madre. È la mia ragazza quindi la devono rispettare. La mia ragazza mi deve rispettare. È mia madre e se le manchi di rispetto poi te la devi vedere con me perché solo io posso permettermi di trattarla male. Il che vale anche per la loro ragazza. Postilla: il rapporto con il padre è spesso assente e nebuloso, quasi sempre conflittuale.
Dato che spesso la gelosia è considerata “prova d’amore” dalle ragazze, sono numerose le coppie fondate su una dinamica tossica e asfissiante: in una quarta liceo, le studentesse definivano “troie” le ragazze che andavano in discoteca con le amiche pur avendo un fidanzato. «Perché se vai in discoteca da sola e sei fidanzata ci vai per un motivo, mica per ballare». Ho chiesto chiarimenti a una di loro, capelli scuri, lisci e lunghissimi, la riga nel mezzo e le sopracciglia tatuate, e la risposta è stata: «Ci vai per rimorchiare. Non capisco perché il fidanzato non gliel’abbia impedito».
Gli studenti hanno annuito vigorosamente precisando che a loro non sarebbe mai successo, perché era una questione di rispetto: la fiducia andava bene, ma il rispetto era la prima cosa. E se lui era contrario, lei non poteva decidere liberamente. «Ma io lo faccio pure con il mio ragazzo», era intervenuta una studentessa. «Non esiste che vada in giro da solo». Alla mia obiezione secondo cui chiudere a chiave, sia pur metaforicamente, il proprio partner non garantiva la fedeltà, le risposte sono state due: «Deve stare attenta/o che non me ne accorgo, perché sennò…» oppure «No, no, si fidi, a me non può succedere».
Naturalmente, non mancano dichiarazioni – ironiche, beffarde, tonanti – contro l’omosessualità. «Oh, a me piacciono le ragazze, anche se non ce l’ho. Mica sono frocio», è la risposta più frequente che mi sento dare dai ragazzi che non sono fidanzati. L’omosessualità sembra ancora una diminutio, uno sfregio, un’offesa che marchia a fuoco la virilità – e quindi l’autorevolezza – degli adolescenti maschi. Nelle mie classi quasi nessuno tra gli studenti gay o le studentesse lesbiche si oppone a certe definizioni. Non hanno voglia di prendere posizione, non hanno voglia di scoprirsi. Essere gay è ancora difficile, più difficile che essere lesbiche, più che essere bisessuali. «Se Dio ha creato uomo e donna vuol dire che il buco giusto è uno solo», detto da ragazzi che hanno visto una chiesa per la prima e ultima volta durante il loro battesimo. Detto da ragazzi che, spesso, non sono nemmeno battezzati. Tutti uniti nell’unico scopo di allontanare da se stessi l’onta dell’omosessualità.
– Leggi anche: In Italia portare un preservativo in classe è molto difficile
Un’altra cosa che mi sembra di poter dire è che le studentesse e gli studenti di Roma sono tutti sorprendentemente collegati tra loro, i gradi di separazione sono al massimo due. La funzione non trascurabile dei social è anche quella di annullare le distanze socioeconomiche tra le ragazze e i ragazzi di zone diverse. Nella mia personale esperienza, alcuni miei ex studenti che vivono e studiano in quartieri più periferici e degradati di Roma sono buoni amici di altri miei ex studenti più fortunati (o per usare un termine che ultimamente va di moda nel mondo dell’istruzione, ma è utilizzato nel modo più sbagliato e offensivo possibile: privilegiati). Qual è il trait d’union? Conoscenze comuni, musica, locali, droga. Come mai uno studente di liceo di Roma Nord conosce lo studente di un istituto professionale di Roma Est? I social, le amicizie comuni, la droga. Anche per questa prossimità mi stupirei se vivessero le loro relazioni in modo completamente opposto.
Quando si parla di fluidità, di rispetto – nel senso più nobile del termine –, di libertà, ecco, ogni volta che si toccano certi argomenti io guardo alle ragazze e ai ragazzi. Perché sono loro a dover incarnare potenzialmente ogni declinazione della libertà, compresa quella dell’orientamento sessuale e dell’autodeterminazione. È una marea, quella di cui si parla e per cui ci si adopera fuori dalla scuola, e che ci si augura non arretri mai, perché è più forte della paura. Tuttavia, come in ogni rivoluzione, dentro esistono e resistono forze opposte, contrarie, pericolose, radicate nelle famiglie, nelle relazioni, nella miseria – senza indipendenza economica e senza istruzione non è possibile recidere i legami con la violenza, agita e subita, psicologica e fisica.
So che molti diranno: non è vero, non è così, nella mia scuola non succede, ai miei figli non succede. Sono pronta ad ammettere che per voi non è vero, che non è così, che nella vostra scuola non succede, che ai vostri figli non succede, e ne sono felice. Tuttavia, la prima regola di scrittura che il professor Bhaer insegnò a Jo March, in quel testo sacro che è Piccole Donne, fu: scrivi di ciò che conosci. E visto che io, tra le tre sorelle (escludo Beth buonanima), non posso che identificarmi nelle scelte di Jo, ossia nell’insegnamento, nella scrittura e nell’indigenza, mi attengo al racconto della mia esperienza decennale.
– Leggi anche: L’educazione sessuale in Cecoslovacchia e in Slovacchia