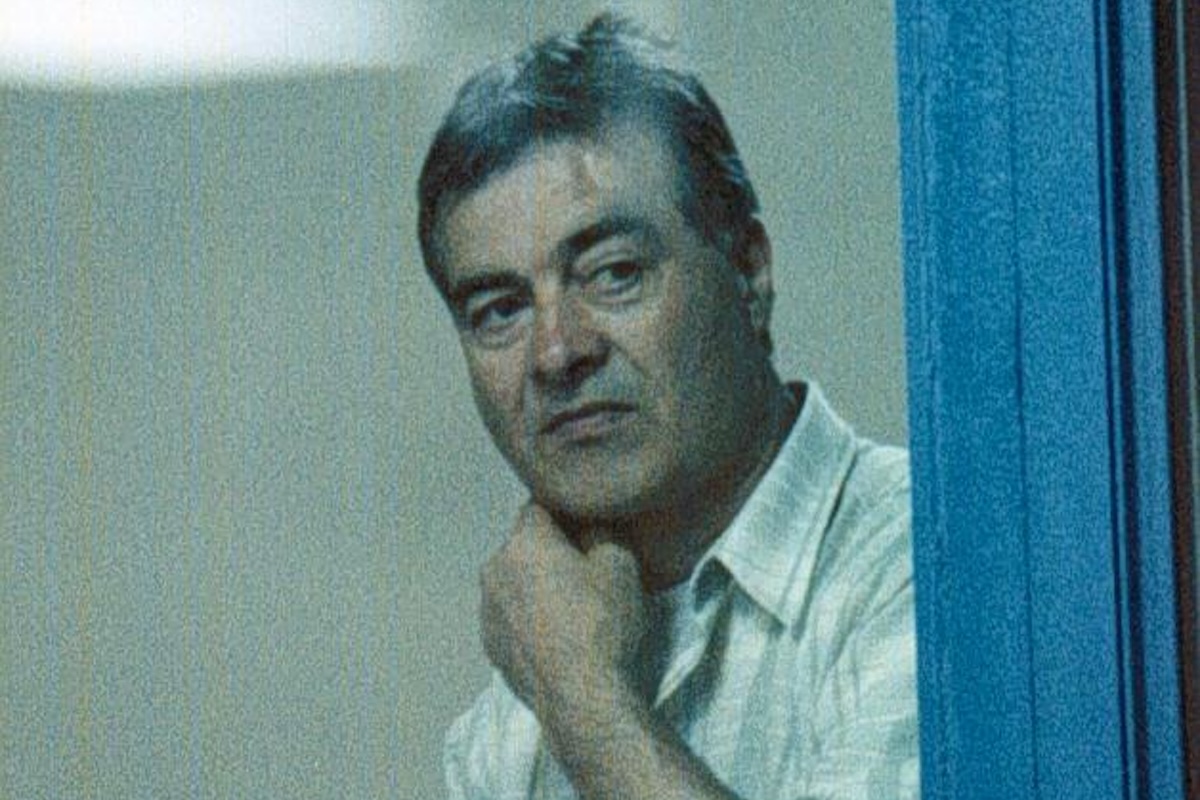Chi sono i cosiddetti “scafisti”
Spesso le persone che guidano le barche di migranti non c'entrano con i gruppi criminali che organizzano i viaggi, ma vengono lo stesso perseguite dalla giustizia italiana

Nei giorni successivi al grave naufragio avvenuto il 26 febbraio a Steccato di Cutro, in provincia di Crotone (Calabria), il governo guidato da Giorgia Meloni ha spiegato più volte di volere impedire gli arrivi via mare di migranti contrastando le attività di due figure: i trafficanti di esseri umani e i cosiddetti “scafisti”, un termine usato quasi solo quando si parla di immigrazione per definire persone che guidano le imbarcazioni o i gommoni su cui i migranti arrivano in Italia. Mentre i trafficanti, cioè le persone che organizzano questi viaggi, sono spesso assai difficili da individuare e processare, ogni anno in Italia vengono arrestati decine di cosiddetti scafisti.
Il problema è che la definizione stessa di scafisti è piuttosto generica, quindi controversa. Spesso in questa categoria finiscono persone che in realtà c’entrano poco o nulla con i gruppi criminali che organizzano i viaggi. Eppure, secondo diversi esperti di immigrazione, negli ultimi anni l’Italia ha dedicato molte risorse e attenzioni ad arrestare i cosiddetti scafisti, più per dimostrare un certo impegno nel contrastare l’immigrazione irregolare che per ottenere risultati concreti.
L’anno scorso BBC News raccontò il caso di un ragazzo senegalese 16enne, Moussa, che dopo essere arrivato via mare in Italia nel 2015 aveva passato più di un anno in carcere perché due persone che viaggiavano con lui l’avevano visto usare il timone dell’imbarcazione. Moussa aveva sostenuto la sua innocenza e a un certo punto era stato effettivamente rilasciato dalle autorità italiane: ma BBC raccontava che il suo processo era ancora in corso, sette anni dopo il suo arrivo.

(Carlos Gil/Getty Images)
Il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione, approvato nel 1998 e ancora in vigore, prevede pene fino a cinque anni per chiunque «promuove, dirige, organizza, finanzia» l’ingresso di migranti irregolari nel territorio italiano, ma anche per chi ne «effettua» il trasporto. Da anni le procure italiane interpretano questa norma in maniera molto ampia, processando centinaia di persone accusate di avere guidato, anche solo per un tratto o per un brevissimo periodo, una imbarcazione con a bordo migranti.
L’ultimo aggiornamento di un rapporto compilato da una serie di associazioni che si occupano di immigrazione, intitolato “Dal mare al carcere”, stima che nel 2022 in Italia siano stati arrestati circa 350 “scafisti”, un dato in linea con quelli osservati dal 2014 ad oggi. Il problema è che in molti casi le persone arrestate non c’entrano nulla con le organizzazioni che hanno organizzato il viaggio. «Le persone che guidano le barche lo fanno per un’ampia serie di motivi che sono difficili da semplificare», si legge nel rapporto: «ma di base sono l’ultimo anello di una rete molto più grande, i cui vertici rimangono nell’ombra. In più […] sono spesso anche loro migranti ai quali è stato impedito l’ingresso in Europa, e che rischiano le proprie vite per attraversare le frontiere».
Il rapporto individua quattro profili di “scafisti” di imbarcazioni dirette in Italia. I quattro profili hanno diversi gradi di responsabilità e collusione con i trafficanti veri e propri, che invece non partecipano ai viaggi.
Il rapporto distingue il “capitano per necessità”, cioè una persona che si assume la responsabilità di guidare l’imbarcazione durante un’emergenza (per esempio un guasto al motore); il “capitano forzato”, costretto con la violenza dai trafficanti a guidare l’imbarcazione perché magari ha esperienze di mare e sa come guidare una barca; il “capitano retribuito”, cioè quello che viene pagato dai trafficanti per guidare l’imbarcazione, e però spesso è un migrante a sua volta; e il “capitano dell’organizzazione”, spesso una persona esplicitamente collusa coi trafficanti che accompagna le imbarcazioni per un certo tratto e poi torna indietro, per timore di essere catturato.
Di queste quattro categorie solo una, l’ultima, ha legami solidi con l’organizzazione che pianifica il viaggio. Nella rotta che va dalla Turchia fino alle coste della Puglia o della Calabria, in cui spesso vengono utilizzate barche di piccole o medie dimensioni, vengono impiegati di frequente marinai esperti che provengono da paesi diversi da quelli delle persone che trasportano: nel 2022 per esempio sono stati arrestati come presunti scafisti 52 turchi, 14 russi e 9 ucraini. Le persone che si possono inserire nelle altre tre categorie hanno invece legami molto deboli, e il loro arresto non condiziona la stabilità dei traffici.

Una nave di migranti fotografata nel 2020 a Crotone, con un presunto scafista che cerca di governarla (ANSA)
In molti casi gli arresti dei cosiddetti “scafisti” seguono poi dinamiche piuttosto opache, che sembrano avere come obiettivo quello di trovare un responsabile a prescindere, piuttosto che accertare chi abbia davvero organizzato o facilitato il viaggio.
Nei principali porti di sbarco nel Sud Italia lavorano gli agenti di Frontex, la controversa agenzia di frontiera dell’Unione Europea. Durante uno sbarco il loro compito è anche quello di chiedere alle persone arrivate informazioni sui trafficanti. Spesso però i migranti arrivati in Italia non hanno alcuna informazione sul gruppo criminale che ha organizzato il loro viaggio, dato che si sono limitati a pagare una certa cifra a uno o più intermediari. Da qualche tempo quindi Frontex si concentra soprattutto nell’individuare i cosiddetti “scafisti”, cioè le persone che per le norme italiane possono essere incriminate di favoreggiamento dell’immigrazione irregolare.
Una persona appena sbarcata dopo un lungo viaggio concluso con un’operazione di soccorso, però, si trova in una posizione di estrema vulnerabilità. Le forze dell’ordine, che spesso comprendono anche Frontex, conducono interrogatori direttamente sulle banchine dei porti «senza nemmeno permettere che le persone sbarcate mangino o facciano una doccia». Lo ha raccontato alla rivista The New Humanitarian Emanuela Rosa Lo Faro, avvocata esperta di diritto degli stranieri e politiche migratorie. E se in questi casi le autorità individuano dei possibili “scafisti”, li «spaventano per estorcere una confessione», aggiunge Lo Faro.
Il giornalista Lorenzo D’Agostino, che si occupa da anni di immigrazione, ha raccontato che a volte i migranti vengono interrogati quando ancora si trovano a bordo della nave, «dopo aver rischiato di morire annegati e aver visto i cadaveri di persone con cui hanno condiviso il viaggio. […] Spesso risulta che venga fatta una proposta suggestiva di permesso di soggiorno in cambio di collaborazione con le autorità».
Interrogatori del genere hanno pochissima attendibilità: le persone appena sbarcate dicono qualsiasi cosa pur di soddisfare le richieste di una persona che in quel momento si trova in una posizione di potere rispetto a loro. A volte indicano persone che percepiscono come meno in grado di vendicarsi per un’accusa infondata: per esempio i minori non accompagnati.
Qualche anno fa il carcere minorile Bicocca di Catania aveva detto all’associazione Antigone che fra il 2012 e il 2016 aveva ospitato 52 ragazzi accusati di essere stati degli “scafisti”. «Molti di quei ragazzi erano semplici pescatori», ha spiegato più di recente all’Essenziale Elvira Iovine, volontaria al carcere minorile che lavora con la Fondazione Centro Astalli. «Conoscevano il mare e sapevano guidare la barca». «Gli veniva affidato un ruolo da leader nell’imbarcazione», ha raccontato la direttrice del carcere, Maria Randazzo, sempre all’Essenziale: «Distribuivano acqua, cibo, a volte guidavano, erano utilizzati per le loro competenze tecnologiche, perché sapevano magari usare il cellulare, perché parlavano inglese o francese e potevano farsi capire da tutte le persone a bordo. Ma non ne traevano alcun guadagno, non erano parte dell’organizzazione criminale».
In un breve documentario pubblicato da ANSA le giornaliste Cecilia Ferrara e Angela Gennaro, del collettivo Lost In Europe, hanno raccontato di Saidu Bangura, un ragazzo della Sierra Leone sbarcato in Italia poco prima di compiere 18 anni, quindi ancora minorenne. Bangura è stato processato come scafista perché era lui a guidare l’imbarcazione che arrivò in Italia: ma solo perché nella settimana prima della partenza i trafficanti libici l’avevano costretto con la forza a imparare sommariamente come si guidava una barca.
– Leggi anche: I corridoi umanitari non sono una soluzione per evitare i naufragi
Secondo dati del ministero della Giustizia italiano pubblicati da BBC News, e aggiornati a marzo del 2022, nelle carceri italiane vivono 952 persone accusate di favoreggiamento dell’immigrazione irregolare, delle quali 562 hanno già ricevuto una condanna. Sono numeri significativi, ma è difficile sostenere che questi arresti abbiano ridotto gli arrivi via mare organizzati dai gruppi criminali. Dal 2020 a oggi gli sbarchi sulle coste italiane sono in progressivo aumento.
Il problema è che i principali gruppi criminali che organizzano questi viaggi sono attivi soprattutto nei paesi di partenza, dove le autorità italiane ed europee non hanno giurisdizione, e in cui possono affidarsi solo alle autorità locali per ridurre questi traffici.
Nell’ultima relazione al parlamento del procuratore nazionale antimafia e dalla Direzione nazionale antimafia, pubblicata nel 2021, si legge prima di tutto che per ridurre questi traffici si «richiede un forte impegno politico e sociale, prima ancora che giudiziario»: sembra un richiamo implicito all’apertura di canali legali per le persone che vogliono trasferirsi in Italia da fuori dell’Unione Europea, che sembrano essere l’unico strumento per scoraggiare rischiosi viaggi via mare.
La relazione aggiunge inoltre che «un efficace contrasto del fenomeno della tratta richiede, infatti, per la sua complessità e diffusione a livello nazionale e transnazionale, un intervento multilivello in cui ruolo centrale assume la collaborazione dei paesi di origine delle vittime e dei trafficanti, ed una osmosi costante delle esperienze e delle informazioni». Al contempo, però, «sul piano strettamente giudiziario sia le indagini che le condanne per tratta di esseri umani sono di numero ridottissimo rispetto al dilagare del fenomeno».
In altre parole: per ottenere dei risultati nel contrasto al traffico di esseri umani verso l’Italia servirebbe una maggiore collaborazione dei paesi d’origine e di partenza. Al momento questa collaborazione non si è mai materializzata, e le indagini e le condanne di questo tipo sono assai rare.