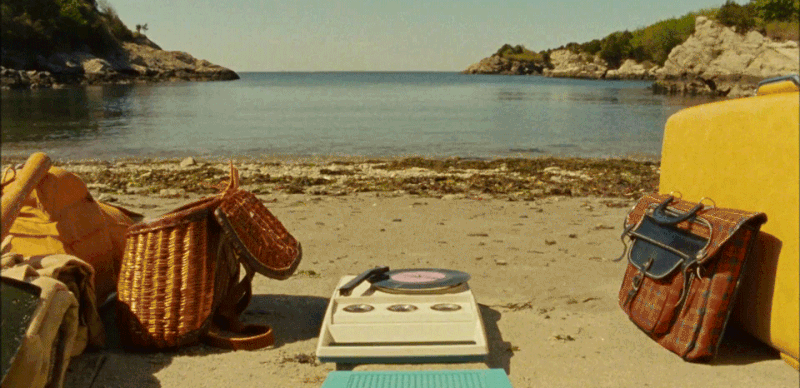Che futuro ha l’alta ristorazione?
La chiusura del Noma ha acceso un dibattito sulla sua sostenibilità economica ed etica, e circola un po' di pessimismo

L’annuncio della futura chiusura del ristorante danese Noma, considerato uno dei migliori al mondo e più volte indicato come migliore in assoluto dalle classifiche di settore, ha aperto un acceso dibattito sul futuro e sulla sostenibilità dell’alta ristorazione. Lo chef del Noma René Redzepi, nell’annunciare al New York Times la volontà di trasformare il suo ristorante in un grande laboratorio di cucina per la sperimentazione di nuovi prodotti e piatti, ha detto che l’intera industria dell’alta cucina dovrebbe essere ripensata, perché così «semplicemente non funziona».
Secondo Redzepi il fine dining, come viene definito nel mondo anglosassone il settore dei ristoranti di alto livello, da noi spesso chiamati “ristoranti stellati” (un riferimento alle stelle della guida Michelin), non è «economicamente ed emotivamente sostenibile». Non è il primo tra gli chef più famosi e quotati ad arrivare a questa conclusione: nel 2011 il ristorante El Bulli di Roses, in Catalogna, dello chef Ferran Adrià, a sua volta al tempo considerato il migliore al mondo, chiuse lamentando ritmi di lavoro troppo intensi e perdite economiche.
Il Noma in questi anni era diventato un riferimento: il suo stile, definito New Nordic, è stato molto imitato, le liste d’attesa erano molto lunghe, i riconoscimenti internazionali numerosi e costanti, i tavoli sempre pieni e il prezzo medio per una cena alto, intorno ai 450 euro senza vino. La chiusura di un progetto di élite del genere, o meglio la sua evoluzione verso un nuovo modello che non prevede la ristorazione classica, ha allarmato molti. Dana Cowin, ex direttrice della rivista specializzata Food & Wine, ha riassunto al magazine Bon Appétit un dubbio diffuso: «Se non riesce a renderlo sostenibile Redzepi, chi può farlo?».

René Redzepi, chef del Noma di Copenaghen (Getty)
La stampa statunitense, ma anche quella europea, si è chiesta se questa chiusura, e i motivi che ne sono alla base, siano l’inizio della fine dell’alta ristorazione, dopo un ventennio in cui questa aveva guadagnato uno spazio e una rilevanza mediatica senza precedenti.
Nel nuovo millennio gli chef più noti sono diventati personaggi televisivi e riferimenti culturali, l’alta cucina ha ottenuto riconoscimenti come “forma d’arte”, la ricerca gastronomica ha assunto contorni scientifici, le esperienze nei ristoranti più importanti hanno fatto nascere un turismo specializzato. Tutto questo è accaduto nonostante il modello economico alla base di questi ristoranti sia sempre stato piuttosto discusso e discutibile. E nonostante a lungo siano state ignorate, o messe in secondo piano, le questioni che Redzepi definisce «emotive», ma che è probabilmente più corretto definire etiche, e che riguardano cioè la retribuzione dei dipendenti, lo sfruttamento, gli orari eccessivi e gli ambienti di lavoro cosiddetti “tossici”.
Secondo quasi tutti gli esperti del settore, nonché i ristoratori che si sono espressi in queste settimane, la questione economica è piuttosto chiara: i ristoranti sono un business dai margini di profitto molto limitati, quelli di altissimo livello sono per lo più insostenibili, almeno basandosi sui proventi principali, i conti pagati dai clienti.
Luca Marchini, chef del ristorante L’Erba del Re di Modena, premiato dalla guida Michelin con una stella, spiega: «Tranne rare eccezioni, il fine dining da solo fa fatica a sostenersi, è sempre sul filo del rasoio. L’importante è che i conti non siano una tragedia, poi deve diventare il centro di un business più ampio, diversificato. Altrimenti è meglio chiudere».
Vito Mollica è chef dello Chic Nonna di Firenze, entrato fra gli “stellati” nella guida Michelin 2023, e dice: «Il ristorante non può essere più solo ristorante, deve diventare impresa e seguire i parametri dell’impresa. Fornire ciò che il mercato gli chiede e farlo seguendo una linea economica, che deve essere chiara anche a tutto lo staff. I conti non devono essere segreti, ma condivisi».
I motivi della difficile sostenibilità, nonostante i prezzi molto alti, risiedono nella quantità di ore di lavoro che servono mediamente per realizzare i piatti e quindi nella numerosa forza lavoro necessaria, nei costi per gli strumenti di lavoro, per le infrastrutture (affitti dei locali), per gli arredamenti e per le stoviglie, che vengono rinnovati con una certa frequenza per garantire un’immagine in evoluzione dei ristoranti. I prezzi crescenti dell’elettricità sono un fattore, così come parzialmente quelli delle materie prime (comunque non il problema principale, secondo gli addetti ai lavori). Al costo del lavoro e alla consistente tassazione dello stesso (quest’ultima una questione comune a tutti i settori imprenditoriali) si aggiungono le spese da sostenere per la formazione e la certificazione del personale, definite «in aumento» dagli chef italiani.
I ristoranti hanno bisogno di molte figure professionali che iniziano a lavorare molto prima degli orari di apertura: cuochi, assistenti cuochi, macellai, pasticceri, manager, custodi, imprese di pulizie. Al momento del servizio, si aggiunge altro personale in cucina e in sala: il Noma ha attualmente 100 dipendenti, solo negli ultimi mesi tutti retribuiti (ci torneremo). L’aumento delle dimensioni delle “brigate” (lo staff delle cucine) e delle ore di lavoro richieste (che possono facilmente arrivare a 15 al giorno) sono andati di pari passo con l’aumento della complessità dei piatti proposti. Il costante inseguimento della perfezione e della massima qualità, nonché la forte competizione nelle categorie del lusso, ha portato a un’esasperazione della ricerca e della complessità.
La volontà di sperimentare, differenziarsi dalla concorrenza, stupire, rendere il pasto un’esperienza completamente differente ed esaltare le proprie inclinazioni artistiche ha portato a preparazioni che semplicemente richiedono troppo lavoro. È stata molto citata la testimonianza di uno stagista del Noma che ha passato mesi a lavorare, nove-dieci ore al giorno, per creare perfetti finti insetti di pelle di frutta (una purea di frutta a cui viene tolta l’acqua).
Ma non è un caso isolato. Uno stagista del ristorante Astrid y Gastón in Perù, uno dei più importanti del Sud America, ha raccontato a VICE: «Dovevo preparare le mele per delle scaloppine. Andavano pelate, tagliate allo spessore di un foglio, poi ridotte a fiammifero e infine, dopo essere state misurate con un righello, ridotte a cubi matematicamente perfetti. Dopo dovevano essere messe sotto vuoto con uno sciroppo zuccherato al basilico, e infine mescolate con cubi simili di cipolla in una maionese alla vaniglia. Dovevo farne dieci litri al giorno e mi prendeva almeno metà turno: poi, quando assaggiavi il piatto finale, quasi non riuscivi a accorgerti che ci fossero quelle maledette mele».
From the menu – the rose terra cotta! A layered cake of berries, elderflower and roses with garden herbs. pic.twitter.com/CTXb4TnH4n
— restaurant noma (@nomacph) August 21, 2020
Un tale volume di lavoro rende quasi impossibile rendere profittevoli i piatti, anche quando non si estremizza la ricerca degli ingredienti come al Noma, dove si serve, ad esempio, un caramello di sangue di renna. Questa tendenza è stata definita da alcuni una deriva “eccessiva” della cucina, mentre altri ne sottolineano la componente di ricerca e artistica, sostenendo che andrebbe preservata. Ma tutti sono piuttosto concordi nel definirla anti-economica, almeno quando i dipendenti vengono pagati regolarmente.
Tano Simonato, chef del ristorante Tano passami l’olio, a Milano dal 1995 e “stellato” dal 2008, dice: «C’è troppo lavoro dietro, l’unica soluzione è un menù più semplice, e un rapporto corretto fra numero dei coperti e staff». Per Marchini semplificare però non è necessariamente la soluzione: «Lo può essere parzialmente, ma la ricerca dell’essenzialità non è sempre una strada semplice: alcuni tempi di preparazione non si possono ridurre, anche con un menù più contenuto, se si vuole fornire un’esperienza di un certo livello».
I grandi ristoranti fanno principalmente profitti con il “ricarico” sui prezzi delle bevande, in primis quelle alcoliche: quasi sempre una bottiglia di vino in un ristorante costa circa il triplo rispetto al prezzo a cui si può trovare in una enoteca molto fornita, ma negli ultimi tempi molti ristoranti hanno ulteriormente aumentato questo rapporto. Questa fonte di introiti presuppone però possibilità di investimento importanti: la creazione di una cantina fornita significa “immobilizzare” risorse economiche, cioè spendere grandi cifre di denaro che potranno rientrare, forse, solo in tempi molto lunghi. Anche in questo caso la crescente tendenza a semplificare, con carte dei vini più selezionate, si scontra con il prestigio di vantare una cantina molto fornita, con la volontà di assecondare ogni possibile gusto dei clienti e di garantire abbinamenti ricercati con i piatti presentati.
Altri modi per massimizzare i profitti sono stati esplorati: molti chef hanno sfruttato il marchio del proprio ristorante per crearne altri satellite, in stile bistrot o trattoria, meno formali e con standard di servizio e contesto meno elevati (e prezzi più democratici ma che garantiscano utili).
Altri si sono specializzati su un singolo tipo di prodotto, specialmente quelli più richiesti (hamburger gourmet, sushi, all’estero la pasta), hanno aperto di servizi catering o di vendita di particolari prodotti online. Tutte queste soluzioni, però, impongono investimenti ulteriori a livello finanziario ed espansione della forza lavoro. Secondo alcuni ristoratori, come sottolinea Vivian Howard, chef e autrice di una fortunata serie di documentari sulla cucina, la cosa può essere controproducente: «Quando un cliente ha l’opportunità di pagare meno per un ristorante, tende ad abituarsi, o ad accontentarsi di quella esperienza per almeno un periodo consistente di tempo».
L’Erba del Re di Modena ha esplorato con soddisfazione molte di queste forme, compresa una scuola di cucina, consulenze, organizzazione di eventi, bottega con vendita di conserve: «Diversificare è necessario» dice Marchini, «anche per rispondere a crisi imprevedibili come quella del Covid. Però, certo, serve una mentalità imprenditoriale che non sempre è presente».
Lo Chic Nonna, oltre a condividere gli sforzi nel marketing con un ristorante gemello a Dubai, sfrutta la propria struttura, il Palazzo Portinari Salviati a Firenze, per affiancare al ristorante un “salotto”, aperto dalle 10 di mattina alle 10 di sera, che serve dalle colazioni ai cocktail e ha una sala per eventi: in entrambe è possibile fornire servizi su misura a richiesta, con margini di profitto valutabili e stimabili con certezza. Tano passami l’olio organizza corsi, appunto, sull’olio, e fornisce un servizio di catering su richiesta.
Le lunghe liste d’attesa nei ristoranti più ricercati suggerirebbero anche un’altra soluzione: aumentare i prezzi, nella quasi certezza che si troverà comunque una nicchia di clienti disposti a pagare cifre anche molto elevate per un’esperienza che si descrive come esclusiva. Questa strada ha due obiezioni: la prima è che è già attualmente praticata, con aumenti anno dopo anno dei prezzi dei menù degustazione anche piuttosto importanti, o comunque superiori all’inflazione. La seconda è che l’aumento di prezzo necessario per rendere sostenibile il business sarebbe troppo alto e porterebbe a cifre che costituirebbero una barriera d’ingresso eccessiva o che potrebbero essere percepite come poco etiche, troppo elitarie. Tano Simonato dice: «Per arrivare a una marginalità sufficiente, intorno al 30 per cento, dovrei mettere i primi a 50 euro e i secondi a 70».
La chiusura e in precedenza la gestione del Noma, così come di altri ristoranti di altissimo livello, avevano inoltre aperto questioni sulla sostenibilità etica, e non solo economica, del fine dining. Redzepi è noto nell’ambiente dei grandi chef per un carattere difficile, modi bruschi e comportamenti ai limiti del bullismo nei confronti dei suoi sottoposti. Nel corso degli anni ha detto di aver lavorato per migliorare la sua leadership, ma questo genere di gestione è più la norma che una eccezione.
Recenti serie tv e film come Boiling Point, The Menu o The Bear hanno raccontato, in varie forme, anche al grande pubblico come le cucine possano essere ambienti di lavoro tossici, conflittuali, potenzialmente traumatici. Le denunce sui social network da parte di dipendenti e stagisti hanno allo stesso modo reso palese come il business dei grandi ristoranti si basi spesso sullo sfruttamento dei lavoratori, su orari di lavoro senza regole, su richieste eccessive e retribuzioni insufficienti o talvolta totalmente assenti. Lo stage gratuito, per cui il Noma è stato molto criticato e che ha superato solo pochi mesi fa dopo le molte polemiche suscitate, è molto diffuso.
we'll never get over that first hit of @thebearfx. pic.twitter.com/dNwrH9D98z
— FX Networks (@FXNetworks) September 14, 2022
Queste pratiche, ora che sono diventate oggetto di discussione pubblica, sono sempre meno tollerate. Inoltre uno degli effetti della pandemia è stata una diffusa maggiore attenzione alla vita extra-lavorativa. Retribuire in modo consono i dipendenti sta diventando un’esigenza tanto scontata quanto potenzialmente distruttiva per i conti dei ristoranti. Il Noma, dopo aver deciso di retribuire tutti gli stagisti (prima ne aveva circa 30 che lavoravano gratis per periodi di tre mesi) ha avuto un aumento delle spese pari a 45.000 euro al mese.
La difficoltà nel reperire personale qualificato ha poi spesso imposto di ripensare gli stessi orari di apertura, limitandoli a quattro-cinque giorni la settimana, alla sola sera, o in Italia superando il logorante “turno spezzato” (pranzo e cena, con poche ore di pausa in mezzo). Dice Mollica: «Allo Chic Nonna il ristorante gastronomico è aperto cinque sere la settimana: così razionalizziamo il costo del lavoro e massimizziamo i clienti. In più non lavoriamo solo con i menù degustazione, ma anche alla carta: un cliente può tornare anche più volte nel corso di un mese». Limitare giorni e orari di apertura, in generale, implica però fare meno “coperti” e quindi ricavi: come far convivere le due esigenze è una questione ancora da risolvere.
Allo stesso modo assicurarsi la stabilità del gruppo di lavoro è sempre più importante, in un contesto lavorativo in cui le posizioni possono restare vacanti a lungo: per questo in alcune imprese virtuose la ricerca della gratificazione del personale passa da una valorizzazione dei rapporti umani, da pratiche di team building e di welfare aziendale, da corsi di formazione supplementare (come quelli di teatro per gli operatori di sala, o quello di basi economiche, a partire dalla lettura delle buste paga). Sono tutte componenti che aumentano i costi. Sempre Mollica racconta che si possono inoltre implementare sistemi di retribuzione a obiettivi, con premi su ciò che si raggiunge e si risparmia.
I ristoranti stellati hanno però spesso bisogno anche solo di superare la cultura interna basata su dinamiche di stile militaresco e sulla centralità della sofferenza e del sacrificio nella dimostrazione di etica del lavoro e carattere. Tutti gli chef sottolineano che una gerarchia all’interno delle cucine sia necessaria, ma i casi in cui questa trascende sono stati ampiamente documentati, soprattutto all’estero. Il Guardian ha presentato uno studio condotto dalle Università di Cardiff e Lione in 62 cucine di chef di 11 paesi: si evidenziava la presenza costante di violenza, verbale e non solo.
Le stesse figure di chef ossessionati dalla ricerca delle perfezione e pronti a dedicare ad essa la propria vita, ma anche quella dei propri sottoposti, sembrano sempre meno compatibili con ambienti di lavoro etici e imprese economiche sane. L’alta cucina ha probabilmente bisogno di ripensare il modo in cui si racconta, oltre che i suoi modelli economici. Ma gli esempi virtuosi non mancano e, come dice il food editor del New York Magazine Alan Sytsma, «ci sarà sempre un pubblico che vuole mangiare al “miglior ristorante” e ci saranno sempre chef che si impegneranno per ottenere quel riconoscimento».
– Leggi anche: Come funzionano le stelle Michelin