Cosa succede in un programma radio che fa raccontare segreti in diretta
Matteo Caccia, che ne conduceva uno su Radio 2, ricorda la telefonata di un camionista nel suo libro "Voci che sono la mia"
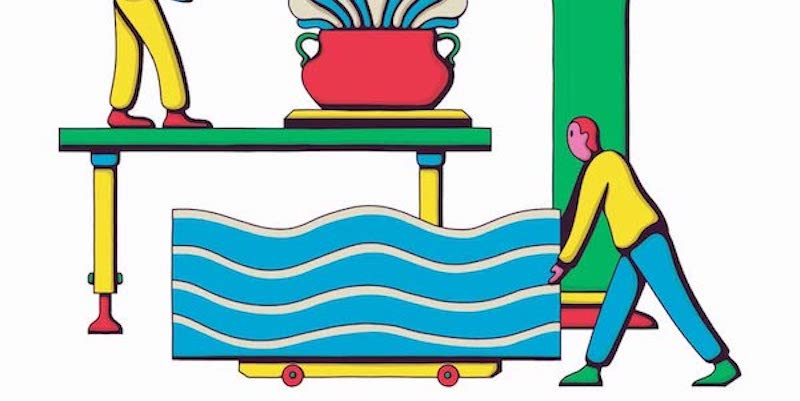
Una parte difficile del lavoro di chi racconta storie per lavoro è trovarle, le storie, prima ancora che raccontarle. Ci sono tanti modi per farlo, con maggiori e minori probabilità di successo. Nella sua carriera Matteo Caccia, conduttore e autore di programmi radiofonici e podcast come La piena, ne ha sperimentati diversi tra cui uno molto spericolato: mettere un numero di telefono a disposizione di chiunque pensi di avere una storia personale da raccontare per farlo in diretta, senza grandi filtri.
Caccia, che ora è anche il responsabile dei podcast del Post, lo racconta in Voci che sono la mia. Come le storie ci cambiano la vita, uscito di recente per il Saggiatore. Il libro raccoglie tante delle storie che Caccia ha trovato e raccontato, spesso spiegando come ci è arrivato. Ne pubblichiamo un estratto, che parla di una telefonata in cui venne raccontato un segreto.
***
Sono in uno studio al quinto piano nel palazzo della Rai di Corso Sempione a Milano.
Fuori è buio, siamo a febbraio.
L’edificio è un palazzo storico disegnato da Gio Ponti, gelido fuori e dentro, soprattutto la sera quando i corridoi assomigliano più a un reparto ospedaliero che a un centro di produzione radio e tv.
Sono in diretta. Il programma che conduco si chiama Pascal e va in onda tutte le sere dalle 22.30 alle 23.30.
In studio sono da solo, seduto su una sedia girevole senza braccioli. Indosso un paio di cuffie e ho un microfono davanti a me. Tutto normale per uno che fa radio. L’unica cosa fuori posto in questo scenario è un telefono appoggiato al banco.
È un telefono di plastica bianco con i tasti neri, avrà una ventina d’anni, uno di quelli che le aziende comprano in grandi quantità, fino a quando invecchiano e vengono rimpiazzati da altri più nuovi.
Le regie ne sono piene, servono per ricevere le telefonate da mandare in onda quando gli ascoltatori chiamano in diretta, ma dentro a uno studio è difficile vederne uno.
Ecco, dall’inizio di questa stagione ho chiesto di avere uno di questi telefoni accanto al mio microfono per rispondere direttamente io alle telefonate mentre sono in diretta.
Quando l’ho comunicato, i tecnici Rai mi hanno guardato smarriti: «Voglio rispondere a una telefonata, direttamente dallo studio» ho detto «e poi mandarla in onda, senza filtro».
La rubrica si chiama «Non dirlo a nessuno», ogni sera allo scoccare delle 23 lancio in onda il numero per chiamare il programma (+39 340 922 7809) e riaggancio la cornetta del telefono che fino a quel momento era rimasta sollevata.
Chiunque può telefonare per raccontarmi anonimamente un segreto, una storia che nessuno sa e che decide di confessare in diretta, a una radio nazionale.
Ogni sera è un salto nel buio. Non sai chi chiama, non sai perché chiama, non conosci le sue intenzioni.
Quando comunichi un numero di telefono di una radio, una parte delle persone che stanno ascoltando prende in mano il cellulare e semplicemente chiama. Non si preoccupa di rispondere alla richiesta e tantomeno di avere qualcosa da dire, motivo per cui spesso il telefono squilla, io rispondo e dall’altra parte buttano giù, oppure dicono qualcosa che credono sia simpatico e buffo tipo «Ciao mamma!» o «Forza Juve!».
Bisogna avere pazienza e soprattutto fare la domanda giusta, in ultimo essere rigidi con chi chiama senza davvero avere una storia da raccontare.
Quella sera il telefono squilla subito, il microfono è aperto di proposito, gli ascoltatori sentono prima il suono di quel telefono che squilla accanto a me e poi la mia voce che risponde:
«Pronto?»
«…»
«Qual è la storia che non hai mai raccontato a nessuno?» «…»
Ci sono dei secondi in cui ascolto in silenzio. La voce di chi telefona entra solo nel mio orecchio sinistro attraverso la cornetta, ho pochi secondi per capire se quella persona ha davvero una storia, o se vuole solo urlare parole sconclusionate e poi buttare giù.
Mi ritrovo fermo sulla sedia, come fossi su un albero e stessi stringendo un ramo per evitare che il vento mi faccia cadere.
Questa rubrica è stata una mia idea e quasi ogni sera mi maledico.
Ci sono troppe variabili in gioco: non so mai se quei cinque minuti previsti in scaletta saranno un calvario o un successo.
«Okay, stai lì che ti mando in onda.»
Dall’altra parte del telefono la voce di un uomo, è un camionista, sembra sincero.
Io mi rilasso un po’, sento i muscoli che mollano la presa stretta attorno allo stomaco. Respiro.
«Matteo, la mia è una storia che tengo dentro da trentacinque anni, è una storia complicata perché io ho una famiglia a Napoli.»
I dettagli del racconto di solito dicono qualcosa del racconto stesso, se la storia è inventata spesso è farraginosa, priva di riferimenti concreti allo spazio o al tempo. Qui non è così.
«Sono un autotrasportatore, ho sempre fatto avanti e indietro tra l’Italia e l’Europa dell’Est. Un anno in Polonia conosco una ragazza facendo un incidente. Le vado addosso col camion, scendo per aiutarla e la sera andiamo a cena insieme.»
Tengo sempre gli occhi leggermente socchiusi quando ascolto una storia interessante, come a concentrare i muscoli del volto per aguzzare orecchie e ascolto. Cerco di distinguere i cambiamenti della voce, le parole esatte utilizzate da chi parla.
Sono un grumo di tensione in attesa. Alle orecchie di chi ascolta resto il responsabile dei racconti che vengono fatti alla radio, paradossalmente lui potrebbe raccontare quello che gli va, come gli va, ma sono io che rispondo della qualità di quello che mando in onda.
«Dopo la cena ci salutiamo con un bacio. Il mese dopo torno in Polonia e ci rivediamo. Iniziamo una storia che finisce quando lei mi telefona dicendomi che è incinta. Di me. Me lo comunica solo perché vuole che io lo sappia, mi dice, ma da qui in avanti le nostre vite si dividono. Lei ha un marito a cui dirà che il figlio è suo, io ho una moglie a cui non dirò niente.»
A questo punto la storia è partita e sta correndo molto bene. Io posso mettermi un po’ più comodo sulla sedia, respiro meglio, anche se lui si è già preso quattro dei cinque minuti che dedichiamo a questa rubrica, ma c’è talmente tanta vita attaccata a questo racconto che adesso il tempo è l’ultimo dei problemi.
«Passano gli anni, io smetto di viaggiare verso la Polonia, per un po’ continuo la mia vita e stop. Un anno fa lei mi ricontatta, mi dice che è malata, non ha tanto da vivere e per questo motivo vuole farmi sapere che in Polonia ho un figlio di trentacinque anni, fa il medico, lavora in un ospedale, non sa niente di me ed è una persona straordinaria. Matteo, a me questa cosa mi ha sconvolto la vita.»
Quando si rivolge direttamente a me facendo il mio nome finalmente mi ridesto da quella sorta di paresi da ascolto che mi ha stretto per qualche minuto.
«Lo posso ben immaginare» gli rispondo.
Ora ci sono di nuovo anche io in questa storia, non è una questione solo sua ma riguarda anche me, come sempre; sono lì davanti a lui, lui la sta raccontando a me, per un attimo l’avevo quasi dimenticato, io sono il suo interlocutore, l’orecchio teso ad ascoltare.
«Ero molto indeciso ma alla fine l’estate scorsa ho preso la decisione e sono tornato in Polonia, sapevo solo il suo nome e l’ospedale in cui lavorava.
Ho una malattia cronica ai reni e quando sono arrivato ho finto di avere un problema e sono andato al pronto soccorso dell’ospedale.
Dopo qualche minuto di attesa è arrivato lui. Io ero senza parole. È un bel ragazzo, parla benissimo inglese. Mi ha chiesto come stavo e mi ha fatto domande specifiche sulla mia cartella clinica. Ho parlato molto poco, lui alla fine mi ha prescritto un farmaco e mi ha detto di tornare quando fossi ripassato in Polonia per lavoro. Mi ha stretto la mano e mi ha salutato.»
Dall’altra parte del vetro il mio regista mi fa segno di chiudere, siamo in ritardo, dovremo far saltare un brano.
Sento caldo, mi rimbocco le maniche del maglione, ringrazio l’uomo al telefono che procede il suo viaggio in camion dicendo quello che dico sempre: «Non so come ma spero che in qualche modo ti sia servito raccontare questa storia».
Parte la musica, mi tolgo le cuffie e mi sfilo il maglione, sono sudato.
© Matteo Caccia, 2022
Pubblicato in accordo con S&P Literary – Agenzia letteraria Sosia & Pistoia
© il Saggiatore S.r.l., Milano 2022




