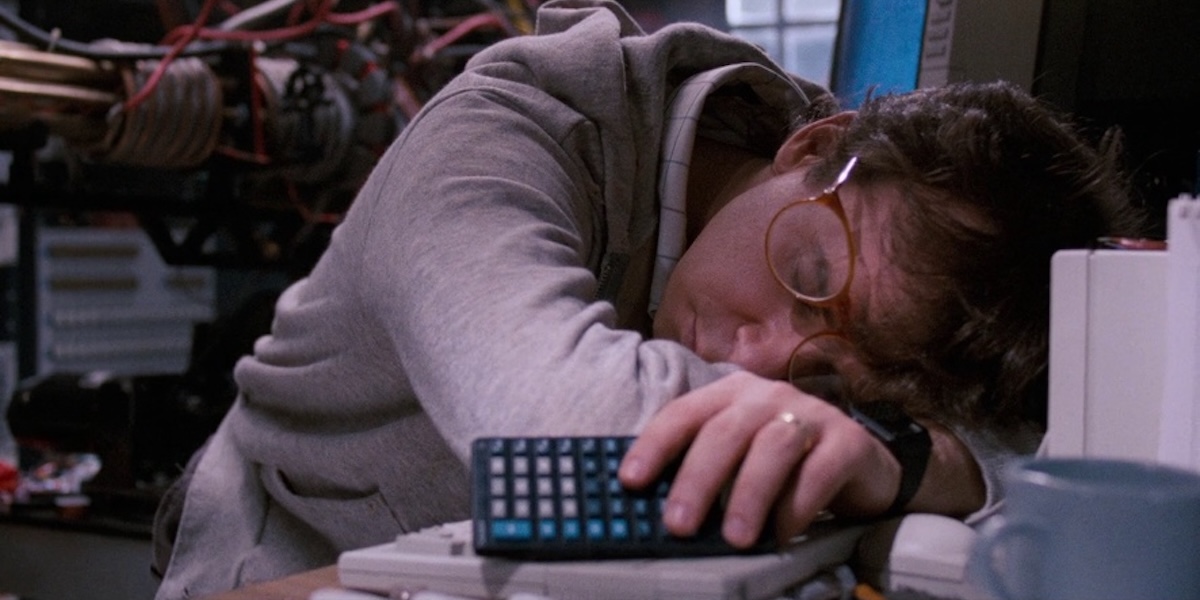Quelli che non visualizzano le cose
L’afantasia, l’incapacità di generare immagini mentali, è da tempo una condizione dai confini incerti e molto dibattuta nelle neuroscienze

In uno dei suoi racconti più famosi e citati – Funes el memorioso, pubblicato nel 1942 – lo scrittore argentino Jorge Luis Borges descriveva il caso immaginario di un giovane uruguaiano chiamato Ireneo Funes. In seguito a un incidente in cui era stato travolto da un cavallo, Funes si era risvegliato semiparalizzato ma con un talento straordinario: una memoria prodigiosa, letteralmente disumana. Ogni nuova informazione – ogni pelo della criniera di un puledro, una mandria innumerevole in un campo, le stelle nel cielo – rimaneva per Funes disponibile in qualsiasi momento come se fosse davanti ai suoi occhi tutto il tempo.
Questi ricordi non erano semplici: ogni immagine visiva era legata a sensazioni muscolari, termiche, eccetera. Poteva ricostruire i sogni dei suoi sonni, tutte le immagini dei suoi dormiveglia. Due o tre volte aveva ricostruito una giornata intera; non aveva mai esitato, ma ogni ricostruzione aveva chiesto un’intera giornata.
In più punti del racconto – tratto dalla raccolta Finzioni, edita in Italia da Adelphi – Borges sembra sottintendere che a sostegno dello straordinario talento di Funes ci sia comunque una capacità apparentemente ovvia e molto meno eccezionale: quella di rievocare immagini mentali di oggetti, persone o esperienze anche in assenza del dato percettivo. Nella letteratura scientifica sul funzionamento del cervello, specialmente quella più recente, è invece una facoltà non scontata: la condizione di chi non è in grado di visualizzare immagini mentali è definita nelle neuroscienze cognitive – che studiano le basi cerebrali del pensiero – “afantasia”.
È una condizione ancora studiata e la cui stessa esistenza è oggetto di discussione, ma alcune autorevoli stime indicano che a soffrirne sia circa una persona su cinquanta: persona che, alla richiesta di immaginare il proverbiale elefante rosa, non riesce a vederlo nella sua mente. L’aneddotica suggerisce che chi non ha la facoltà di visualizzare immagini mentali possa in certi casi non rendersene nemmeno conto fino a una fase avanzata della sua vita, quando per caso – leggendo questo articolo, per esempio – si imbatte in una descrizione precisa di cosa intendano tutte le altre persone quando dicono “immagina di essere su un’isola deserta”. Chi non riesce, in risposta a questo invito, a visualizzare nella testa l’immagine di una spiaggia tropicale e disabitata, si arrangia inconsapevolmente in modo diverso: e nella maggior parte dei casi assolve a tutte le funzioni quotidiane che nelle altre persone passano attraverso l’immaginazione visiva mentale.
Uno studio recente pubblicato sulla rivista scientifica Proceedings of the Royal Society B e condotto da ricercatori dell’Università del Nuovo Galles del Sud (UNSW), a Sydney, ha concluso che la capacità di produrre immagini mentali potrebbe, in determinate circostanze, essere un requisito essenziale nell’esperienza della paura in mancanza di stimoli visivi. È soltanto uno degli esempi più recenti di studi che nel corso degli ultimi due decenni si sono occupati di afantasia, studi peraltro favoriti dall’evoluzione delle tecniche di diagnostica medica dopo un lungo periodo di incertezza dei confini e dei termini stessi del dibattito.
– Leggi anche: Quanto contano gli altri sensi per il gusto
L’immaginazione visiva
Molti studi riguardo all’afantasia – un’espressione piuttosto recente, attestata dal 2015 – sono stati storicamente preceduti dall’analisi di casi clinici particolari in cui la presenza di menomazioni accidentali nelle vite di alcuni pazienti ha offerto a scienziati, psicologi e filosofi la possibilità di definire anche per contrasto concetti altrimenti difficili da afferrare e maneggiare in modo condiviso e uniforme. La perdita della vista, per esempio, è uno di quei casi che permettono generalmente di trovare un’intesa sul concetto di “immagine mentale”, la cui manipolazione e generazione stessa risultano compromesse nel caso dell’afantasia, appunto.
All’inizio degli anni Novanta lo psicologo australiano di origini ungheresi Zoltan Torey scrisse al neurologo inglese Oliver Sacks, all’epoca già noto per i suoi libri di successo in cui descriveva problemi e condizioni neurologiche riscontrate tra i suoi pazienti. Torey gli raccontò della sua cecità, conseguenza di un incidente avuto a 21 anni quando era uno studente di odontoiatria. Sebbene gli fosse stato consigliato dai medici di «passare da una modalità visiva a una uditiva», come riportato da Sacks nel libro L’occhio della Mente, Torey decise di andare in direzione opposta e si concentrò il più possibile sulle sue facoltà di immaginazione visiva, il suo «occhio interiore».
L’immaginazione visiva sviluppata in seguito da Torey – che lasciò poi odontoiatria e si laureò in Psicologia e in Filosofia – gli permise di fare cose che sarebbero sembrate impossibili da eseguire per un non vedente. Raccontò che a un certo punto finì per sostituire senza alcun aiuto la grondaia sul tetto di casa, generando incredulità tra i suoi vicini di casa, allarmati nel vedere un uomo cieco, da solo, sul tetto di casa in piena notte (per lui l’oscurità non faceva alcuna differenza). «L’ho fatto basandomi esclusivamente sulla manipolazione accurata e concentrata del mio spazio mentale, che oggi è perfettamente duttile e sensibile», scrisse Torey. La sua «capacità di produrre, trattenere e manipolare immagini mentali», riferì Sacks, ne uscì talmente acuita che il suo «mondo visivo virtuale» gli sembrava persino più reale e più intenso di quello che aveva perduto.
Nei confronti di quella sua immaginazione visiva Torey mantenne comunque un atteggiamento prudente: si assicurava di verificare l’accuratezza di quelle sue immagini in ogni modo possibile, accettandole sempre in via provvisoria. «Imparai a riconoscere credibilità e status all’immagine solo in presenza di qualche altra informazione che facesse pendere la bilancia in suo favore», spiegò a Sacks. E suggerì anche che il lavoro di suo padre in Ungheria – direttore di uno studio cinematografico durante l’infanzia di Torey, prima della Seconda guerra mondiale – potesse avere influito su quelle sue future capacità in condizioni di cecità. «Mi dava l’opportunità di visualizzare storie, trame e personaggi – di allenare l’immaginazione, insomma», scrisse riferendosi all’abitudine di leggere i copioni che giravano per casa.

(Richard Heathcote/Getty Images)
L’assenza di immagini mentali
Non va sempre come nel caso di Torey, ovviamente, e ogni storia di cecità presenta dettagli che di fatto rendono unico ogni caso clinico analizzato. Nello stesso libro, Sacks racconta la storia di John Hull, un insegnante inglese di scienze religiose rimasto privo dell’uso dell’occhio sinistro a diciassette anni, poi ipovedente dal destro fino a quarantotto anni e infine completamente cieco. Hull descrisse quella sua esperienza in un libro che fece avere a Sacks, il quale lo trovò «impressionante» soprattutto riguardo a un fenomeno che si era rapidamente verificato in Hull: una graduale attenuazione della memoria e dell’immaginazione visive.
Hull raccontava di avere completamente perso, con il tempo, la facoltà di richiamare alla mente immagini mentali e ricordi visivi, cadendo in quella che definiva «cecità profonda». «Hull non riusciva più a immaginare l’aspetto del numero 3, a meno che non lo tracciasse in aria con la mano», spiega Sacks: «riusciva a costruire l’immagine motoria di un 3, ma non quella visiva». E nel frattempo aveva perso ogni capacità di richiamare alla mente l’immagine della moglie e dei figli. Dopo averne inizialmente sofferto moltissimo, arrivò a considerarla una risposta «naturale» alla perdita della vista, pensando anzi che quella perdita fosse un prerequisito per il potenziamento di altri sensi.
– Leggi anche: Quanto contano gli altri sensi per il gusto
A quel punto, Hull fece di fatto quello che era stato consigliato dai medici a Torey: concentrarsi sugli altri sensi. Nel libro raccontò di come il suono della pioggia fosse diventato per lui il segno di un intero paesaggio, di come riuscisse a distinguere in giardino le gocce che cadevano sul vialetto da quelle che cadevano sul prato o sulla siepe prima della strada. E per lui non si trattava di «compensazione», ma di un «dono oscuro, paradossale» che gli aveva permesso di scoprire un intero nuovo ordine di sensazioni. Sacks trovò invece sorprendente che un «annientamento della memoria visiva» come quello descritto da Hull potesse verificarsi in un soggetto adulto con decenni di esperienze visive ricche e significative alle spalle.
Ma lo stesso Sacks racconta che, anni dopo, in occasione di un congresso di medicina in cui aveva parlato dei casi di Hull e Torey e di come il secondo fosse riuscito a ipersviluppare le sue capacità di visualizzazione, un uomo si avvicinò a lui alla fine degli interventi. Chiese a Sacks se e in che misura pensasse che i vedenti potessero «funzionare» lo stesso, anche in assenza di immaginazione visiva, e gli disse che né lui né i membri della sua famiglia avevano mai posseduto un’abilità di quel tipo. «E che lavoro fa?», gli chiese Sacks. «Sono un chirurgo vascolare. E anche un anatomista. E progetto pannelli solari», replicò quello.
Il chirurgo incontrato da Sacks disse di non aver mai saputo di non possedere quella facoltà mentale e di averlo scoperto soltanto in seguito alla partecipazione volontaria ad alcuni test psicologici tra gli studenti durante gli anni di studio a Harvard. Tutti gli altri studenti, seppure in misura variabile, sembravano possedere quella facoltà. Sacks si chiese come facesse quel chirurgo a «riconoscere» ciò che vedeva quando lavorava. E il chirurgo spiegò: «io credo che nel mio cervello esistano rappresentazioni o modelli associati a ciò che sto vedendo e facendo, solo che non sono coscienti, non posso evocarli».

(Paula Bronstein/Getty Images)
I primi studi di Galton
Si ritiene che il primo a cercare e riportare casi umani di carente o assente produzione di immagini visive mentali fu l’eclettico studioso di statistica inglese Francis Galton in una ricerca del 1880. La definì come una condizione piuttosto diffusa tra i suoi colleghi, spesso per niente problematica. In un successivo libro, Inquiries into Human Faculty and Its Development del 1883 (pdf), Galton descrisse altri particolari del metodo utilizzato nelle sue ricerche.
Aveva formulato una specie di questionario con alcune domande che avrebbero con ogni probabilità messo in difficoltà il chirurgo incontrato da Sacks oltre un secolo dopo. Una delle domande del test chiedeva al soggetto, per esempio, di richiamare con precisione i lineamenti di un parente o di un caro amico, di visualizzarlo mentre si sedeva o si voltava lentamente. Alcune persone risultarono totalmente prive di una facoltà del genere, anche se questo non sembrava avere ripercussioni significative nelle loro attività quotidiane.
– Leggi anche: Perché vediamo le facce negli oggetti?
L’estrema variabilità con cui l’immaginazione visiva si presentava o a volte era del tutto assente nei soggetti dei primi studi di Galton fu, in sostanza, una delle ragioni dell’incertezza che da allora in poi ha caratterizzato gran parte del dibattito su questa condizione. Per certi versi, non essere in grado di evocare immagini visive sembrava a Galton incompatibile con certi processi superiori del pensiero. Per altri versi, molti soggetti che si dichiaravano privi di quella facoltà riuscivano comunque a descrivere bene le loro esperienze, al punto da far credere che fossero in grado di visualizzarle esattamente come gli altri.
Qualcosa cambiò all’inizio degli anni Settanta, quando psicologi e studiosi di scienze cognitive come Roger Shepard e Jacqueline Metzler contribuirono a fornire strumenti quantitativi utili al dibattito ideando una serie di esercizi basati sulla rotazione mentale delle immagini di figure geometriche. Shepard e Metzler individuarono un rapporto tra il tempo necessario a eseguire nella mente la rotazione di un’immagine e l’angolo della rotazione richiesta espresso in gradi. Questa scoperta permise in seguito di appurare che le persone incapaci di visualizzare immagini mentali tendono a risolvere questi esercizi di rotazione con strategie mentali alternative e in tempi differenti rispetto a quelli delle altre persone.
Dagli anni Novanta in poi altri studi sull’assenza di immaginazione si avvalsero dei progressi nella diagnostica di medicina nucleare. Scansioni eseguite tramite esami come la tomografia ad emissione di positroni (PET) e la risonanza magnetica funzionale (fMRI) resero possibile, tra le altre cose, la mappatura delle aree del cervello attivate quando viene richiesto ai soggetti di visualizzare immagini mentali.
Gli studi di Zeman sull’afantasia
Fu nei primi anni Duemila che la ricerca sull’afantasia subì un’accelerazione significativa, grazie al lavoro e agli studi del neurologo Adam Zeman, docente alla Facoltà di medicina dell’Università di Exeter, in Inghilterra. Nel 2003 un geometra di 65 anni in pensione si rivolse a lui sostenendo di non essere più in grado di evocare immagini di amici, familiari o luoghi conosciuti, a seguito di un intervento di cardiochirurgia durante il quale aveva probabilmente subìto un lieve ictus.
Zeman e i colleghi del suo gruppo di ricerca avviarono una serie di studi basati su test e risonanze magnetiche funzionali, poi confluite in una pubblicazione del 2015 in cui coniarono per la prima volta l’espressione “afantasia” per definire la condizione di 21 partecipanti volontari. Così come Galton più di cento anni prima, anche Zeman notò da subito che il suo primo paziente, il geometra in pensione, pur avendo punteggi scarsi nei questionari di valutazione della capacità di produrre immagini visive, era in grado di svolgere compiti che avrebbero tipicamente richiesto una certa capacità di visualizzazione.

Il mosaico dedicato a John Lennon allo Strawberry Fields Memorial di Central Park, a New York (Stephen Chernin/Getty Images)
Il paziente di Zeman, per esempio, fu in grado di eseguire gli esercizi in cui occorreva ruotare gli oggetti mentalmente. Gli furono mostrate due immagini di oggetti tridimensionali e gli fu chiesto se su entrambe le immagini fosse raffigurato oppure no lo stesso oggetto prima e dopo una rotazione sul suo asse. Riuscì a rispondere correttamente, in un tempo che restava sostanzialmente invariato anche quando la rotazione dell’oggetto era maggiore. A conferma di una risposta fisiologica differente rispetto a quella del gruppo di controllo, una risonanza magnetica funzionale mostrò inoltre nel paziente di Zeman un’intensa attività in aree del cervello diverse rispetto a quelle generalmente più attive durante la visualizzazione di immagini mentali.
Dal 2015 l’afantasia – una condizione che secondo le stime di Zeman riguarda circa il 2 per cento della popolazione – ha progressivamente attirato più attenzioni ed è diventata oggetto di approfondimenti, testimonianze e documentari. Anche il programmatore e cofondatore di Mozilla Blake Ross, in un lungo articolo su Facebook, raccontò di soffrirne.
«Se ti dico di immaginare una spiaggia, riesci a immaginare la sabbia dorata e le onde azzurre. Se chiedo un triangolo rosso, la tua mente inizia a disegnarlo. E la faccia della mamma? Certamente. […] Ecco, io no. Non ho mai visualizzato niente in tutta la mia vita. Non riesco a “vedere” la faccia di mio padre né una palla blu che rimbalza, la mia stanzetta da bambino né la corsa che ho fatto dieci minuti fa. E pensavo che “contare le pecore” fosse una metafora. Ho 30 anni e non ho mai saputo che un essere umano potesse fare niente di tutto questo».
Oltre che suscitare grande interesse, le ricerche di Zeman hanno sollevato una serie di domande. Una parte del dibattito riguarda ancora la definizione di afantasia e mette in dubbio l’esistenza stessa di questa condizione. Secondo i più scettici le persone che dichiarano di non essere in grado di visualizzare immagini mentali potrebbero semplicemente avere un modo di descrivere quelle immagini diverso rispetto a quello di altre persone.
– Leggi anche: La parola che state cercando è “illanguidimento”
Sebbene Zeman ammetta un certo margine di errore nelle domande del suo questionario, a confermare la realtà dell’afantasia sarebbero secondo lui i risultati neurologici delle risonanze magnetiche funzionali e, a volte, la compresenza di altre anomalie legate alla visualizzazione, tra i pazienti. Diversi tra loro sono affetti anche da prosopagnosia, la malattia di chi non riconosce i volti conosciuti, raccontata da Oliver Sacks nel libro L’uomo che scambiò sua moglie per un cappello. Altri presentano una scarsa memoria autobiografica, l’insieme delle conoscenze relative alle proprie esperienze. E tutto questo, secondo Zeman, potrebbe indicare che esistono diversi sottogruppi di afantasia.