Un naufragio lungo 15 mesi
Nel 1965 sei adolescenti tongani rubarono una barca, restarono alla deriva per giorni e finirono su un'isola disabitata, senza cibo né acqua: se la cavarono
di Gabriele Gargantini

Una sera di giugno del 1965 sei studenti di un severo collegio cattolico di Nuku‘alofa, la capitale di Tonga, rubarono una barca. Non è chiaro dove volessero andare: forse alle Fiji, forse in Nuova Zelanda, o forse – visto che sia Fiji che Nuova Zelanda erano lontanissime – volevano solo un’avventura, provare a pescare qualcosa, passare una notte nell’Oceano e poi tornare in collegio. Il più giovane aveva 13 anni, il più grande 16. Non erano grandi navigatori e nemmeno buoni pianificatori. Scelsero la barca da rubare per via dell’antipatia nei confronti del pescatore che ne era proprietario; per l’avventura portarono con sé due caschi di banane, qualche noce di cocco e un fornello a gas. Non pensarono a una mappa, e nemmeno a una bussola.
La mattina seguente i sei ragazzi tongani – Mano, Sione, Stephen, Kolo, David e Luke – si trovarono dispersi chissà dove nell’Oceano. Dopo qualche giorno di inutili ricerche vennero celebrati i loro funerali, ma i sei non erano morti: erano finiti su un’isola disabitata, dove restarono per oltre un anno.
La loro storia, fino a qualche giorno fa poco nota, è stata raccontata dallo storico olandese Rutger Bregman nel suo nuovo saggio, Humankind, che uscirà a giugno nel Regno Unito e in autunno in Italia, per Feltrinelli. Se ne è parlato in questi giorni per via di un estratto del saggio uscito sul Guardian. Nel saggio Bregman ha presentato la storia come una versione reale del Signore delle mosche, il romanzo degli anni Cinquanta sulla rapida degenerazione sociale di un gruppo di ragazzi britannici naufragati su un’isola disabitata.
Nella brezza della sera di quel giugno del 1965, su un mare calmo, i ragazzi si addormentarono. Si svegliarono tra le onde, senza sapere dove fossero e dove li stesse portando quel peschereccio lungo più o meno sette metri. David, il più giovane del gruppo, che a suo dire era stato scelto dagli altri proprio perché sapeva navigare, non riuscì a fare granché: le vele si squarciarono per il troppo vento e il timone si ruppe. «Restammo alla deriva per otto giorni», ha raccontato uno di loro, soprannominato Mano, a Bregman: «Senza cibo e senza acqua». Provarono a pescare e riuscirono a raccogliere un po’ di acqua piovana nei gusci delle noci di cocco, spartendosela equamente. Un altro ragazzo, Sione, provò a usare il fornello per far bollire l’acqua marina, ma il fornello si ruppe e lui si bruciò.
I ragazzi – che prima di rubare la barca ne avevano parlato ad alcuni compagni senza essere presi sul serio – riuscirono comunque a sopravvivere abbastanza per arrivare davanti a una piccola isola: «Non un paradiso tropicale, con palme sventolanti e spiagge di sabbia fina», ha precisato Bregman, «bensì un imponente ammasso di rocce, che salgono per oltre 300 metri sopra il livello del mare».
A una giornalista del Guardian che è andato a trovarlo dopo la pubblicazione dell’estratto di Bregman, Mano ha raccontato che lui e i compagni di naufragio avvistarono l’isola poco prima che scendesse la notte e che fu lui il primo a tuffarsi in acqua per raggiungerla, ma solo dopo aver detto una preghiera insieme agli altri. «Fu molto, molto difficile arrivarci», ha detto Mano, che era notevolmente debilitato dai giorni passati senza cibo sulla barca: «Quando raggiunsi la riva, provai ad alzarmi in piedi ma tutto si mise a girare, quindi strisciai fino a quando toccai dell’erba secca, restandoci sdraiato sopra». Trovò però la forza necessaria per urlare agli altri cinque che era arrivato, così da farsi raggiungere da loro. Poco dopo, si addormentarono esausti.
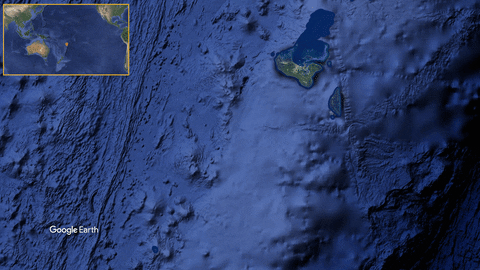
I naufraghi non lo sapevano, ma erano finiti sull’isola di ‘Ata, diverse decine di chilometri a sud rispetto al loro punto di partenza. Un’isola grande poco più di un chilometro quadrato: difficile da raggiungere dal mare e piuttosto ostile verso chi prova ad esplorarla.
L’isola era disabitata, ma solo da circa un secolo. Nel Diciassettesimo secolo l’esploratore Abel Tasman ci era passato accanto, ma a causa dei venti avversi non ci aveva messo piede; era invece sbarcato su ‘Ata, un secolo dopo, James Cook, incontrandone gli abitanti. Si pensa che nel Diciannovesimo secolo l’isola avesse almeno duecento abitanti e si sa che nel 1863 Thomas James McGrath, baleniere diventato mercante di schiavi, fece salire con l’inganno decine di loro sulla sua barca, per poi rinchiuderceli e deportarli in Perù come schiavi (non ci arrivarono mai, ma questa è un’altra storia). Dopo essere stato informato della cosa, comunque, il re tongano decise di far evacuare verso la vicina ‘Eua tutte le persone rimaste sull’isola, che da quel momento restò quindi disabitata.
Più di un secolo dopo, arrivarono i sei ragazzi. Non si erano dimostrati naviganti provetti, ma – a differenza dei più giovani ragazzi del Signore delle mosche – si dimostrarono ottimi naufraghi. Il resoconto di Bregman, ma anche di altri che negli anni hanno raccontato questa storia, parla di una cooperazione efficace e pacifica. Si organizzarono per lavorare a coppie, riuscirono a preparare una sorta di orto e uno di loro fu in grado di accendere un fuoco, che grazie al contributo di tutti non fu mai spento. Quando capitava – e capitò – che qualcuno litigasse, i litiganti venivano in qualche modo separati in due parti dell’isola, così da restare soli per un po’ a farsela passare. Quando uno di loro, Stephen, si ruppe una gamba, gli altri si presero cura di lui.
«Ogni giorno iniziava e finiva con canzoni e preghiere», ha scritto Bregman. Kolo, uno dei sei, costruì una chitarra artigianale con una noce di cocco e altri materiali che si era portato dalla nave, prima che i naufraghi la abbandonassero per raggiungere la riva. Non è chiaro se e con quali modalità uno di loro emerse in qualità di leader, ma ci sono resoconti che parlano di “un leader spirituale e di uno pratico”.
Per i primi giorni i ragazzi si nutrirono di cocco, pesci, uccelli e uova (l’unico mammifero autoctono dell’isola era il ratto polinesiano). Ebbero però problemi con l’acqua, perché non pioveva mai. Quando finalmente iniziò a piovere, la raccolsero in tronchi d’albero scavati.
L’alimentazione dei naufraghi ebbe comunque un’importante svolta quando esplorando l’isola trovarono, molto ben nascosto nel cratere di un antico vulcano, le rovine di Kolomaile, il villaggio abbandonato più di un secolo prima e, lì vicino banani, piante di taro e polli, che avevano continuato a vivere sull’isola anche senza gli umani che ce li avevano portati. Sempre da quelle parti trovarono anche dell’acqua dolce.
In tutti quei mesi passati sull’isola, ci fu qualche tentativo di costruire zattere con cui lasciare l’isola, ma alla prova del mare nessuna si dimostrò sufficientemente resistente. Per fortuna: i ragazzi pensavano di essere da qualche parte vicino a Samoa e di dover andare verso sud, ma in realtà erano da tutt’altra parte. Gli sarebbe convenuto andare verso nord, per raggiungere Tonga. Andando verso sud, avrebbero trovato solo altre migliaia di chilometri di oceano.
Vista l’impossibilità di andarsene in zattera, una delle attività principali consisteva nello stare a osservare il passaggio di qualche nave. I ragazzi ne videro passare alcune e provarono a fare segnali di fumo, ma nessuno se ne accorse almeno fino all’11 settembre 1966, quando – 15 mesi dopo che i ragazzi avevano lasciato in barca il collegio di Nuku‘alofa – a passare vicino all’isola fu la Just David, un’imbarcazione da pesca il cui capitano era Peter Warner.
Peter Warner è figlio di Arthur Warner, un politico e imprenditore che, come ha scritto Bregman, «era uno degli uomini più ricchi e potenti d’Australia». Peter era destinato a seguire le orme di suo padre, ma a 17 anni scelse di fare vita da marinaio e negli anni successivi «veleggiò verso Hong Kong, Stoccolma, Shanghai e San Pietroburgo». Tornò dal padre dicendo di voler stare per un po’ in Australia, e il padre gli suggerì di studiare contabilità, perché era facile da imparare. Warner accettò, ma allo stesso tempo gestì alcuni pescherecci che operavano al largo delle coste della Tasmania, cercando soprattutto di pescare crayfish, il nome con cui in gran parte dell’Oceania è nota una specie di aragosta. La pesca non andava però granché bene e nell’inverno del 1966 Warner si spostò verso Tonga, per chiedere al re Taufa’ahau Tupou IV di poter pescare in quelle acque. Il re gli disse che non se ne parlava proprio e Warner si organizzò per tornare verso la Tasmania.
Tornando, passò accanto ad ‘Ata. Prima di vedere i naufraghi, Warner vide dal suo binocolo della terra bruciata, segno che qualcuno era o era stato sull’isola. Al tempo poteva succedere che pericolosi criminali venissero abbandonati su isole deserte e Warner ordinò quindi ai suoi uomini di caricare i fucili, pronti a difendersi.
Poco dopo, ha scritto Bregman, Warner vide in effetti un naufrago: «Nudo, con i capelli che cadevano fino alle spalle, che saltò giù dalle rocce e si tuffò in acqua; improvvisamente seguito da altri, che urlavano con tutta l’aria che avevano in corpo». Il primo di loro a raggiungere la barca fu Stephen, che dopo aver detto il suo nome aggiunse, in un ottimo inglese: «Siamo in sei e crediamo di essere qui da 15 mesi». Arrivarono a bordo anche gli altri cinque, che spiegarono un po’ meglio la loro incredibile storia. Warner comunicò via radio di averli ritrovati, dopodiché li ricondusse verso Nuku‘alofa.
In un libro di memorie (perlopiù destinato ai suoi nipoti, ma che in questi giorni ha attirato diversi altri lettori), Warner ha raccontato che sull’isola i ragazzi si erano organizzati per bene, riuscendo a costruire anche un serraglio e una sorta di palestra improvvisata. Warner ha anche raccontato che i ragazzi erano muscolosi e in salute e che la gamba di Stephen era in ottimo stato.
Una volta arrivati a Nuku‘alofa la polizia li arrestò tutti e sei. Erano infatti accusati del furto dell’imbarcazione con cui erano scappati 15 mesi prima. Il proprietario, il pescatore che a loro stava antipatico, aveva deciso di non ritirare la denuncia.
Warner, che evidentemente si era affezionato a loro o comunque appassionato alla loro storia, aveva un piano. Grazie a certi contatti del padre trattò con un canale televisivo australiano, Channel 7, i diritti per realizzare un documentario sulla storia dei naufraghi (non è ben chiaro se informandoli prima della cosa) e con i soldi dell’anticipo riuscì a risarcire il pescatore e a far uscire i ragazzi di prigione.
Su Haʻafeva, la piccola isola di cui i ragazzi erano originari, furono fatti grandi feste e, come segno di riconoscenza, il re tongano Taufa‘ahau Tupou IV concesse a Warner di pescare nelle acque di Tonga che solo pochi mesi prima gli aveva negato.
Ma la storia di Warner e dei sei ragazzi non finisce qui.
Non molti giorni dopo la scarcerazione, Mano, Sione, Stephen, Kolo, David e Luke furono raggiunti a Tonga da una troupe di Channel 7. La troupe, gli ex naufraghi e anche Warner salirono su una barca diretta verso ‘Ata. Per raccontare la loro storia, il canale aveva scelto di farli tornare sul luogo del naufragio.
Le riprese furono proibitive. Per cominciare, alcuni tra quelli di Channel 7 non sapevano nuotare, e poi ebbero diversi problemi anche solo a seguire i ragazzi fino alle cime più alte dell’isola, dalle parti di Kolomaile. Per di più diversi minuti di girato andarono perduti, non si sa bene come.
Restano giusto una ventina di minuti di riprese a 16 millimetri, questi:
Dopo le riprese, Warner decise di trasferirsi a Tonga con la moglie e il figlio, e i sei ragazzi finirono a lavorare con lui, migliorando le loro doti da marinai. Il nuovo peschereccio si chiamava ATA, come l’isola.
Peter resigned from his father company and commissioned a new ship. He hired the 6 boys as his crew, and called the new boat the ATA, named after the uninhabited island. I really really love this picture: pic.twitter.com/cSP3Gx5OhS
— Rutger Bregman (@rcbregman) May 10, 2020
Il saggio di Bregman non ne parla, ma nel giugno 1974 un settimanale australiano raccontò che l’ATA fu protagonista di un nuovo salvataggio. Due ragazze, un ragazzo e un uomo di origini gallesi che aveva ingaggiato i primi tre per lavorare sulla sua malandata imbarcazione (la “Sospan Fach”, che in gallese vuol dire “casseruola”) si erano arenati sulla barriera corallina del Middleton Reef, più o meno a metà strada tra l’Australia e la Nuova Zelanda, dovendosi trasferire sul vicino relitto di una più grande imbarcazione giapponese.
Restarono lì diversi giorni, sopravvivendo grazie alle scorte che si erano portati dietro dalla barca abbandonata, finché non furono avvistati e soccorsi dall’ATA di Warner. Uno degli articoli del settimanale racconta la sua storia e dice che, vedendo i quattro abbandonati sulla nave, disse tra sé, ridendo: «Oh no, non un’altra volta». Sempre per quell’articolo, Warner disse comunque di essere affascinato dai naufraghi, forse perché da giovane gli era capitato di stare su una barca che si era ribaltata (venendo però salvato poco dopo).
Non ci sono informazioni recenti su tutti i sei naufraghi, ma è certo che Mano Totau e Peter Warner sono rimasti amici, ancora adesso che il primo ha poco più di settant’anni e il secondo quasi novanta. Ora vivono entrambi in Australia e Totau, contattato dal Guardian, ha detto che sta considerando l’idea di fare un suo libro sulla vicenda «per lasciare qualcosa ai nipoti», ma che sarebbe felice anche se a guadagnare qualcosa dalla storia fosse Warner, dato che fu lui a salvarli.
Per quanto ne sappiamo, il primo a tornare su ‘Ata dopo i naufraghi fu l’archeologo Atholl Anderson, nel 1977 e nel 2001 ci tornarono un ornitologo e David V. Burley, un altro archeologo, che ne ha parlato qui. Burley ha anche fatto notare la stranezza del fatto che i resti del villaggio di Kolomailie presentino delle specie di mura difensive, una cosa insolita per un isolatissimo villaggio in mezzo a un’isola. Ha scritto che potrebbe essere perché gli abitanti non erano cristiani, mentre diversi altri tongani lo erano e avevano provato a convertirne gli abitanti.
Contattato dal Post, Burley ha detto che ‘Ata «sembra proprio uscita da un romanzo di Jules Verne» e che, memore del suo arduo arrivo sull’isola è «ancora oggi affascinato da come quei ragazzi riuscirono ad arrivarci». Ha anche raccontato di ricordare di aver visto tanti uccelli marini attratti sull’isola dall’assenza di predatori e per niente spaventati dalla sua presenza. Ha raccontato, inoltre, «che una volta arrivati nella parte superiore, quella con le rovine di Kolomaile, dove ancora ci sono gli antenati dei polli che non salirono sulle navi a fine Ottocento, è tutta un’altra storia» e l’isola è decisamente meno ostile.

Una baia a nord-ovest dell’isola (David Burley, Matangitonga)
Qualche anno fa sull’isola fece un giro anche Alvaro Cerezo, uno spagnolo che organizza esperienze estreme per turisti: «Fa’ soldi abbandonando per un po’ ricchi turisti occidentali su piccole isolette del Pacifico e dell’oceano Indiano», come ha sintetizzato su questo blog Scott Hamilton, autore di The Stolen Island, un libro sulla storia di ‘Ata (di cui è disponibile un estratto sugli eventi del 1863).
Cerezo andò sull’isola insieme a Kolo Fekitoa, uno dei sei ex naufraghi: dice che sta lavorando a un documentario e a un libro, entrambi in uscita nei prossimi mesi. Ha raccontato al Post di essere stato stupito, così come Burley, dalla quantità di uccelli e dal fatto che non fossero in alcun modo spaventati dalla sua presenza («mi venivano vicino, persino in testa»), che «muoversi sull’isola è davvero proibitivo» e che «sull’altopiano è davvero un paradiso».

L’isola vista dal mare (Alvaro Cerezo)
Naked Island, un libro di cinquant’anni fa, fu il primo a raccontare, insieme ad altre storie, la vicenda dei sei naufraghi. La biografia di Warner, divisa in tre parti, si intitola Ocean of Light. La prefazione l’ha scritta Mano Totau.
– Leggi anche: La tribù più isolata del mondo






