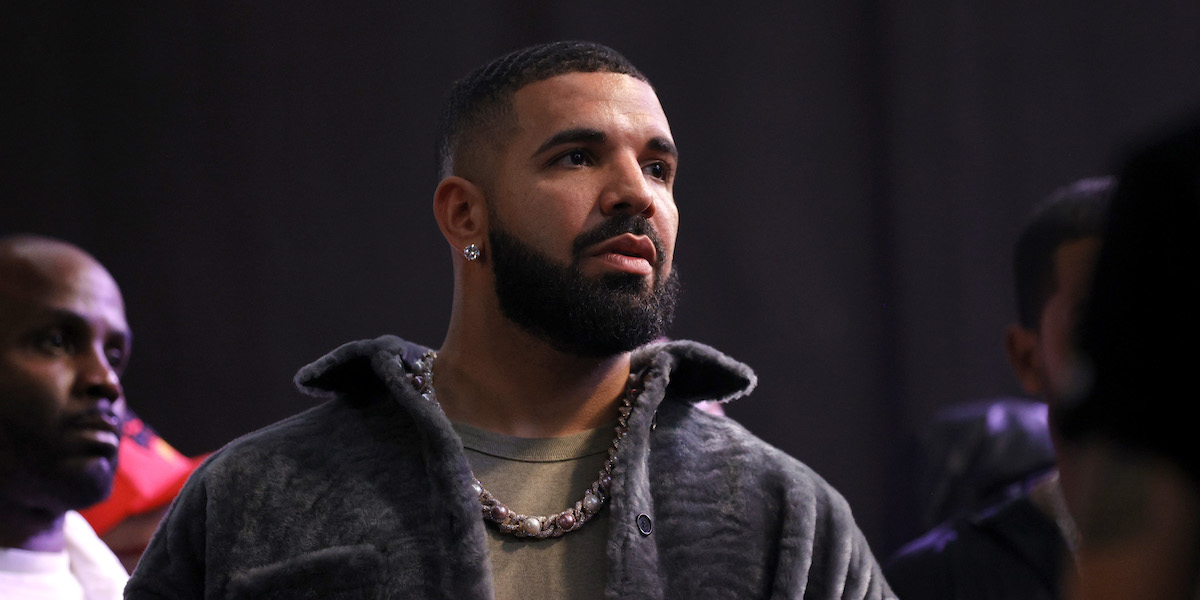Madre è chi la madre fa
Catalogo di matrigne più o meno famose della letteratura, da rileggere per la festa della mamma

È quasi arrivato quel giorno dell’anno in cui quasi ogni madre aspetta i figli a braccia conserte, per vedere se almeno o anche quest’anno si ricorderanno di farle gli auguri: ve n’eravate dimenticati ma sta per arrivare di nuovo la Festa della mamma. La mamma però non è solo quella biologica che, come anche un padre, può essere pessima e scarsa: in tutta la storia dell’umanità la funzione materna è stata svolta da lupe, pantere, suore, zie e soprattutto matrigne. Che sono, come le mamme, buone e cattive, ma che nessuno ha mai festeggiato. Per rimediare, in occasione della festa della mamma, che nel 2022 si celebra l’8 maggio, abbiamo raccolto alcune figure più o meno conosciute di matrigne e figure materne della letteratura, dando per scontato che quelle malvagie delle fiabe le conosciate già tutti: da quella immaginaria di Persepolis, alla vecchia e amabile signora Lolotta di Cesare Zavattini, dall’improbabile Holly Golightly di Colazione da Tiffany a quella che vorremmo avere tutti. E auguri, con chiunque vogliate festeggiarla.