Gli articoli autobiografici dappertutto
Le storie raccontate in prima persona che leggiamo sempre più spesso fanno risparmiare le redazioni e piacciono molto ai lettori, ma comportano rischi e rinunce
di Eve Fairbanks – Washington Post @evefairbanks
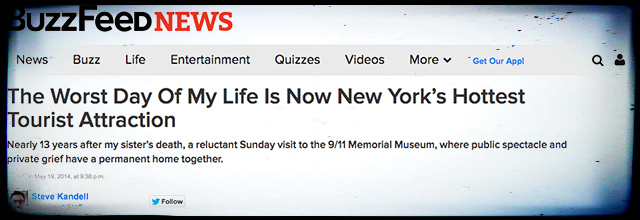
“La mia vita da persona piccola”, “Sogno ancora lo stupratore che una volta consideravo mio padre”, “La mia start-up è fallita, e questo è come ci si sente”, “Il giorno peggiore della mia vita ora è l’attrazione turistica più in voga di New York”, “Capisco perché gli occidentali si uniscono ai movimenti jihadisti: per poco non l’ho fatto anch’io”.
Sono dovunque, in questi giorni: storie che seguono la formula “Io sono X, e mi è successo Y!”. Questo genere di articoli-confessione in prima persona sono stati a lungo i barbari in agguato ai cancelli della tradizionale cultura giornalistica, comparendo su blog o su rubriche di nicchia come Modern Love, mentre i territori del giornalismo serio rimanevano dominati da figure autorevoli come Larry Summers o Aaron David Miller, che pontificavano sull’economia o sul conflitto israelo-palestinese.
Ora, però, sono entrati nella cittadella. La CNN ha annunciato un nuovo progetto chiamato “First Person”, una “serie di racconti personali che esplorano le identità e i punti di vista personali che danno forma a chi siamo”. BuzzFeed ha detto di cercare racconti personali. C’è un magazine, PostEverything, che ha partecipato a questa moda pubblicando articoli in prima persona di immigrati clandestini che sono andati a Harvard, di poliziotti che avvisavano i civili di non sfidarli se non volevano farsi male, e di proprietari di Mercedes che vivevano grazie ai sussidi sociali. Io sono stata formata professionalmente come un cronista politico tradizionale, ma ho scritto anche pezzi del genere, riflettendo sulle mie esperienze in cucina e nel coltivare piante in balcone.
Un redattore del New York Times mi ha detto che il suo giornale sta attivamente cercando più racconti personali – tipo “Perché sono invidioso dell’assicurazione sanitaria del mio cane” – perché «la risposta dei lettori è fantastica». Mi ha anche spiegato che «una volta era: ‘Troviamo un politico che si è occupato di diritti gay’. Ora invece diciamo anche: ‘Troviamo qualcuno che si è appena sposato! Troviamo qualcuno che ha qualche qualifica unica per parlare di un argomento. Troviamo qualcuno che abbia un’identità che gli attribuisca autorità’”.
Per alcuni ovvi motivi, la crescita di popolarità dei racconti personali è una cosa bella. Incanala la nostra profonda sfiducia nelle élite, dopo il disastro dell’Iraq e la crisi finanziaria, entrambi provocati da esperti lontani che avevano poca esperienza diretta delle cose – come le dittature, o i subprime – che dicevano di capire così bene. Ora vogliamo il contrario: ascoltare quello che hanno da dire le persone sul campo, per conoscere punti di vista talmente legati all’esperienza personale che pensiamo debbano per forza essere veri.
Il responsabile degli op-ed sul New York Times – gli editoriali e le storie scritte da persone esterne al giornale – ha chiamato questa tendenza «una radicale democratizzazione delle opinioni» che da certi punti di vista rappresenta un grande trionfo della democrazia, realizzando la promessa – propria della letteratura – che la vita di chiunque, dall’imprenditore in crisi al poliziotto al tizio qualunque che invidia l’assicurazione del suo cane, merita uguale interesse e dignità. Charles Blow, in una recente confessione sul New York Times riguardo la sua sessualità ambigua, ha scritto che il suo percorso personale lo ha portato a scoprire che «non ci sono gerarchie nell’umanità. Non c’è un solo modo di esistere, nemmeno due, ma molti». Questa frase descrive come mi sento dopo aver letto le cose migliori venute fuori da questa ondata di articoli in prima persona scritti da persone esterne alle redazioni: incantata dalla eccezionale varietà delle esperienze umane, dalla miriade di maniere per essere felice e per amare gli altri e il proprio mondo che trovano le persone che soffrono.
Penso anche che l’esplosione dei racconti personali rispecchi la nostra agitazione per i tagli dei budget per le inchieste e la maggiore superficialità dei reportage che necessariamente ne consegue. Una persona che dia un punto di vista personale su un fatto di attualità – per esempio, questo emozionante articolo su una profonda storia personale che racconta come i ritardi nella modifica del Defense of Marriage Act possano sconvolgere una famiglia – può non essere il risultato di un mese di indagini con un ampio budget, come ai vecchi tempi, ma invece porta come contributo alla storia l’esperienza di una vita intera. «Tutto è così rapido e veloce che è bello avere a disposizione questi racconti personali per fermarsi e andare più a fondo», mi ha detto Rachel Levin, una redattrice del giornale online Ozy (che sta per lanciare una nuova sezione che lei chiama “Venerdì in prima persona”), quando le ho chiesto perché amasse i racconti autobiografici.
Mi ha sorpreso un po’, perché giornalisticamente è lapalissiano che una testimonianza personale sia in realtà più veloce e facile da scrivere di un reportage. Forse, in questa nostra era di notizie a scadenza immediata e budget ridotti all’osso, scandagliare la propria vita sembra essere l’unico modo per soffermarsi un po’ su un argomento, per prendere un respiro e dire qualcosa più lentamente e di più ragionato, di spostare il concetto di “reporting” verso un arco temporale più ampio di quello della conferenza stampa della mattina.
Eppure, perdiamo qualcosa di importante nella corsa agli articoli autobiografici. Prima di tutto, anche se abbiamo diversificato i contenuti delle nostre pagine di opinioni, chi scrive su quelle pagine resta fondamentalmente un gruppo di persone che sanno scrivere. Documentandomi sulle biografie di chi scrive storie personali, ho scoperto che la maggior parte di essi fa il giornalista o comunque scrive per professione: dalla nana che ha scritto per CNN al tizio la cui tragedia personale è diventata un’attrazione turistica di New York al signore invidioso dell’assicurazione del suo cane. Quindi forse quello che vediamo come la cosiddetta “democratizzazione delle opinioni” è in realtà quanto siano strane e varie le vite di chi scrive per lavoro, e non una finestra spalancata sull’esperienza umana. Da Omero in poi, è sempre stato un dovere dei reporter raccontare le vite di quelle persone che non erano in grado di produrre grandi storie sulle proprie incredibili esperienze (questo lungo profilo su uno spazzino analfabeta del Cairo ne è un ottimo esempio). Abbiamo bisogno che i nostri reporter indaghino sulle storie di queste persone, esattamente come lo abbiamo sempre avuto.
La seconda convinzione diffusa riguardo l’esplosione degli articoli autobiografici è che il racconto di una persona sulla propria vita sia sempre quello più interessante. Con queste confessioni personali crediamo di avvicinarci di più alla verità, come suggerisce il nome alternativo di Ozy alla rubrica “Venerdì in prima persona”: “Storie vere”. Ma se questo fosse vero, non ci sarebbero mai state le biografie, i diari di viaggio o perfino i romanzi, che si basano sulla premessa che un narratore invisibile capisce la verità sui personaggi, spesso incapaci di giudizi obiettivi su se stessi, meglio dei personaggi stessi. Non ci sarebbero le rubriche di consigli, o gli psicologi.
Leggendo molti articoli autobiografici penso spesso che vorrei che chi li scrive avesse avuto un interlocutore esplicitamente visibile nell’articolo, qualcuno che avesse fatto più domande e offerto un punto di vista esterno. Prendete questo racconto di una cinica scrittrice newyorkese che ha un’esperienza inaspettatamente eccezionale in una bottega di un cartomante, e che segretamente diventa una cartomante a sua volta. Inevitabilmente è molto divertente, ma non riesco a smettere di pensare a quanto sarebbe potuto essere più divertente e rivelatore se fosse stato scritto da un giornalista che fosse andato nello studio della donna a indagare un po’ più a fondo di quanto abbia fatto lei stessa sul perché, esattamente, i tarocchi la abbiano resa capace di risolvere quei problemi – difficoltà con la carriera, un’ossessione per un ex – per i quali la maggior parte di noi annaspa per una vita intera, e senza riuscire a risolverli. La sua risposta è banalmente: i tarocchi mi stavano «raccontando una storia sulla mia vita (…) Nella mia vita litigavo con qualsiasi cosa perché ero insoddisfatta».
O vedetela dal punto di vista opposto. Pensate a uno dei più brillanti articoli pubblicati recentemente, sull’ex presidente georgiano Mikhail Saakashvili, caduto in disgrazia, che fa lavoretti qua e là come barista o fattorino a Williamsburg, cercando di sentirsi di nuovo importante e al passo coi tempi. Quel ritratto era una divertentissima, toccante e intensa rivelazione sui tormenti e sul tedio del leader di una piccola nazione, mitizzato dall’Occidente come un portatore di democrazia e poi violentemente emarginato dai suoi concittadini. «Williamsburg è parte della trasformazione democratica» dice con fare premonitore al giornalista, che nel frattempo lo descrive mentre corre attorno a un mercato hipster con scarpe da ginnastica verde fosforescente vantandosi di fronte a chiunque sia disposto ad ascoltarlo di «un mio amico, uno dei più importanti sceicchi degli Emirati Arabi», e comprando cinquanta orologi fatti con vecchi libri per «la mia biblioteca presidenziale».
Ora immaginate se fosse stato un articolo autobiografico, scritto da Saakashvili stesso. Si sarebbe potuto intitolare “Come il mio paese ha abbandonato la vera democrazia e io l’ho ritrovata a Williamsburg”. Sarebbe stato ridicolo. Tutta quella tristezza e quelle sottili verità, tutta la discrepanza tra come ci immaginiamo e chi siamo veramente – la discrepanza che sorregge l’intera commedia tragica dell’esistenza umana – si sarebbe perduta. A volte le verità più profonde sono quelle che non possiamo proprio affrontare da soli.
© Washington Post 2014



