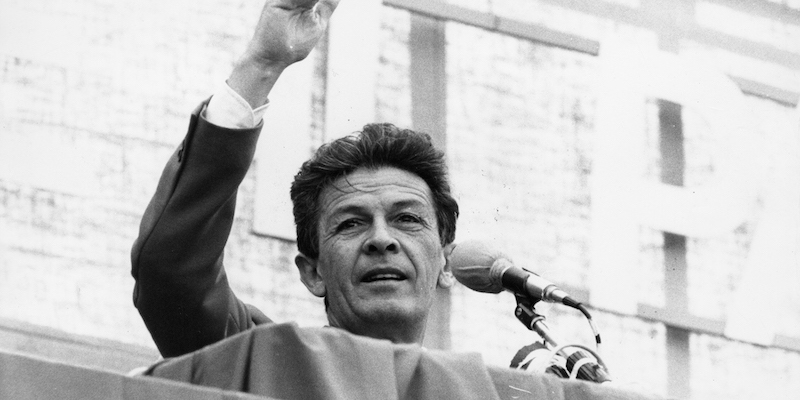La prigione di Stanford
La storia del più celebre esperimento di psicologia sociale di sempre, cominciato nell'agosto del 1971 nei sotterranei di una facoltà di psicologia e interrotto dopo soltanto sei giorni
di Giovanni Zagni

Dave Eshelman oggi è un signore dai modi educati, proprietario di un’agenzia che si occupa di mutui a Saratoga, una cittadina californiana vicino a San Francisco. Nell’agosto 1971, era uno studente della Chapman University di Orange, nel sud nello Stato, e cercava un lavoretto per l’estate. Le possibilità erano un impiego in una pizzeria oppure rispondere a un annuncio che aveva trovato sullo Stanford Daily, il quotidiano degli studenti distribuito nel campus dell’università di Stanford (dove suo padre insegnava ingegneria): «Studenti maschi che frequentano il college richiesti per uno studio psicologico sulla vita carceraria. 15$ al giorno per 1-2 settimane.»
Insieme a Eshelman risposero più di 70 persone. Un giovane professore di psicologia di 38 anni di nome Philip Zimbardo e il suo gruppo di ricercatori (Craig Haney, W. Curtis Banks e David Jaffe) sottoposero loro una serie di test della personalità e selezionarono 24 ragazzi bianchi che non avevano mai avuto problemi con la giustizia e non avevano problemi di instabilità o fragilità psicologica. Poi tirarono una moneta e assegnarono casualmente a ciascuno di loro il ruolo di “prigioniero” o di “guardia” in quello che diventerà il più celebre esperimento di psicologia sociale della storia, l’esperimento della prigione di Stanford. Eschelman venne scelto e diventò una “guardia”.
L’arresto, la prigione, le regole
Nella mattinata di domenica 14 agosto 1971, una bella giornata di sole a Palo Alto, California, diverse auto della polizia arrivarono a casa di una decina di studenti del college selezionati per l’esperimento. Notificarono a ciascuno l’arresto per furto e rapina a mano armata e li trascinarono fuori di casa sotto lo sguardo dei vicini, perquisendoli in strada prima di farli salire in macchina e allontanarsi verso la stazione di polizia. I volontari non sapevano che l’esperimento a cui avevano accettato di partecipare sarebbe iniziato con un vero arresto, sotto gli occhi dei parenti e dei vicini.
La polizia di Palo Alto aveva accettato di collaborare con il dipartimento di psicologia dell’università di Stanford e prese il compito molto sul serio: prelevò i ragazzi a casa dopo aver letto i loro diritti, li registrò seguendo la procedura regolare all’arrivo alla stazione e li tenne qualche tempo in una cella con gli occhi bendati.
Gli arrestati vennero quindi portati in un seminterrato di Jordan Hall, una costruzione sul cortile principale dell’università che era (ed è tuttora) sede del dipartimento di psicologia. Qui erano state chiuse le due estremità di un corridoio, e le porte in legno di tre laboratori che si aprivano sui lati erano state sostituite da altre formate da sbarre di ferro. Ciascuna delle celle, molto strette, avrebbe ospitato tre prigionieri. A una estremità, uno sgabuzzino di sessanta centimetri per sessanta, che diventerà famoso tra i prigionieri come “la buca” e in cui finiranno quelli puniti con l’isolamento. Nell’ambiente non c’erano finestre né orologi.
Dopo l’ingresso nella “prigione della contea di Stanford”, ogni detenuto venne perquisito, denudato e spruzzato dalle guardie con uno spray, mimando le normali pratiche carcerarie. Invece di essere rasato, gli venne messo in testa un copricapo ricavato da una calza di nylon. Alla caviglia destra gli venne chiusa con due lucchetti una pesante catena ad anelli di metallo. La catena non sarebbe stata tolta in nessuna occasione, neppure durante la notte. L’unico capo di abbigliamento sopra il corpo nudo era un camicione lungo, di colore bianco, con davanti e dietro il numero di matricola personale di tre o quattro cifre.
Le nove guardie, che si alternavano in tre turni da otto ore, indossavano tutte la stessa divisa cachi, avevano un fischietto al collo e un manganello prestato dalla polizia. I loro occhi erano nascosti dietro occhiali scuri, per evitare di mostrare qualsiasi emozione ai prigionieri. Alle guardie non era stata data nessuna indicazione specifica su come comportarsi, ma era stato detto loro che, per mantenere l’ordine nella prigione, potevano fare qualsiasi cosa che non attentasse all’integrità fisica dei detenuti. Oltre ai diciotto volontari coinvolti inizialmente, nove guardie e nove prigionieri, altri sei rimanevano disponibili nel caso fossero necessari rinforzi per le guardie o rimpiazzi per i prigionieri.
Le regole scritte della prigione vennero preparate dalle guardie con la supervisione degli psicologi che seguivano l’esperimento. Vennero lette due volte all’inizio della detenzione, a tutti i detenuti schierati nel corridoio tra le celle. Erano diciassette punti, circa una pagina di testo. I prigionieri dovevano, tra le altre cose, tenere pulite e ordinate le celle, chiamare le guardie esclusivamente “signora guardia carceraria” e chiamarsi l’un l’altro solo con il numero di matricola. La regola numero nove diceva: “i prigionieri non devono mai riferirsi alla loro condizione come a un ‘esperimento’ o a una ‘simulazione’. Sono in prigione fino al rilascio” e l’ultima, la numero diciassette, stabiliva che “il mancato rispetto di una qualsiasi delle norme precedenti può risultare in una punizione”.
Le rivolte
La prima “conta” dei prigionieri venne ordinata dalle guardie alle due e mezza del mattino della prima notte. I prigionieri furono svegliati, si disposero lungo il corridoio con la faccia rivolta verso il muro. Le guardie fecero l’appello, e dopo una decina di minuti li lasciarono tornare a dormire.
Il primo giorno passò senza incidenti. Non solo, ma le guardie sembravano piuttosto a disagio, incerte della loro autorità, spesso indecise o imbarazzate. L’atmosfera assomigliava molto poco a quella di una prigione. Il professor Zimbardo pensò che non sarebbe successo nulla per due settimane, e che tutto si sarebbe risolto in una gran noia: forse i detenuti si sarebbero semplicemente seduti nelle loro celle e avrebbero suonato la chitarra tutto il tempo. La mattina del secondo giorno, cogliendo guardie e ricercatori di sorpresa, i detenuti inscenarono una rivolta. Si tolsero il copricapo dalla testa, spinsero i materassi contro le porte e iniziarono a prendere in giro le guardie, urlando insulti. Il turno di giorno delle guardie arrivò (quando non partecipavano all’esperimento, le guardie potevano tornare alle loro case) e se la prese con i “colleghi” del turno precedente, che a loro dire avevano lasciato che si creasse quella situazione difficile.
Il nuovo turno decise di chiedere rinforzi, mentre il turno di notte rimase volontariamente per aiutare a sedare la rivolta. Le tre guardie non coinvolte all’inizio dell’esperimento furono chiamate a casa, arrivarono al dipartimento e entrarono anche loro nel sotterraneo della facoltà di psicologia. I nove uomini decisero di risolvere la situazione usando gli estintori che erano stati portati nella prigione per rispetto alle norme antincendio, e iniziarono a spruzzare anidride carbonica sui detenuti per allontanarli dalle porte. Poi entrarono nelle celle, denudarono i detenuti, portarono fuori i letti e misero quelli che credevano i capi della rivolta in isolamento nella “buca”.
Bastò la prima rivolta a mutare l’atteggiamento delle guardie, fino al giorno prima piuttosto incerte sul da farsi. Pensarono a un sistema per evitare che succedessero altre rivolte in futuro, e stabilirono la “cella dei privilegi”: ci misero dentro i tre prigionieri meno coinvolti, ai quali non venne sospeso il cibo e il diritto di lavarsi, come invece fu fatto per gli altri sei. Dopo mezza giornata le guardie sostituirono arbitrariamente gli occupanti della cella privilegiata con altri prigionieri, in modo da rompere la solidarietà tra di loro e istigarli al sospetto reciproco.
Le guardie iniziarono anche a negare il diritto ad andare in bagno dopo lo spegnimento delle luci per la notte alle dieci di sera, costringendo i prigionieri ad utilizzare i due secchi che erano in dotazione ad ogni cella. L’ambiente si riempì di cattivi odori. Dopo trentasei ore dall’inizio dell’esperimento, la notte tra il 15 e il 16 agosto, i supervisori decisero di liberare il detenuto numero 8612, che aveva iniziato a soffrire di scoppi di pianto incontrollati e di attacchi d’ira.
Dave Eschelman fu una delle guardie più crudeli verso i prigionieri. Intervistato dal periodico degli ex allievi dell’università per il quarantesimo anniversario, insieme agli altri protagonisti dell’esperimento, dice che il suo comportamento non fu casuale. “Fu programmato. Partecipai con un piano ben definito in testa, quello di provare a forzare la situazione, fare in modo che succedesse qualcosa, in modo che i ricercatori avessero qualcosa su cui lavorare. […] Al college e alle superiori partecipavo a tutte le recite teatrali. Si trattava di qualcosa a cui ero molto abituato: immedesimarsi in un’altra personalità prima di entrare sul palcoscenico.” I prigionieri lo soprannominarono “John Wayne” per i suoi modi arroganti. Lui dice che aveva bene in testa il modello che voleva seguire: il responsabile della prigione nel film Cool Hand Luke con Paul Newman (in italiano Nick mano fredda, 1967), detto “il Capitano” e interpretato da Strother Martin.
Il giorno successivo ci furono le visite dei parenti e amici dei prigionieri. I responsabili dell’esperimento decisero di migliorare le condizioni del carcere facendo pulire le celle, permettendo loro di lavarsi e sbarbarsi, suonando musica nell’interfono e dando loro una cena migliore del solito e più abbondante la sera prima. Invitarono pure un’ex cheerleader dell’università per accogliere i parenti in visita. Una madre disse al professor Zimbardo che non aveva mai visto suo figlio stare così male, ma lo psicologo rispose girando la domande al padre, anche lui presente alla visita: credeva che suo figlio non sarebbe stato in grado di sostenere una situazione dura come quella? Il padre sembrò punto sul vivo e rispose che suo figlio era un tipo tosto, un vero leader, e che ce l’avrebbe fatta. I genitori se ne andarono. Da quella sera, Zimbardo iniziò a non tornare a casa per la notte e a dormire nelle stanze adiacenti al luogo dell’esperimento.
Quando camminava per lo stretto corridoio al centro della finta “prigione della contea di Stanford”, Zimbardo ora metteva le mani dietro la schiena. “Come un generale che ispeziona le truppe”, ricorda, “una postura che non ho mai avuto in vita mia, né prima né dopo.”
Il piano di fuga
Lo stesso giorno delle visite, una guardia sentì due prigionieri parlare di un piano di fuga: il volontario rilasciato il secondo giorno sarebbe tornato con un gruppo di amici, subito dopo l’orario delle visite, e avrebbe cercato di liberare tutti i prigionieri. Zimbardo e il suo gruppo di ricercatori tennero una riunione tra loro per cercare di sventare il piano. Ormai non erano più solo gli osservatori di un esperimento, che rimanevano distaccati e neutrali: ne erano diventati una parte. Decisero di intervenire per salvaguardare la sicurezza della loro prigione. Zimbardo andò personalmente al dipartimento di polizia di Palo Alto e chiese se poteva far trasferire i suoi volontari in una prigione in disuso. La polizia rifiutò, per problemi di assicurazione. Zimbardo ricorda che lasciò la centrale di polizia “arrabbiato e disgustato”.
I responsabili dovevano evitare l’evasione da soli. Decisero che dopo le visite avrebbero chiamato rinforzi per le guardie, incatenato insieme i prigionieri e coperto le loro teste con dei sacchi prima di portarli in una stanza al quinto piano. Quando sarebbero arrivati l’ex prigioniero 8612 e i suoi amici, avrebbero trovato il solo Zimbardo che avrebbe detto loro che l’esperimento era finito e tutti i volontari erano stati mandati a casa. Poi avrebbero riportato giù i prigionieri e raddoppiato la sicurezza. Pensarono anche a trattenere l’ex prigioniero 8612 con un pretesto e di rinchiuderlo di nuovo, per fargliela pagare. Zimbardo rimase solo nel corridoio, parzialmente smantellato. Attese per parecchio tempo, ma per qualche motivo l’ex prigioniero 8612 e i suoi amici non si presentarono. I prigionieri vennero riportati nelle celle.
Da quel giorno le guardie aumentarono ancora la loro crudeltà nei confronti dei prigionieri, facendo loro eseguire in continuazione esercizi fisici punitivi, obbligandoli a pulire i bagni a mani nude, prolungando gli appelli notturni per ore. Non tutte le guardie si comportarono allo stesso modo: circa una su tre ebbe comportamenti particolarmente repressivi e crudeli, ma anche tra quelle più gentili verso i prigionieri nessuna pensò mai di mettere in discussione i trattamenti più duri imposti da “John Wayne” e dagli altri, che assunsero di fatto un ruolo di guida. Nessuna guardia arrivò mai in ritardo al suo turno alla prigione e nessuna chiese di lasciare l’esperimento in anticipo.
Tra i prigionieri, invece, un secondo venne rilasciato e un terzo pianse istericamente mentre ai suoi compagni veniva fatto cantare “il prigioniero 819 è un cattivo prigioniero e per questo motivo la mia cella è disordinata, signor sovrintendente”. Quando a un quarto venne negata la libertà vigilata da un’apposita commissione, l’ennesima finzione per rendere più realistica la prigione, sviluppò uno sfogo cutaneo su tutto il corpo.
Il quinto giorno venne introdotto nella prigione un nuovo volontario, con il numero di matricola 416. Il suo impatto con la situazione fu durissimo, dato che non era presente durante il crescendo di pressioni e punizioni dei giorni precedenti. Decise di iniziare uno sciopero della fame per ottenere il suo rilascio.
Le guardie non riuscirono in nessun modo a fargli accettare il cibo e lo misero in isolamento per tre ore (il limite massimo, in precedenza, era stato di un’ora). Una guardia, che nella vita era un pacifista convinto, che aveva partecipato a diverse manifestazioni contro la guerra in Vietnam, provò a forzare il prigioniero 416 fino a sporcargli tutto il viso di cibo. Ricordando quel momento, dice che provava odio verso se stesso per quello che stava facendo, ma soprattutto odio verso il prigioniero che con la sua ostinazione lo stava costringendo a fargli quella violenza.
Agli altri prigionieri, le guardie presentarono una scelta: il numero 416 sarebbe rimasto in isolamento tutta la notte, oppure quelli rimasti in cella avrebbero dovuto rinunciare alle loro lenzuola. I prigionieri rifiutarono, ma i responsabili dell’esperimento fecero rientrare lo stesso il numero 416 nella sua cella. Invece di sostenere la sua protesta, i suoi compagni lo vedevano come una fonte di problemi.
Dopo cinque giorni di esperimento, notò Zimbardo, i prigionieri non avevano alcuna solidarietà reciproca. Molto indicativo è il fatto che, rinchiusi nelle celle, non parlassero mai tra loro di storie personali e di argomenti che riguardassero il mondo fuori dalla prigione: la loro immedesimazione nel ruolo del carcerato era totale e il fatto che si trattasse di una situazione temporanea non aveva alcuna influenza sui loro discorsi e sul loro comportamento. SI comportavano esattamente come se fossero stati in prigione davvero.
La fine
Christina Maslach aveva appena finito il dottorato in psicologia a Stanford e, fatto ancora più importante, era la ragazza del professor Zimbardo (si sposeranno un paio d’anni dopo l’esperimento). La sera di giovedì 18 agosto andò a visitare il luogo dell’esperimento, nei sotterranei della facoltà. Vide le guardie allineare i prigionieri per la conta delle dieci di sera, prima che venissero portati in bagno e venisse spenta la luce. Le guardie coprirono le loro teste con dei sacchetti e incatenarono insieme i loro piedi, urlando e insultandoli. Maslach scoppiò in lacrime e se ne andò, dicendo che non riusciva a sopportare quello che stava vedendo. Zimbardo la seguì fuori da Jordan Hall e i due ebbero un grosso litigio.
Delle circa dieci persone (di solito altri studenti o ricercatori della facoltà di psicologia) che avevano visitato il luogo dell’esperimento prima di Maslach, nessuna aveva sollevato obiezioni di tipo etico su quanto stesse succedendo, ma l’ultimo litigio fece aprire gli occhi a Zimbardo. Le guardie, notò, diventavano più dure durante la notte, quando credevano di non essere sorvegliate dai ricercatori, imponendo ai prigionieri punizioni umilianti e spesso a sfondo sessuale. Lo stesso professore si interrogò sul proprio ruolo e sulla gestione dell’esperimento. Sabato 20 agosto 1971, dopo soli sei giorni dei quattordici previsti, il professor Zimbardo decise di interromperlo.
Nei colloqui che seguirono la fine, i prigionieri dimostrarono tutti di essere sollevati e contenti della conclusione anticipata. Le guardie, invece, ne erano molto insoddisfatte.
L’eredità dell’esperimento di Stanford
I risultati dell’esperimento della prigione di Stanford furono pubblicati da Zimbardo e dai suoi collaboratori su diverse riviste scientifiche. Zimbardo trasse conclusioni che deponevano fortemente a favore di un’interpretazione situazionale, piuttosto che disposizionale, del comportamento umano: in un determinato contesto, forniti di autorità e di una sorta di “alibi” giustificante, ragazzi senza precedenti violenti, ben educati e di un buon ambiente sociale si trasformavano in poco tempo in “guardie” oppressive e sadiche. Chiunque, in altre parole, poteva essere spinto da un certo contesto a commettere abusi, ridimensionando le teorie su una eventuale “predisposizione” di alcuni individui ad esercitare l’autorità con violenza.
L’esperimento venne anche molto criticato negli ambienti della psicologia, e anche se un’indagine dell’American Psychological Association concluse nel 1973 che l’esperimento rispettava le linee-guida della professione, gli attuali regolamenti per gli esperimenti di psicologia, approvati successivamente, ne impedirebbero lo svolgimento.
Alcuni studiosi misero in discussione il comportamento del professor Zimbardo. Tra questi, gli psicologi che condussero il “BBC Prison Study” trent’anni dopo: secondo loro, lo psicologo, agendo da “sovrintendente capo” della prigione e indirizzando alcuni discorsi alle guardie, avrebbe falsato il loro comportamento e avrebbe dato troppe istruzioni implicite su come comportarsi. Una guardia che partecipò all’esperimento è convinta ancora oggi che fu Zimbardo a causare il peggioramento della situazione, e che fin dall’inizio lo psicologo cercò di ottenere un “crescendo drammatico”.
Nel 2001, due professori di psicologia britannici, il professor Alex Haslam dell’università di Exeter e il professor Steve Reicher dell’università di St. Andrews, organizzarono un esperimento simile a quello di Stanford. Le registrazioni dell’esperimento vennero trasmesse nella miniserie in cinque puntate The Experiment, trasmessa dalla BBC a maggio 2002 (da cui il nome con cui è noto lo studio, chiamato “BBC Prison Study”).
L’esperimento durò nove giorni, due meno del previsto, e le cose andarono in modo del tutto diverso rispetto allo studio di trent’anni prima: le guardie non si adattarono mai facilmente ai loro ruoli e i prigionieri si ribellarono il sesto giorno riuscendo a prendere il controllo della situazione, ma gli attriti all’interno del gruppo dei detenuti portarono a un nuovo regime in cui alcune guardie si coalizzarono con alcuni detenuti. Solo a questo punto si creò un sistema tirannico simile a quella della prigione di Stanford, e i supervisori decisero di interrompere l’esperimento.
Contrariamente alle conclusioni di Zimbardo, secondo cui è il ruolo assegnato che crea i comportamenti della persona, il BBC Prison Study concluse che le condizioni per la creazione di una tirannia sono che, in primo luogo, si formi autonomamente un gruppo in cui c’è una leadership ben definita, e secondariamente che il gruppo definisca un progetto autoritario con cui pensa di risolvere problemi concreti. A Stanford, secondo Haslam e Reicher, Zimbardo falsò l’esperimento indirizzando le guardie sul loro ruolo e ponendosi così di fatto come il leader della loro fazione.
L’eredità dell’esperimento di Stanford è ancora attuale: quando emersero le immagini e le notizie degli abusi sui prigionieri iracheni da parte delle guardie statunitensi del carcere di Abu Ghraib, quello studio sull’ambiente carcerario ritornò di attualità. Il professor Zimbardo, in pensione da pochi anni dopo una luminosa carriera come psicologo negli Stati Uniti, venne nuovamente intervistato. Nel libro Prigioni della mente. Relazioni di oppressione e resistenza (2004), il docente dell’università di Padova Adriano Zamperini ha messo l’esperimento di Stanford a fianco dei casi di Abu Ghraib e della base di Guantanamo.
Sull’esperimento della prigione di Stanford sono stati fatti numerosi documentari e film, l’ultimo dei quali è del 2010, diretto dal creatore della serie tv Prison Break Paul Scheuring, con Adrien Brody e Forest Whitaker. Zimbardo dice ancora oggi che l’esperimento lo ha cambiato per sempre:
Dopo l’esperimento della prigione, sono diventato più consapevole del ruolo centrale del potere nelle nostre vite. Sono diventato più consapevole del potere che ho, come insegnante. Ho iniziato coscientemente a comportarmi in modo da minimizzare l’uso negativo del potere in classe. Ho spinto gli studenti a mettermi in discussione. Penso di essere diventato più riflessivo. Sono più generoso e più aperto, a causa di quell’esperienza. Penso che abbia fatto di me una persona migliore.