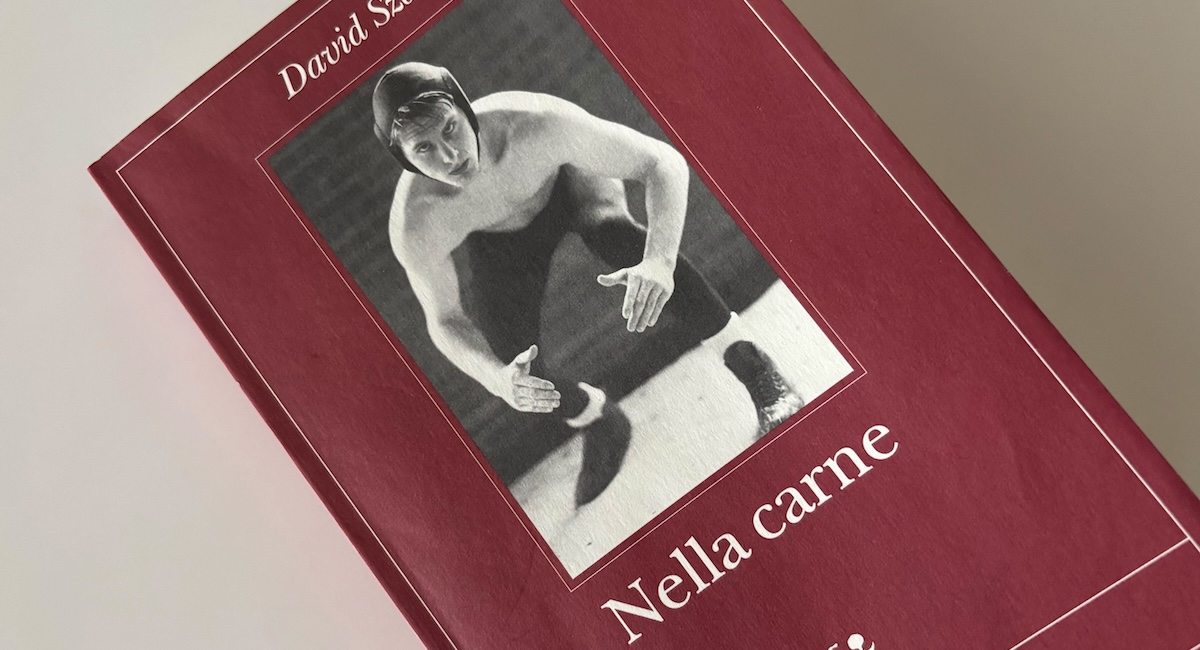Otto ore a Parigi
Otto ore trascorse nelle strade di Parigi, tra ieri notte e stamattina, e per me una sola domanda è rimasta a lungo senza risposta.
Purtroppo credo di sapere che cosa ha spinto i terroristi a uccidere, intuisco l’odio che evidentemente nutrono verso tutto ciò che siamo noi, ed è troppo facile inquadrare l’ondata di assalti della notte scorsa nella guerra totale che è stata scatenata attraverso i continenti ma riguarda ormai soprattutto l’Europa.
Mi pare poi chiaro che, una volta di più, i servizi di sicurezza che dovrebbero proteggere le nostre società hanno fallito tragicamente, patetico risultato di miliardi spesi in reti di controllo sempre più sofisticate e più inutili: è vero, ci sono azioni impossibili da prevedere e da prevenire; ma l’assemblarsi di un simile commando pesantemente armato non dovrebbe passare inosservato nel 2015.
Infine non ho dubbi sulla forza, la dimensione e la compattezza della reazione che Parigi e la Francia sapranno opporre a questo reiterato assalto: non mi ingannano le via deserte del X e XI arrondissement, i negozi chiusi in quasi tutta la città, il clima che si avverte che è di sorpresa, di dolore, di sospensione e di attesa, ma non di paura né di rassegnazione, nonostante tutto.
Ciò che per ore non riuscivo a capire è stata la logica con la quale sono stati scelti i luoghi, gli obiettivi, e dunque nomi e cognomi delle vittime di questa strage.
Si è già scritto: dallo stadio del calcio al ristorante cambogiano, dal teatro del rock al bistrot d’angolo, i posti più tipici del divertimento presunto “occidentale”. Con una conseguenza sull’età media delle vittime, sul loro essere giovani “qualunque”, non anziani né bambini stavolta, né ebrei o intellettuali laici, o agenti di polizia. È una spiegazione convincente, ma mi pareva insufficiente: di ristoranti come Le Petite Cambodge e bistrot come La Belle Equipe ce ne sono migliaia a Parigi, decine e decine solo nelle strade intorno alle tappe della strage: perché colpire proprio questi e non altri?
Anche per trovare un minimo senso all’accaduto ho visitato nell’arco della mattina quattro di questi teatri di guerra, spostandomi su una bici del noleggio comunale. Secondo una prima teoria degli investigatori, ho seguito il percorso compiuto venerdì sera da un paio di automobili cariche di uomini armati: è possibile che si spostassero per il quartiere, colpendo a casaccio per disorientare la polizia mentre in realtà stavano convergendo sul teatro dell’eccidio finale, il Bataclan, per allestire lì dentro la replica della decimazione compiuta dai ceceni nel teatro Dubrovka di Mosca, nel 2002?
Per quanto sinistra e folle, questa ricostruzione è l’unica possibile. Mentre scrivo non so nulla del lavoro della polizia, ma unendo i punti sia sulla mappa che a forza di pedali, l’ipotesi sta in piedi. A patto naturalmente che fossero più d’uno i terroristi minimamente esperti della zona, e a patto di considerare anche le esplosioni dello Stade de France come un’azione micidiale ma diversiva.
Mi è sembrata particolarmente illuminante la scena assurda che ho visto all’angolo tra Rue du Faubourg du Temple, Rue de la Fontaine au Roi e Quai de Jemmapes, a due passi da Place de la Republique. Tra bar, ristoranti e tintorie, qui non c’è una sola vetrina risparmiata dalle pallottole. Stessa situazione al lato opposto dell’isolato, tra Rue Alibert e Rue Bichat. Un numero ancora imprecisato di morti e feriti. Colpiti da raffiche sparate da un’auto in corsa contro qualsiasi locale aperto a quell’ora, contro chiunque: una cosa da gangster di Chicago, oltre cento proiettili ritrovati sul terreno. Un raid del genere in una zona relativamente insignificante del X arrondissement può aver appunto un solo obiettivo: uccidere, terrorizzare, ma soprattutto deviare l’attenzione dal bersaglio principale.
E infatti la strage del Bataclan è incomparabile, per svolgimento ed esito, con gli altri assalti. Ed è lì, forse più rapidamente di quanto i terroristi avessero calcolato, che tutto è finito (ammesso che sia finito).
Ero a duecento metri dal teatro, dietro il nastro vigilato dalla polizia che sbarrava Boulevard Richard-Lenoir e impediva di avvicinarsi a chiunque, quando verso mezzanotte è partito il blitz delle forze speciali annunciato da esplosioni di diversa entità e raffiche di armi automatiche. Già si avevano notizie confuse su decine di morti all’interno, esecuzioni a freddo, appunto la decimazione del Dubrovka. Una situazione terrificante al solo immaginarla. E quando ancora non si sapeva quella fosse stato l’esito del blitz, il segnale che la tragedia si era comunque consumata per lasciare spazio ad altro è venuto da uno spettacolo surreale, da film: l’arrivo dal fondo del boulevard, da piazza della Bastiglia, di un interminabile corteo di auto blu, furgoni e fuoristrada blindati, motociclisti in borghese con i mitra in pugno.
Era Francois Hollande, con gli uomini del suo governo, che si presentava sul luogo dell’eccidio per dichiarare che la reazione della Francia e dei suoi alleati sarà senza pietà.
Lo capisco. Ma non riesco a immaginare una reazione più dura ed efficace di quelle che già ci sono state in passato, che non hanno restituito sicurezza e pace né agli occidentali né al Medio Oriente. Nonostante tutto, per quanto assurdo e paradossale possa sembrare ora in questa giornata parigina, credo che dopo i giorni del dolore, dell’indignazione e della mobilitazione verrà il tempo dell’assuefazione. Se non altro, come forma estrema di autodifesa.