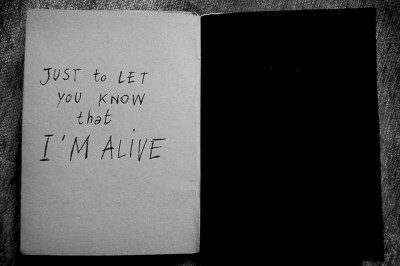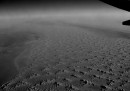Tre donne, un grant e un popolo
Protagonisti
C’è una signora di Los Angeles che dopo aver girato mezzo mondo fotografando e scrivendo, irrimediabilmente attratta dagli inferni in terra, s’inventa un grant come dicono loro, una borsa o un premio come diciamo noi, che invita a occuparsi di un angolo di mondo, di una guerra dimenticata, di una sofferenza collettiva. Lei si chiama Sara Terry e la sua creatura The Aftermath Project. Vale la pena tenerlo d’occhio perché ci si può fidare delle intenzioni, delle selezioni e della serietà.
C’è una fotografa italiana, strano caso nel mondo della fotografia, che da artista si fa fotogiornalista. Una migrazione in senso opposto, in barba alle sirene del collezionismo e dell’esibizione museale. Dopo autoritratti e nature morte, si è avventurata nel grande mondo reale. Non quello intimo che sussurra disagi e solitudini, ma quello delle guerre senza fine, quello delle vittime senza voce. Quello dove, quando arrivi dall’Italia con la macchina fotografica e le lingue imparate a Londra o a Parigi, non sei nessuno, sei incomprensibile e, soprattutto, non sei uno di loro. Si chiama Simona Ghizzoni, da Reggio Emilia.
C’è una giornalista d’inchiesta coraggiosa e caparbia. Una che ha scelto di stare fuori nel mondo e cercare sul campo le storie da raccontare. Quando la storia è troppo lunga e intensa per consumarsi nelle pagine di un giornale la trasforma in libro; quando c’è tanto da vedere e le parole sono solo la metà della storia, impara a girare documentari. Si chiama Emanuela Zuccalà, siciliana vera.
Come si combinano le tre ?
La prima indice uno special grant per la questione Saharawi.
La seconda decide di partecipare.
Sa che non basteranno le immagini. Bisogna approfondire per capire questa storia, costruirci intorno un progetto per andare davvero a fondo. O almeno provarci.
La terza è già stata nei territori Saharawi, deve solo rinfrescare la memoria e costruire un percorso d’inchiesta. Si mette a leggere e studiare. Butta giù la traccia.
Nasce il progetto
Vincono. Il premio finanzia un’indagine fotografica ma loro hanno vinto insieme e dunque partono. Tornano con la storia anzi, con molte storie. Molte donne si sono raccontate. I loro volti e i loro diari compongono un affresco nuovo che affonda nell’intimo e regala quella preziosa miscela che fonde l’inchiesta con le testimonianze dei singoli. Come ho già scritto in un post precedente, ogni storia appartiene al suo protagonista e nessuno è più anonimo. Registrano voci, prendono appunti, girano video. Nomi e circostanze diventano contenuto essenziale della storia.
Le fotografie che vedete sono solo un piccolo diario di questi viaggi.
Alla fine c’è tanto. Molto per l’Aftermath Project per cui erano partite e troppo per accontentarsi di pubblicare sui giornali con cui collaborano – dove però, una volta tanto, testo e foto dialogano coerentemente completandosi – c’è da dire e da far vedere di più. Montano tutto quello che hanno girato.
Il progetto è ora un documentario che cerca sostegno per essere completato e diffuso.
Per chi vuole saperne davvero di più.
Me, per esempio. Dopo tanti noiosi e polverosi reportage volevo ascoltare e vedere il Saharawi con occhi nuovi. Simona mi ha messo a disposizione le foto, non un vero e proprio lavoro documentario ma tanti appunti visivi. Emanuela mi ha raccontato la sua storia e il suo viaggio. Non mi hanno deluso.
C’è un popolo che si chiama Saharawi (non è il nome di un calciatore e neppure un resort in mezzo al deserto) e di cui stancamente ogni tanto leggiamo in fondo alle pagine di esteri. Discende da gruppi tribali che abitavano la regione del Sahara Occidentale (da cui il nome). Più arabi che africani, i Saharawi da tempo sono in una perenne diaspora. Non hanno terra, non hanno Stato e dunque diritti. Dagli anni Trenta hanno iniziato una lotta per l’indipendenza, prima dai colonizzatori spagnoli e poi dal Marocco che non gli ha riconosciuto l’autonomia nei territori del Sahara Occidentale che occupavano.
Per arrivare alla storia recente: il Marocco ha invaso il Sahara Occidentale il 31 ottobre del 1975, bombardandolo. L’esercito marocchino è arrivato da Nord, l’esercito mauritano da sud: l’hanno invaso dopo che la Spagna l’aveva abbandonato. Un gruppo nutrito di Saharawi, circa 200.000, è scappato a est in Algeria e ha chiesto asilo politico. Qui i Saharawi hanno ottenuto un territorio dove costruire i campi profughi. Nel 1976, un anno dopo il loro arrivo, hanno dichiarato la Repubblica Araba Saharawi Democratica (RASD). È una repubblica riconosciuta da più di 80 Paesi del mondo, dall’Unione Africana ma non da quella Europea e dagli Stati Uniti. Però è una Repubblica. Le donne in questo periodo di guerra, dal 1975 al 1991, si sono trovate da sole nei campi profughi a fare le tende e le casette con il fango, a costruire una vera società.
Oggi circa 150.000 Saharawi vivono nei campi profughi in Algeria – per la cronaca, dove è stata rapita e fortunatamente liberata la volontaria italiana Rossella Urru – gli altri, in condizioni peggiori e più oppressi, vivono nei territori che rivendicano nel sud del Marocco. Un terra che per il regno di Mohammed VI, colonizzazione spagnola a parte, è sempre stata una proprietà del Marocco. Vivono male, torturati e imprigionati a ogni alito di richiesta d’indipendenza. I giornalisti non ci vanno più, la situazione ristagna da troppo tempo. «Lavorare – dice Emanuela – è stato difficile: ci hanno seguito, controllato, senti sempre una strana pressione. In Sahara occidentale quelli che ti parlano direttamente in spagnolo lo capisci subito, sono Saharawi, militanti del Fronte Polisario, indipendentisti; quelli che parlano francese sono filo marocchini. Qui sono tutti mischiati, non si sa quanti siano, poiché il Marocco, quando ha invaso il Sahara occidentale, ha mandato i coloni: ha fatto le cosiddette “marce verdi” mandando centinaia di migliaia di persone a colonizzare queste terre, mescolando completamente le cose. In realtà le donne le distingui, quelle con la melfa, l’abito tradizionale Saharawi sono differenti dalle donne marocchine che hanno il velo e la tunica. Dai Saharawi siamo state accolte molto bene: hanno sete di giornalisti e di notizie, soffrono per quello che chiamano l’embargo mediatico e per la difficoltà a far uscire la loro voce all’esterno».
Il racconto di Emanuela continua: «I Saharawi oggi sono un popolo in diaspora: divisi tra i campi algerini, il sud Sahara e il resto del mondo dove si sono dispersi. Quelli che sono andati nei campi profughi non tornano nel Sahara occidentale perché preferiscono vivere poveri, senza cibo, con poca acqua ma comunque liberi. La Repubblica Saharawi è molto democratica, fanno tante attività culturali, hanno scuole, si respira un’aria un po’ comunista. Inizialmente il Fronte Polisario è stato decisamente un movimento di matrice comunista: ha resistito al crollo dei vari muri e oggi mantiene ancora il partito unico. A proposito di muri, il Marocco ne ha costruito uno di 2700 chilometri nel deserto che parte dal confine nord del Sahara occidentale e arriva fino alla Mauritania – costi altissimi di mantenimento e militarizzazione – per dividere i Saharawi dell’Algeria da quelli del Sahara occidentale. Hanno cominciato a costruirlo durante la guerra e oggi, con campo minato e filo spinato, non ha nulla da invidiare ai muri più celebri dell’atrocità recente e contemporanea. C’è un punto di questo sinistro percorso che si chiama El Rincón (l’angolo), qui vedi il muro che taglia in due il deserto del Sahara. Surreale se non fosse vero. Ma lo è».
Quanti siano oggi i Saharawi non si sa. «Cerco di fartela più breve possibile – continua Emanuela – Nel 1991 è finita la guerra, l’Onu ha fatto firmare alle due parti in lotta un cessate il fuoco. “Entro un anno farete un referendum, ha intimato, con il quale deciderete se essere indipendenti o annessi al Marocco”. Sono passati 20 anni da quel mancato referendum. Il vero problema del referendum è: come li identifichiamo questi Saharawi? Chi sono? Sono stati proposti una serie di criteri d’identificazione, quindi, sempre l’Onu, ha fatto un lavoro lungo più di dieci anni per identificare i Saharawi. Il Marocco ha presentato una serie di ricorsi, ovviamente non si sono messi d’accordo e i Saharawi non sono stati identificati». Il Marocco non ha nessuna intenzione di perdere questo lembo di terra strategico: regione di confine, collegamento tra il Maghreb e l’Africa, seconda riserva al mondo di fosfati, un mare pescosissimo e tante compagnie straniere che lo stanno esplorando alla ricerca di gas e petrolio e pare ce ne sia.
C’è uno specifico femminile, visto che si documentano sempre queste donne Saharawi?
«Sì – prosegue Emanuela – Molte delle icone di eroismo Saharawi sono donne. Quella più importante è un personaggio che prima o poi vincerà il Nobel – Aminatou Haidar – una che è stata in galera tre volte, per un totale di tantissimi anni, un’eroina assoluta. Così come tante altre che sono state imprigionate. Sono più le donne che emergono. Hanno avuto questa parità anche nel dolore. Il loro livello culturale è piuttosto alto, fondano associazioni, (il Marocco non le riconosce e quindi, di fatto, sono illegali). C’è, in loro, un grado di consapevolezza e di comunicazione davvero straordinario; le loro storie sono documentate, nomi e numeri, citano i rapporti di Amnesty International. Umanamente, un’esperienza straordinaria. L’ospitalità che ci hanno offerto è eccezionale: non hanno niente e ti danno tutto».
«Il referendum arriverà e saremo indipendenti», dicono dal Sud del Marocco ai campi algerini. Ci credono.
Lo scenario ideale sarebbe che i dispersi per il mondo e i profughi dei campi rientrassero nel Paese magrebino, avessero uno posto per vivere, un’identità da conservare, nascesse un nuovo Stato e fossero un popolo. Desideri legittimi e congrui. Come dargli torto.