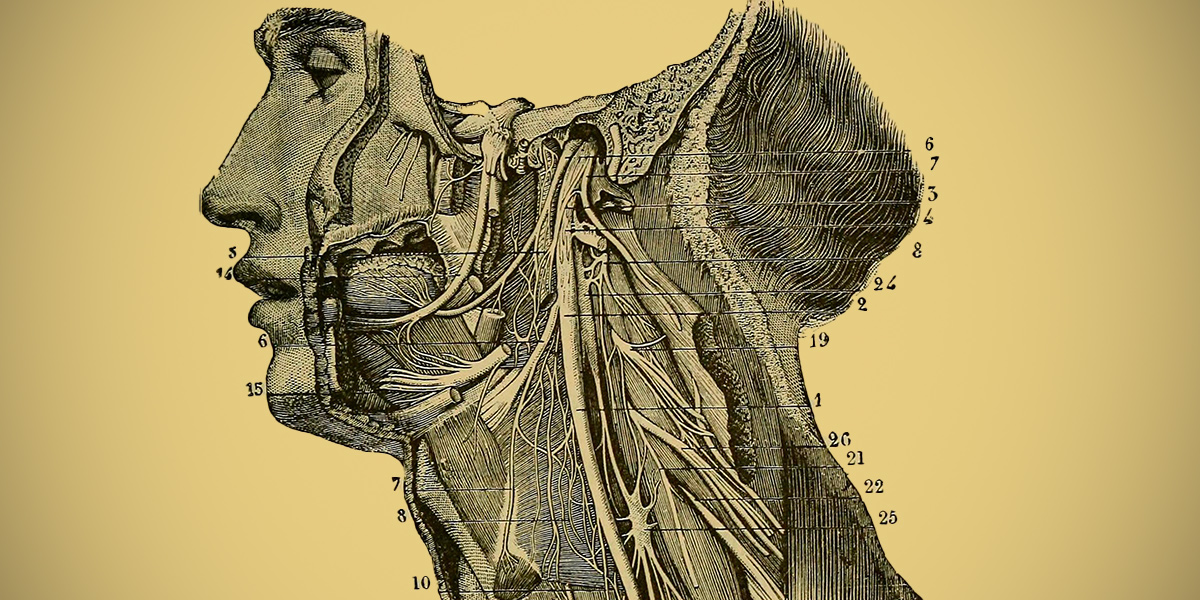Maturità, t’avessimo preso quando ci pareva
«Esiste una forma di scafatezza – con qualche utile venatura di ipocrisia, quanta ne basta per sorridere cordialmente a professori che sanno quasi niente di te, e tu quasi niente di loro – che aiuta a navigare e reggere le tempeste»

Il caso del maturando (più qualche seguace) che rifiuta la prova orale perché non ritiene umanamente all’altezza – lo dico a modo mio – il criterio di valutazione sembra fatto apposta per Ok Boomer!. Ovvero per sollecitare il vecchio mondo (eccomi) a confrontarsi con quello nuovo.
Fino a qui, è andata piuttosto bene: il patto era che il maturo tenutario di questa newsletter avrebbe detto la sua nella speranza di essere letto e anche contraddetto, in modo da imparare qualcosa, e in cambio, se ancora possibile, insegnare qualcosa. Così è stato, direi. Per esempio: ho imparato dai lettori del Post, specie quelli più giovani, che il lavoro non è più un valore assoluto (per me è una novità scioccante); che la sinistra è inchiodata a categorie novecentesche (dunque decrepite) e per questo parla poco e male a buona parte dei contemporanei; che Taylor Swift non è una cheerleader che ha avuto successo, è un’artista colta e importante. Non è mica poco.
Dunque, contando sulla confidenza tra anagraficamente diversi che si è instaurata qui, vi dico che secondo me quel ragazzo ha sbagliato. E ha sbagliato per la ragione opposta a quella che parecchi commentatori hanno supposto: dà troppa importanza a una commissione esaminatrice. Non è vero che la oltraggia o la disprezza (sarebbe il minore dei mali, a diciotto anni, voltare le spalle a una giuria di adulti). La promuove a un ruolo che non ha, quello di giudice della sua giovane vita.
Un esame è una convenzione sociale, è la maniera impropria, approssimativa ma in qualche modo necessaria per vagliare una qualità (la “maturità”!?) che la vita stabilirà poi per tutt’altre strade. Relativizzare le convenzioni sociali, non farsene opprimere più del necessario, cercare un “centro di gravità permanente” autonomo, e non troppo scalfibile, è il compito (difficilissimo) di ciascuno di noi. Imparare a convivere con sé stessi, magari perfino a stimarsi, senza disprezzare la valutazione degli altri ma anche senza darle eccessiva importanza: mi sembra una buona definizione di autonomia individuale, della forza e della salute psicologica di ciascuno di noi.
Immagino che l’intenzione di quel ragazzo fosse proprio quella di contrapporre l’irriducibilità del “sé” a una cerimonia di iniziazione, l’esame di maturità, non gradita e non condivisa. Ma il “sé”, mi permetto di dire, ne esce più fragile rispetto alle intenzioni. Dei patemi scolastici, e più in generale dell’ansia con la quale affrontiamo il giudizio degli altri, abbiamo tutti contezza. Anche per i più forti, addirittura per i più presuntuosi, viene comunque il momento in cui il vaglio sociale, le cose che dicono di te, la caratura che ti viene attribuita, risultano grevi, poco sopportabili, estranee al tuo modo di considerare la vita, e a volte umilianti. Un colloquio di lavoro, per esempio, è spesso al massimo grado il tipico caso di distonia totale tra la persona che pensi di essere e il ruolo che ha in mente chi ti sta di fronte.
Il meccanismo salvifico che può e anzi deve scattare – secondo me – è la capacità di relativizzare quegli impatti, da quelli inevitabili (un esame scolastico) a quelli più evitabili (i veleni dei social), sapendo che sono accidenti dei quali è lastricata la vita: per quanto dannosi, per quanto noiosi, non potranno mai cambiarci tanto profondamente da farci perdere la bussola di noi stessi. Dobbiamo essere osmotici rispetto agli altri, perché senza di loro non esisterebbe società e non esisteremmo neppure noi. Ma non al punto di concedere agli altri un potere di intrusione, di manipolazione, di assoggettamento che può storcere la nostra vita fino a spezzarla.
Quando leggo o sento dire che i ragazzi di oggi (categoria di una genericità inammissibile, diciamo dunque “molti ragazzi di oggi”) sono troppo individualisti, mi viene da replicare che non lo sono abbastanza. Il loro ego mi sembra molto vulnerabile, troppo esposto, come se mancasse una crosta, una protezione che custodisce la persona lungo il suo lungo viaggio. Un vero individualista dovrebbe munirsene.
Esiste una forma di scafatezza – con qualche utile venatura di ipocrisia, quanta ne basta per sorridere cordialmente a professori che non sanno quasi niente di te, e tu quasi niente di loro – che aiuta a navigare e reggere le tempeste. Mi rendo conto che “navigare” è un verbo discutibile, si dice spesso “quello sa come si naviga in società” intendendo che è un po’ paraculo, che sa come arrangiarsi, come cavarsela a buon prezzo. (Cavarmela a buon prezzo, ripensandoci, è stato il leitmotiv della mia intera carriera scolastica). Ma navigare, e farlo da scafati, ovvero con prua e chiglia in grado di reggere bene il mare, è anche un’arte avventurosa, una prova di destrezza, di forza morale.
Chi si occupa professionalmente dei ragazzi (psicologi e insegnanti) mette al centro della questione l’estrema fragilità/suscettibilità di molti di loro. Reggono male il giudizio degli altri, non riescono a relativizzarlo. Si lasciano ferire dalle chat, dalle parole svolazzanti e dagli sputacchi sprezzanti, si sentono “non capiti” dai professori, non bene descritti nelle valutazioni degli adulti.
Non lo direi in un serio convegno, non lo scriverei in un editoriale, ma penso che se invece di arrovellarsi troppo attorno al giudizio del mondo su di loro, trovassero la forza di un sereno e ben pronunciato “ma perché non ve ne andate tutti quanti affanculo?”, detto tra sé e sé, a bassa voce, di quelli che liberano il cuore e rendono la giornata leggera, avrebbero trovato la porta d’uscita.
*****
Poche ma buone le Zanzare di questa puntata. Con una nota estiva, in apertura, che ci fa sentire tutti al mare – così spero di voi – anche se non lo siamo. Si tratta di un cartello che Stefano ha fotografato in uno stabilimento balneare vicino a Messina. Dice così:
CON BANDIERA VERDE: BALNEAZIONE CONSENTITA, NON OBBLIGATORIA
Ci si domanda con quale bandiera esposta la balneazione diventi obbligatoria. A ricordarci che le guerre non fanno mai vacanza, Fernanda segnala questo notevole titolo, vagamente fantasy, dalla newsletter del Manifesto:
LA MOSCA COLPISCE DA EST A OVEST
ARMI A KIEV, RIPARTE IL FLUSSO
Fortunatamente c’è chi si attiva per mettere pace. Le insidie della consecutio tra le parole rendono però molto ambigue le loro intenzioni, come in questo titolo da Sky TG24, segnalato da Silvio:
UCRAINA, COSA ASPETTARSI DALLA CONFERENZA
SULLA RICOSTRUZIONE DI ROMA
Ma non sarebbe più urgente ricostruire Odessa e Kiev?
*****
Ha fatto piuttosto fresco, questa settimana, levando dalla pelle il ricordo del caldo spietato della seconda metà di giugno. Nelle chiacchiere sul tempo, la frase ricorrente è: “finalmente un’estate come una volta!”. Non sono sicuro che le estati “di una volta” fossero benevole, ricordo nel famigerato 2003, schiantato dal caldo notturno, di avere provato a dormire in terrazza, a Roma, portando il materasso all’aperto, e di essermi svegliato fradicio di sudore alle tre del mattino. E, da ragazzo, afe milanesi implacabili, di quelle che sciolgono l’asfalto e il cavalletto delle moto sprofonda. Però dicono le statistiche che le temperature medie effettivamente salgono, e l’anticiclone africano si sposta sempre più di frequente a settentrione, spingendo via le correnti atlantiche che ci darebbero beneficio. Dunque sì, fa sempre più caldo, e il benessere di questa settimana di luglio limpida di giorno, con poche nuvole bianche che pascolano nel celeste, e fresca di notte, che si deve anche tenere una coperta leggera ai piedi del letto, si sente eccome.
Mentre scrivo è domenica pomeriggio e sta piovendo, una pioggia fitta e sottile, prato e bosco sono contenti. L’erba medica è al sicuro, è stata imballata proprio stamattina e le rotoballe non temono la pioggia. Spiccano sul campo con una certa solennità e al tramonto fanno un’ombra lunga quasi come le pietre di Stonehenge. Se appoggiate male dalla macchina imballatrice (capita) possono rotolare a valle e sono anche pericolose, pesano quattro/cinque quintali. Una, anni fa, dalla cima del campo alto precipitò nel fondo della forra, in mezzo al roveto, quasi nel greto del torrente di fondovalle, e recuperarla fu un’impresa. Una rotoballa vale, negli anni d’oro, una settantina di euro, in quelli grami (come questo) una trentina. Se la si recupera non è dunque una questione di soldi, è una questione d’ordine. L’agricoltura è (anche) il tentativo, quasi sempre frustrato, di mettere ordine nel mondo e di mettere le briglie alle stagioni.
Le rotoballe di erba medica saranno il cibo autunnale e invernale del bestiame. Ancora per qualche giorno stazioneranno nel campo in attesa di essere ricoverate nei capannoni. Presidiano il paesaggio come sentinelle pingui e pigre, sono molto belle da vedere, chi non si è mai seduto su una rotoballa per guardarsi attorno non sa cosa si è perso.
Continua a piovere, e la terra profuma. È il 14 luglio, viva la Francia che è la mamma della democrazia. E in alto i cuori.