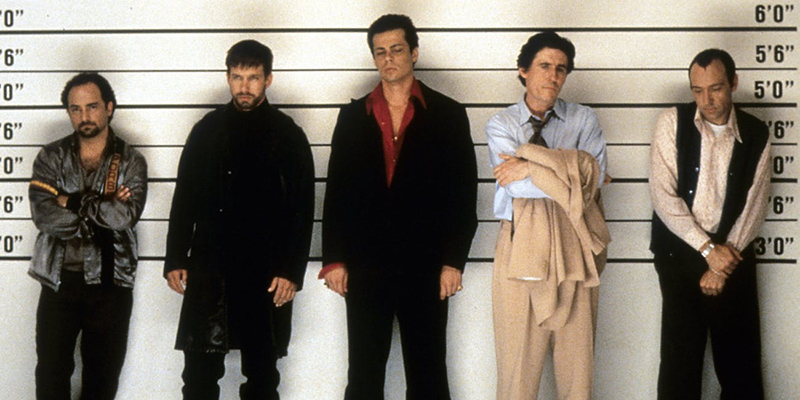Fumetti maledetti
Un atteggiamento che spesso riemerge, tra gli appassionati di fumetto, è il vittimismo culturale: i fumetti sono stati troppo bistrattati, eccetera eccetera. Ma al di là di una certa autoindulgenza un po’ nerd, è vero che, nella sua storia, il fumetto è stato oggetto di dibattiti pubblici particolarmente violenti. Lo testimoniano due libri in uscita in questi giorni. Che vi faranno ricredere sulla virulenza di ‘casi mediatici’ degli anni 2000 come Grand Theft Auto o Harry Potter.
Il primo è “Psychopathia Sexualis” (Purple Press – Castelvecchi). Si tratta di un fumetto di Miguel Angel Martìn, illustratore spagnolo, che racconta vicende disperatamente violente di serial killer, pedofili e altri aguzzini compulsivi, colti nell’oscena eccitazione per i propri delitti, in un asettico futuro dal bianco accecante. Nel 1995 venne pubblicato in Italia dalla piccola etichetta alternativa Topolin Edizioni. E in un battibaleno si beccò una sequela di denunce che non si vedevano dai tempi del Salò di Pasolini o di Ultimo Tango a Parigi: pubblicazione di spettacoli osceni; contenuto impressionante o raccapricciante; pornografia minorile – e altre amene ipotesi di reato.
Martìn era già un autore stimato in Spagna (mostre di Psychopathia ricevettero supporto da Ministero della Cultura e Comune di Barcellona) ma in Italia fu dipinto come pericoloso istigatore, e il suo editore si ritrovò oggetto di una brutale perquisizione domestica, trattato come fiancheggiatore della peggio feccia. Quasi invisibile a intellettuali e giornalisti, poco avvezzi a coprire un episodio di censura concernente il fumetto, l’editore – che nel frattempo ha cambiato mestiere – trovò per fortuna il supporto di disegnatori (tra cui Manara), scrittori (Covacich) e musicisti (Elisa, Prozac+ e Tre Allegri Ragazzi Morti), racimolando il denaro per pagare parte delle spese legali con cui, nell’arco di 6 anni, è riuscito a vedersi assolto in Cassazione. Il volume mi pare prezioso perché raccoglie alcuni materiali e testimonianze di questa vicenda, non ancora del tutto conclusa: resta aperto un procedimento per offesa al pudore.