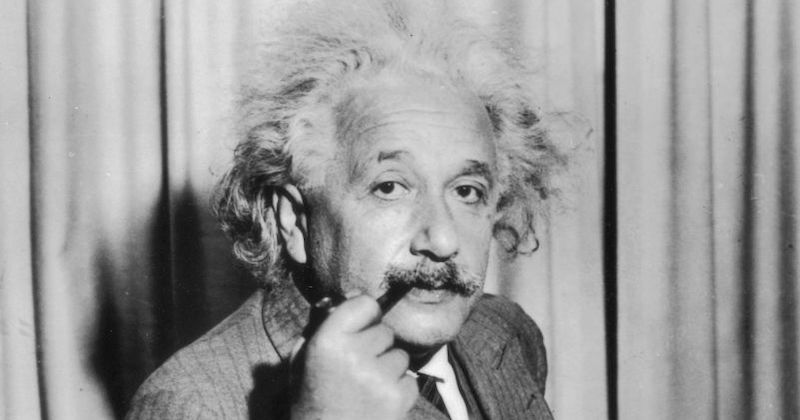Reed e Jony, nemiciamici
Siamo tutti molto felici di Netflix. Molti lettori del Post sono sicuramente abbonati al servizio di streaming più efficiente che ci sia. L’applicazione di Netflix, poi, è una perla di familiarità, facilità, intuitività assoluta e qualità della rappresentazione del catalogo. Lo sappiamo. È un’applicazione che ci conosce bene, che ci accompagna, ci anticipa: un algoritmo con la faccia del CEO Reed Hastings, un tipo sorridente che vorremmo tenere accanto a noi sul divano. Basta andare su Amazon Prime per Guardare Fleabag o le storie fantastiche di Neil Gaiman (American Gods o The Good Omnes) per avere la sensazione di essere finiti nella DDR. Anche sui social la comunicazione di Netflix è affilata come una lama, ironica, ficcante, laterale, che fa sponda con le notizie e le tendenze del momento un po’ come la satira al biliardo del Lercio.
C’è però un contesto nel quale l’esperienza di spettatore di Netflix diventa un calvario insopportabile. E non è solo colpa di Netflix ma anche di Apple. È una specie di associazione a estinguere la pazienza dell’utente; nello specifico stiamo parlando della mia. Ho anche il sospetto che sia un problema esclusivamente personale, ma sono mesi che ne parlo con gli amici e siamo arrivati alla conclusione che qualcuno deve dirlo.
Io guardo Netflix su Apple TV. Comando quindi Netflix con il telecomando sottile e sensibile progettato da Jony Ive. Jony Ive è l’uomo che ha costruito il nuovo corso di Apple, nonché uno dei giganti del progetto industriale odierno. È lui che ci ha abituati alle superfici di alluminio satinato, lui che ha tolto gli orpelli, lui che, ispirandosi al prodotti Braun concepiti da Dieter Rams, ha alzato il livello della nostra elettronica di consumo, allontanandola a forza dal mondo dei plasticoni. In questo suo sforzo di semplificazione delle linee, Jony si è buttato su una strada che permette poche deviazioni: via quello che non serve, via quello che rende caotiche le forme. C’è però un rischio, cioè che a furia di semplificare si abbandoni del tutto il rapporto tra forma e funzione, finendo in una spirale che privilegia la forma rispetto all’uso, come se la stessa ergonomia rischiasse di finire tra gli orpelli. Alcuni dei prodotti Apple degli ultimi anni sembrano avere il monolite di 2001: Odissea nello spazio come riferimento filosofico, e una piastrella di ghisa liscia come modello fisico. Questa sottile linea tra il bello e il funzionale è quella che Jony Ive tende a scavalcare con più slancio, tanto da aver prodotto il telecomando della Apple TV, che è un piccolo monolite sottile pensato male, un piastrellite.
Il telecomando di Jony ha dei tasti, ma per fare sì che siano tutti belli simmetrici sono stati concepiti quasi identici, con un’area tattile e cliccabile sopra. Nella nuova versione dello stesso oggetto i tasti non sono più identici, perché an Cupertino si sono resi conto che se al tatto non percepisci la differenza devi sempre guardare il telecomando, che è nero e in genere si usa al buio, e la cosa porta l’utente a insultarti mentre lo fa. Perché i vecchi telecomandi cessi del televisore, con i loro tasti stupidi di gomma, questo problema non lo avevano. Inoltre questo telecomando tattile sempre pronto a recepire ogni nostra intenzione, leggero e sottile, tende a infilarsi ovunque nel divano, o semplicemente a scivolare accanto al corpo. Così, grazie al contatto con la pelle di un braccio o di un fianco, a volte i film vanno avanti, si fermano, mostrano per un istante letale la scena chiave della puntata che sarebbe dovuta arrivare venti minuti dopo. Anche questo problema era ignoto ai telecomandi cessi del televisore.
In questo contesto di fastidio già evidente, dicevo, ci si mette Reed Hastings, o meglio la sua applicazione di Netflix, la quale da un po’ di tempo prevede dei piccoli trailer con audio e video che partono in automatico quando si scorre tra i contenuti. Partono, e hanno quella impostazione che chiama con tutti i mezzi possibili la nostra attenzione: volume alto, montaggio serrato, VRAAAM, risate, urla strepiti schiamazzi. Se scorri tra i titoli mentre scegli i contenuti, non c’è modo di sfuggire a questi trailer strilloni che continuano a partire, uno diverso dall’altro, poi finiscono e ripartono. Il silenzio e le immagini statiche sono esclusi. Non se ne esce. Ciascun contenuto abbaia come un cane al canile gridando “Prendi me!”. E intanto non puoi parlare con chi è seduto con te sul divano, non puoi discutere di questo o quello, perché ci sono i trailer che vanno in eterno.
Da un po’ di tempo a questa parte quindi io e i miei amici facciamo così: vediamo quello che c’è. Poi ci sale il nervoso, e facciamo di tutto per evitare questa tortura dei trailer. Smacchinando abbiamo scoperto che c’è un solo modo per salvarsi: rifugiarsi in uno sgabuzzino chiuso dove nessuno ci disturba, nella pagina della ricerca. Può essere che uno a 45 anni si debba andare a rintanare con un telecomando frustrante dietro una lente di ingrandimento per non essere bombardato di spot in un posto dove ha già pagato? Bah. Io mi infurio, lancio insulti a Reed e Jony, ma forse sono l’unico. In caso, scusate. Torno nello sgabuzzino dietro la lente di ingrandimento e non disturbo più.