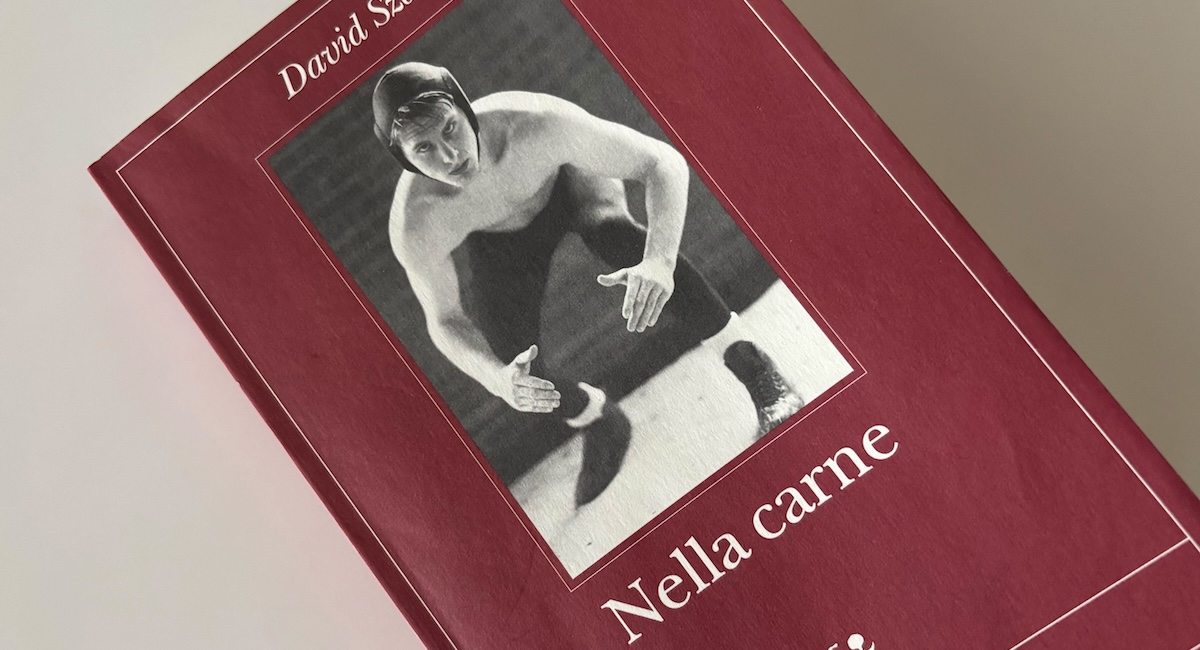Apparizioni nevose al Cimitero Monumentale
Tra il 26 e il 27 dicembre a Milano ha nevicato per tutta la notte. Il giorno dopo sono uscito di casa e i marciapiedi erano attraversati da tante linee serpeggianti di forme bislunghe: le impronte dei passanti, a volte uniformi, delicate, soavi, altre profonde, decise, spezzate dai tasselli della suola carrarmato, effetto di tante diverse calzature indossate, di corporature ineguali e magari di vite inconciliabili e modi opposti di credere, di sentire, di fare, perfino di scrivere. Anche la neve divide l’umanità in partiti: chi ne subisce il fascino e chi la considera un disagio. E poi: la neve ammonticchiata in creste color ruggine lungo i binari del tram e i globi in mezzo alla strada, grigi e tozzi, tranciati o sbatacchiati senza pietà dalle automobili. Con le carreggiate sporche di ghiaccio e le strade spopolate a causa del freddo e delle restrizioni alla circolazione dovute alla pandemia, Milano somiglia a una città dell’est Europa negli anni Settanta.
Ho fatto una lunga e piacevole passeggiata, ipnotizzato dal susseguirsi delle orme sulla neve grigia. Sono arrivato fino al Cimitero Monumentale e sono entrato. Superato il Famedio, è calato il silenzio. Il rumore del traffico oltre il piazzale era cessato. Nel cimitero sembrava essersi depositata molta più neve. Era intatta e accumulata ovunque, in forme piane e tondeggianti. Ho imboccato un vialetto interno, camminando in un’aria velata tra una doppia fila di tombe coperte di neve e sopravanzate da fronde verde scuro. Le fronde erano piegate qua e là da macigni nevosi con gli angoli smussati e un aspetto buono, invogliante, simili a un tòcco di panna quando da una vaschetta lo si raccoglie in un cucchiaio grande. Dal vialetto ho svoltato verso un’altra zona del cimitero. Era tutta neve fresca.
Sentivo la neve entrare nelle scarpe, sciogliersi e bagnare la stoffa del calzino; eppure non avevo freddo, semmai una leggera e gradevole paralisi alle dita dei piedi, e un desiderio di altra neve, evocato dallo scricchiolio sotto le scarpe e dalla visione degli spessori nevosi, morbidi e ondulati, posati tra una tomba e l’altra. A ogni passo il godimento di entrare nella neve fresca e il rimpianto per aver rotto la neve fresca. Ogni tanto, con uno schiocco e un tonfo, un pezzo di neve scivolava giù da un ramo e si spappolava sul manto di neve a terra. Nessun altro visitatore, una solitudine memorabile, immacolata, irripetibile, eccetto l’apparizione di un paio di persone, sbucate dal nulla della foschia in due momenti e in due luoghi diversi del cimitero. Si somigliavano: jeans schizzati di neve e ghiaccio, giacca a vento nera, incedevano nella neve fresca e ogni tanto, colpiti da un dettaglio, si fermavano per scattare una foto, sollevando con entrambe le mani una macchina fotografica legata a tracolla. Non solo si somigliavano, ma il nylon sfregato delle giacche a vento, in mezzo a quello spazio silenzioso, produceva un ronzio tenue e identico.
Che cosa stavano cercando i due fotografi, in particolare? Che cosa li aveva spinti fino al Monumentale? Senza dubbio, come me, erano qui in virtù di un’idea di generica spettacolarità, legata al soggetto convenzionalmente suggestivo del cimitero monumentale, con le sue diecimila statue e gli ornamenti, in addizione con l’effetto scenografico della neve che li sommerge, anche se certe parentesi temporali di grigiore chiarissimo, di luminescenza in particolare di un cristallo, di sospensione, di separazione, di isolamento, di vera e propria beatitudine, non erano facilmente registrabili.
Il Cimitero Monumentale dopo una nevicata è un luogo dove si possono scattare belle fotografie, lo sapevamo, ma nessuno dei tre, probabilmente, immaginava quel giorno d’imbattersi in un soggetto inaspettato, sul quale esercitare tutta la nostra fame di illusione: a causa di un fenomeno fisico e meccanico, la neve, fiocco dopo fiocco, si era cumulata sulla porzione sommitale di moltissime statue, cioè sul cranio di busti raffiguranti uomini defunti, donne defunte, vecchi o bambini morti ottanta o cento anni fa, prendendo la forma cilindrica di un cappellino senza falda, una specie di colbacco o di fez, magari inclinato sulle ventitré.

All’inizio, vedendo un primo busto di bronzo con un cappello di neve, ho pensato fosse un caso e poi, invece, continuando a vagare da un’area all’altra, ho scoperto che tutto il cimitero era punteggiato di altre decine di statue incappellate e di fatto travestite dalla natura. Ironia della neve: tuttalpiù ho sorriso, ma alla fine è un’immobilità stupita e l’incapacità di incasellare il fenomeno che hanno prevalso. Come nel disorientamento che si prova di fronte a un robot capace d’interazione e dotato di una mimica verosimigliante o davanti all’azione di un algoritmo che mostra di saper prevedere i nostri pensieri, anche in questa circostanza ero confuso, spiazzato, perché la natura sembrava comportarsi con un’ironia genuina e umana.
Sotto il cappello di neve bianca traslucida – e a volte, a seconda del punto di osservazione, quasi azzurra, celeste, acqua marina – l’espressione del volto ritratto cambiava, diventava comica o si trasformava nella smorfia della vittima impotente di uno scherzo. I busti vicini di un uomo e una donna, entrambi con il loro fez di ghiaccio, sembravano un marito e moglie bersaglio di uno scherzo che prendeva di mira la monogamia, tutto il loro essere stati assieme, la decisione di vivere nella stessa casa e di dormire nello stesso letto. In alcuni casi la neve si era depositata anche sulle spalle, creando un effetto «collo di pelliccia».
Non so come finire questo discorso che ho cominciato e perciò lascio la parola a un libro di Andrea Gentile, che si chiama Apparizioni, uno dei migliori letti lo scorso anno: «Che cos’è un’apparizione? Tutto appare: viene alla luce. Il nostro stare al mondo è un flusso continuo di eventi improvvisi e inaspettati. Tutto ciò che ci accade, giorno dopo giorno, minuto dopo minuto, è un evento improvviso e inatteso: la coda in automobile in una città di provincia in estate (un piccolo tamponamento imprevisto davanti a noi e via, dieci minuti inaspettati), la caldaia che smette di funzionare, la presenza di un qualunque cliente in un bar dove prendiamo il caffè […]»; E infine, sempre da Apparizioni: «Una pandemia è un grande irradiatore di apparizioni. Moltiplica le apparizioni».