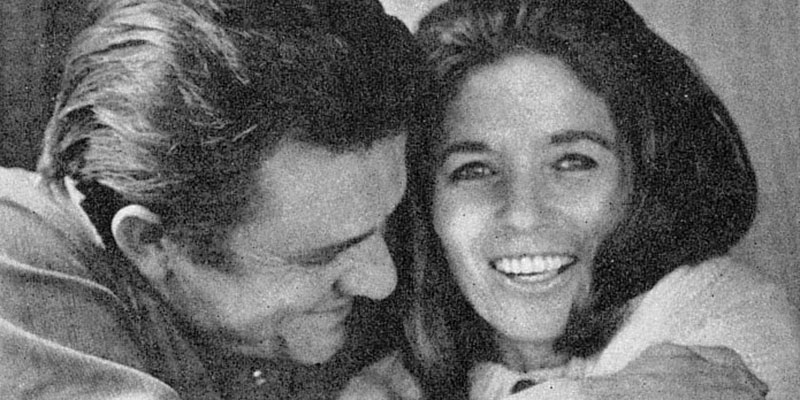Tempo fuor di sesto
A fine agosto, ho avuto l’onore di essere uno tra i circa cento studiosi provenienti da tutto il mondo e da diverse discipline (fisica, cosmologia, biologia, neuroscienza, filosofia, informatica, psicologia) invitati a un incontro sul tempo organizzato dal Foundational Questions Institute. L’idea era di provare a dibattere su questioni del tipo: perché il tempo, a differenza dello spazio, sembra avere una direzione intrinseca? Cosa produce l’impressione dello scorrere del tempo come un flusso inarrestabile, una corrente che non si può risalire? Qual è il legame tra il tempo soggettivo della mente e quello oggettivo delle scienze naturali e in particolare della fisica? Quale ruolo gioca nell’organizzazione dei sistemi complessi e in particolare nell’origine della vita? (altro…)