I titoli di Woody Allen
Lo sappiamo tutti. Sono sempre uguali. Rassicuranti. Un punto fermo. Una certezza ritrovata. Un patto mantenuto con noi spettatori. Quando si spengono le luci, si accende il nero e iniziano a scorrere accompagnati da note dixieland, lo capiamo subito che dietro c’è lui. Perché Woody Allen realizza i suoi titoli di testa (e di coda) tutte le volte alla stessa maniera.
Qualunque conferma delle nostre aspettative rientra nei piaceri della vita. Il primo sorso di una birra agognata, la nota finale dell’acuto di un’opera o un pallone che va a infilarsi lentamente nell’incrocio di due pali. E per noi quei titoli, mai cambiati, rappresentano ormai un rituale. Se non ci fossero non sarebbe un film di Woody Allen. “Quelle sequenze iniziali mi sono incredibilmente familiari – racconta Christopher Whalen, art director newyorchese – quando le vedi scorrere puoi già sapere quello che stai per assaporare. Per me sono più emozionanti di quelle di James Bond”. Certo, non danno la medesima adrenalina, però, pur nella loro asciuttezza, riescono a trasmetterci una sensazione forte. Come entrare d’inverno in una casa già calda.
Il merito di questa sensazione, sicuramente condivisa da milioni di ammiratori del regista, è da attribuire anche alla scelta del carattere adottato. I migliori esperti di comunicazione sono pronti a dimostrarci quanto sia decisivo per un’azienda, un marchio, un prodotto, una campagna elettorale o, come in questo caso, un film, la scelta dello stile giusto: il font.
La scelta del font
Il font è una parola inglese che proviene dal francese (medioevale: fonte, fuso), a sua volta derivante dal latino fundere (con riferimento ai caratteri mobili ottenuti versando il metallo fuso nella forma del singolo carattere). Sta a significare un insieme di caratteri tipografici (detto anche “famiglia”) caratterizzati e accomunati da un determinato stile grafico (il Times New Roman, ad esempio, è tra quelli che, forse per pigrizia, ci troviamo a utilizzare di più), ma ormai la parola viene riferita direttamente e impropriamente al singolo tipo di carattere, al suo design (chi volesse approfondire può seguire il relativo tag del Post, da sempre sensibile al tema).
I font non costituiscono solo una scelta calligrafica, rappresentano qualcosa di più complesso di un’apparenza estetica. Sono in realtà la punta di un iceberg. Dietro il loro tratto si nascondono ore di ragionamenti, dubbi e illusioni. Su quelle asticelle creativi di ogni genere ripongono le loro aspettative, affidano ad esse le sorti delle loro idee sperando che, grazie al font scelto, vengano assorbite dal mercato nel modo migliore. Il loro abuso può creare anche effetti deleteri (la vintage-dipendenza di questi anni, ad esempio, ha innescato la bolla del Lobster – che impazza nei menù delle caffetterie hipster – e di tutte le altre famiglie dei font retrò).
Il font che ha adottato Allen, rendendo inconfondibili i titoli dei suoi film, è il Windsor.
L’eccentrico calore di Windsor
Windsor è un vecchio carattere di tipo serif (gli stili tipografici che possiedono alle estremità quegli allungamenti, detti grazie), creato da Eleisha Pechey (1831-1902), rilasciato dalla fonderia tipografica Stephenson Blake, destinato prevalentemente a titoli e insegne. Le lettere minuscole a, h, m e n, si arrotondano in diagonale come dolci colline creando un movimento irregolare che rende ciascuna parola elegantemente imperfetta. È il carattere psicologicamente avverso al campione dei pesi massimi Helvetica, un sans serif, il font che con la sua precisione svizzera aveva veicolato, in pieno boom economico, l’affidabilità di migliaia di multinazionali divenendo poi il font ufficiale dell’intera segnaletica di New York. Windsor invece, che aveva vissuto la gloria del mezzo secolo precedente, è stato amato da un certo tipo di piccole imprese, per il suo essere “caratteristico”. Non troppo comune, ma abbastanza comune da poterlo trovare e riconoscere in giro regolarmente. I più distratti oggi lo associano al Cooper (Black o Old Style), che imperversava negli anni Settanta, ma il Windsor è un carattere tipografico più versatile e meno stereotipato, inconsueto e un po’ eccentrico. Ma in modo molto sottile.
La designer Brooke Semple descrive il senso di “cordialità e calore” che questo font riesce a emanare. “Ogni volta che guardo un film di Woody Allen che non ho mai visto prima – racconta la designer coreana Soojin Lee – i credits d’apertura sono come un riflesso condizionato per me. Vedo il bianco Windsor e mi sento avvolta da un sorriso caldo, perché so che i prossimi cento minuti della mia vita saranno rapiti da un dialogo tra i miei due personaggi preferiti di Allen: spirito e cuore”. Il columnist del MinnPost, Andy Sturdevant, riconosce che molti tipi di caratteri possono essere considerati amichevoli e caldi, ma che “nel caso di Windsor, tale cordialità e calore sono temperati da una certa eccentricità attraente. Windsor è come la tua zia preferita, quella che aveva vissuto in una comunità, che indossa occhiali da vista vintage e vive in un appartamento in affitto pieno di antologie di poeti stranieri”.
Originale, verboso, eccentrico, amichevole. Peculiarità che, incredibilmente, accomunano font e regista (perdonatemi, devo proprio scriverlo: entrambi, quindi, dotati del medesimo “carattere”).
Se, naturalmente, ho sempre concordato sul fatto che quel carattere (disposto magnificamente sulle insegne di Londra o di New York un secolo fa) oggi annunci, dunque, l’arrivo di “un” Woody Allen (come la celebre montagna bianca – si dice del Monviso – introduca un film Paramount), al tempo stesso la mia curiosità in passato mi aveva spinto a voler sapere altro, imponendomi, ad esempio, domande sulla sua origine.

Il quando e il perché
D’accordo, forse è il tipico esercizio di schizofrenia cinefila su inezie collaterali (tra l’altro altri registi hanno le loro fissazioni sui typeface: Wes Anderson predilige il Futura Bold and Black, Stanley Kubrick adorava tutti i sans serif, il Futura Extra Bold su tutti, ma naturalmente il suo rigore lo conduceva anche verso Helvetica e Univers, puliti, lineari ed eleganti; il Futura, tra l’altro, nel 1969 venne utilizzato per scrivere la frase sulla targa che è rimasta nella Luna) però, come molti altri, appurato facilmente il quando (Woody Allen cominciò a usarlo a partire da “Io e Annie”, 1977, esattamente quarant’anni anni fa), mi sono chiesto intanto il perché – di questa sua fedeltà (soprattutto in tempi nei quali già ai titoli di testa si affida il compito stupire il pubblico). E ho provato a darmi delle possibili risposte.
- È una scelta intellettuale. Autoriale, quasi politica, di chi bada al sodo, all’essenza del film: la sceneggiatura e i dialoghi, ad esempio, perché il resto è solo contorno.
- È una scelta pratica. Si risparmia tempo. Adottarne un’altra implica sforzi, insicurezze e ricerche. E Allen fa un film all’anno. Ogni minuto è prezioso.
- È una scelta psicologica. Allen è abitudinario, vive di punti fermi: Macy’s per le sue giacche di velluto a coste, Elaine’s per le cene, i Knicks per il basket (al Madison Square Garden). Detesta i cambiamenti. La titolazione di lavoro dei suoi progetti, non è mai stata modificata: WAWP (Woody Allen Winter Project) per l’inverno o WASP (Woody Allen Summer Project) per l’estate. Le sue sessioni di clarinetto prima al Michael’s Pub, poi al Cafè Carlyle cadono da decenni ogni lunedì.
- È una scelta scaramantica. La adottò la prima volta al suo settimo film: “Io e Annie”. Vinse 4 Oscar. Nel film successivo, “Interiors”, cambiò font, fu un flop. Dal seguente non lo ha più abbandonato.
- È una scelta estetica. Il font gli piace. E come molti altri creativi non vuole cambiare per una opzione che lo convinca meno.
- È una scelta produttiva. I suoi film non hanno budget stratosferici. Adottare dei titoli essenziali significa avere più soldi per il resto (per le location, ad esempio, o per una star).
Quest’ultima tesi trova fondamento in una dichiarazione che lo stesso Allen rilasciò all’Obs (come si chiama dal 2014 il Nouvel Observateur): “Ho le mie piccole abitudini. Quando ho iniziato, c’era la moda dei titoli pazzeschi, come in Pink Panther, che assorbivano la metà del budget dei film. Così ho cercato di fare lo stesso, ma in maniera più economica”. Per “Tutto quello che avreste voluto sempre sapere sul sesso”, Norman Gorbaty, il title designer, gli chiese di “sparare” in una stanza bianca dei conigli, anch’essi bianchi, che dovevano rappresentare simboli sessuali. “Ne prendemmo duecento – raccontò Allen – ma all’arrivo, i conigli erano tutti affollati in una pila compatta. Ce ne servivano altri. Ne facemmo arrivare altri duecento. Stesso risultato. Ne ordinammo cinquemila a Parigi. E ancora non bastavano! A questo punto dal film successivo ho deciso di mantenerli semplici. E non ho più cambiato”. Dopo il film del 1972, infatti, uscirono “Il dormiglione” e “Amore e guerra”, già in una forma essenziale, sebbene non ancora definitiva.
Avevo solo appurato il “quando” e semplicemente supposto il “perché”. Mi restava da capire ancora molto. Il “come” e il “dove” erano chimere.
Il dibattito tecnico
Mi venne in soccorso Cristian KIT Paul, un designer romeno, fondatore di Brandient, che nel 2007 sul suo blog scrisse un post dedicato all’argomento e che ancora oggi, dopo dieci anni, vive e si aggiorna grazie ai continui commenti dei suoi lettori. Da addetto ai lavori, Kit disquisì prevalentemente di tematiche tecniche, “only for fans” (o “nerds” o “geeks”, fate voi), soffermandosi sulla specifica tensione del font (se allungata, accorpata, compressa, etc.) e soprattutto sulla sua declinazione, arrivando a reputarlo infine un Windsor di tipo Elongated. Tutto questo fino a quando due utenti di fila (Maza e Tom Ross) gli fecero notare che si trattava di un Windsor Light Condensed e non Elongated. Il designer in quella occasione si rivelò sportivo (“C’è un vecchio detto rumeno che – tradotto in modo scorretto – recita pressappoco così: quando una persona ti dice che sei ubriaco, ignoralo. Quando due persone ti avvertono che sei ubriaco, devi andare a letto”). E corresse il tiro, senza però negare del tutto la sua tesi. Riassumendo e semplificando: “È così, ma è anche così” (dilatando, per chi proprio ne vuole di più: “Devo ammettere che voi possiate avere ragione. Sembra più Light Condensed, tuttavia, alcuni dei titoli sono impostati in un peso visibilmente più spesso: basta guardare “Stardust Memories”, “La rosa purpurea del Cairo” o “Hannah e le sue sorelle”, dubito che in questi casi possa essere un Light Condensed”). In questo dibattito su quisquilie tipografiche, incredibilmente vivace e terribilmente tecnico, cercò di sigillare il triello l’utente Mark Simonson: “È sicuramente Windsor Light Condensed, non allungato. Le variazioni di peso nei titoli sono probabilmente dovute alle differenze di esposizione o all’uso di diverse versioni di Windsor Light Condensed”. Il “peso” è il rapporto tra area inchiostrata e area in bianco della serie di caratteri. Semplificando: lo spessore delle sue linee, indipendentemente dalla sua dimensione.
Appurato il tipo di font utilizzato, mi restava ancora da capire, al di là dei tecnicismi, come mai Allen scelse proprio questo font.
La svolta
L’indagine ebbe una svolta inaspettata grazie a una stupefacente storia nascosta nelle pieghe dei commenti: “Attualmente sto facendo un corso di design tipografico con Ed Benguiat, e proprio ieri sera ha raccontato di quando faceva colazione ogni mattina nello stesso dinner, nel New Jersey. Tra gli altri commensali c’era Woody Allen”.
Lo scoop era di Randy J. Hunt, direttore creativo di Etsy. Stupore e meraviglia colsero tutti i lettori del blog, padrone di casa compreso. La sorpresa, naturalmente, avvolse anche il sottoscritto.
Pausa.
Dobbiamo immaginare la scena. Perché tutto il futuro si gioca lì, sul bancone di quella tavola calda. È lì che il mio forse sterile interrogativo troverà la sua risposta. Due leggende, della grafica e del cinema, entrambe di Brooklyn, visceralmente attaccate a New York, la prima da quasi mezzo secolo, la seconda da poco meno, si incontrano insolitamente in un dinner lontano da Manhattan, dall’altra parte dell’Hudson River. Ne hanno fatta di strada prima di arrivare lì.
Il caffè di Benguiat
Benguiat era già un monumento della lettering art. Suo padre era stato direttore di un grande magazzino newyorkese e aveva tutti gli strumenti di disegno che un bambino potesse desiderare. I giochi di Ed erano penne, pennelli e pennarelli. Iscrittosi alla Workshop School of Advertising Art, Benguiat si era accorto presto di avere poco talento per il disegno. Ma di averne molto per il layout. Uscito nel mondo aveva intrapreso una carriera impressionante come designer e art director per case editrici, studi e agenzie pubblicitarie, facendo uscire dalla sua testa oltre seicento typeface designs compresi Tiffany, Bookman, Panache, Souvenir, Edwardian Script e naturalmente il Benguiat. Suoi sono i loghi realizzati per Esquire, The New York Times, Playboy, Reader’s Digest, Look, Sports Illustrated, Coke, Estée Lauder e Ford. Quando parla con Allen insegna da cinque anni alla School of Visual Arts di New York, ha già creato i caratteri per “Il pianeta delle scimmie”, “I cannoni di Navarone” e per i film della blaxploitation degli anni Settanta (per i quali verrà chiamato da Tarantino, vedi il main title “Jacky Brown”, un ITC Tiffany, che Benguiat aveva già usato nel 1974 per “Foxy Brown” o il Benguiat per i titles di “Pulp Fiction”) ed è già una leggenda. Benguiat ragiona come un musicista. Vede il ritmo degli spazi, cadenza pieni e vuoti, regola alti e bassi. È realmente un percussionista jazz. Da giovane, quando suonava il be-bop nei locali della 52sima era uno dei migliori della città. E avrebbe continuato a suonare se un giorno non fosse entrato alla Musician’s Union per pagare i bollettini annuali. Osservando la coda si accorse che quelli più grandi di lui sbarcavano il lunario suonando a bar mitzvah e matrimoni greci. Immaginò il suo futuro e decise di cambiarlo. Diventando un illustratore. Allen era sulla grande scena da circa dieci anni. Fino a quel momento era stato diretto in tre film – “Ciao Pussycat” (1965), “Casino Royale” (1967) e “Provaci ancora, Sam” (1972) – e lui stesso ne aveva girati il doppio: “Che fai, rubi?” (1966), “Prendi i soldi e scappa” (1969), “Il dittatore dello stato libero di Bananas” (1971), “Tutto quello che avreste voluto sapere sul sesso” (1972), “Il dormiglione” (1973) e “Amore e guerra” (1975). Come Benguiat conosceva già bene il ritmo, delle battute o l’armonia di una scena. Era sempre una questione di musica, amava anche lui il jazz e si dilettava con il clarinetto.
Newyorchesi, jazzisti e creativi. Due anime elette che si trovano frequentemente a bere un caffè insieme. Benguiat più sovrastante, è un audace pilota di aerei, Allen più impacciato, da tre lustri è psicanalisi dipendente. Una mattina il regista infila il coraggio nelle corde vocali: “Sto cercando il carattere giusto per il mio film. Quale è il migliore secondo te?”. Benguiat, che paragona il disegno grafico all’equilibrio di una composizione musicale, posa la tazza di caffè e non fa passare un secondo: “Windsor”.
Quando penso a quel momento immagino che il nome lo abbia pronunciato sul rumore impercettibile provocato dall’impatto della tazza quando incontra il piatto (o il tavolo). Quel rumore vetroso (o più sordo, a seconda del supporto) che è simile al suono del piatto della batteria. “Tztztz”. Windsor. Lo stesso suono che è contenuto nella parte centrale del nome. Le associazioni inconsce delle idee a volte fanno combaciare le realtà (Allen – via Freud – riuscirebbe a farmi una lezione su questo) e nella loro perfezione possono rivelarsi illuminanti.
Se vogliamo trovare, invece, una logica più concreta, i caratteri “graziati” sono generalmente considerati più facili da leggere. Pertanto Benguiat, dopo un’altra sorsata di caffè, avrà supportato la sua scelta con una motivazione più che fondata: “È un font perfetto per titoli che scorrono veloci”.
Non sappiamo se fu per il minimale eco jazz suscitato da quel momento o per l’agevole lettura che poteva scaturire dal suo utilizzo, fatto sta che ad Allen piacque l’idea. Windsor divenne una firma dei suoi film, insieme ai vecchi brani di Cole Porter, ai suoi occhiali neri, ai dialoghi serrati e alle sue nevrosi esistenziali.
Il colpo di scena
Era questa la verità? Lo speravo fortemente. Sarebbe stato magnifico se quella chiacchierata avesse determinato la scelta definitiva di Allen. L’incontro raccontato da Hunt doveva avere avuto luogo intorno al 1976. Ma era leggenda? O si trattava di un episodio realmente accaduto?
Non lo avrei mai saputo se un giorno Benguiat in persona non avesse deciso di scendere in terra per lasciare un segno tra i comuni mortali. Chi non si aspetta l’inaspettato non arriverà mai alla verità. E la rete stavolta aveva inventato uno di quei miracoli che riescono ancora a rendere giustizia al monito eracliteo.
Tutto era iniziato con un post scritto da un designer della Transilvania settentrionale, era proseguito con una discussione tecnica, durata anni, tra decine di utenti di tutto il mondo, fino a quando uno di loro, forse il più autorevole, aveva svelato una confidenza del peso massimo in materia. Una rivelazione che poteva aprire uno squarcio sul mistero del font alleniano.
Imbattutosi nel post di Kit (ormai vecchio di quattro anni), il signor Benguiat (anche lui non male in quanto a vecchiaia: novant’anni compiuti da poco), lettosi i quarantanove commenti come fossero novelle hemingwayane, alle 5.45 pm di un 24 aprile compila il form per aggiungere il suo. Il commento numero 50:
Tutto molto ben formulato e tecnicamente corretto.
Grazie a tutti per le puntuali informazioni sul signor Allen.
Un’altra persona che ha bisogno di alcuni ringraziamenti per la sua opinione sull’utilizzo di Windsor era Corbett Monica, che si trovava al dinner ogni sabato e domenica.
Ha recitato nel film “Broadway Danny Rose”.
Ed Benguiat
Happy End
A partire da quella chiacchierata, dunque, ora possiamo dirlo, Allen usò questo font, facendolo sedimentare per quarant’anni (in quarantuno dei suoi film) sulle retine di noi spettatori e rendendolo così un brand inesorabilmente iconico.
“Qualunque amore riusciate a dare e ad avere – fa dire al suo alter ego Boris Yellnikoff – qualunque felicità riusciate a rubacchiare o a procurare, qualunque temporanea elargizione di grazia, basta che funzioni”. Possiamo quindi evitare di chiederci se quel Windsor sia veramente allungato o condensato. Quello che è certo è che per Allen ha funzionato. In esso si riflette la sua cultura, il suo jazz, la sua città e il suo calore. Non poteva che adorare Windsor, tanto quanto “adorava New York”.
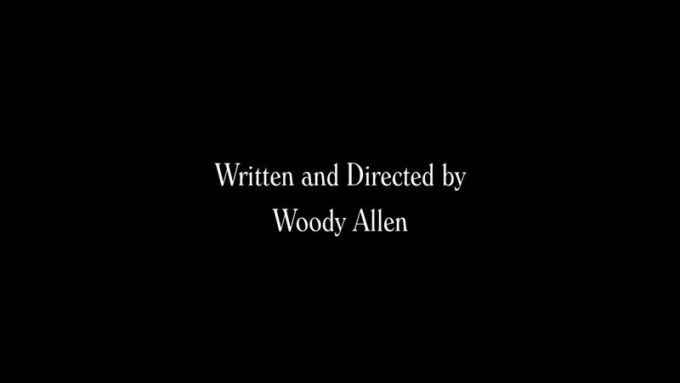
Postilla n.1: Corbett Monica, il terzo commensale, era stato un commediante di successo, membro giovane del Rat Pack e star dell’Ed Sullivan Show. Forse memore di quegli incontri, a lui, anch’egli batterista, nel 1984 Allen affidò la parte di se stesso nel film B.D.R. dedicato agli artisti senza successo.
Postilla n.2: che Allen abbia costantemente vissuto di punti fermi lo si capiva già quando, sdraiato sul divano, ne decantò una dozzina (Groucho Marx, Joe Di Maggio,il secondo movimento della Sinfonia Jupiter, Louis Armstrong, i film svedesi. “L’educazione sentimentale”, Marlon Brando, Frank Sinatra, la frutta di Cézanne, i granchi da Sam Wu…) nel memorabile finale di “Manhattan”. Per un singolare paradosso è l’unico film senza i titoli.
Postilla n. 3: a proposito di titoli e di anniversari, “Io e Annie” (“Annie Hall”) doveva chiamarsi “Anhedonia”, termine psichiatrico un po’ arcaico riferito all’incapacità di provare gioia. La United Artists, che aveva distribuito i quattro film precedenti di Allen, capì subito che per il marketing sarebbe stato un’impresa promuovere un film con questo nome. Così, nel tentativo di rendere più appetibile il titolo fortemente desiderato da Allen, diede l’incarico a un’agenzia pubblicitaria per riempire i giornali locali di tutto il paese con titoli in prima pagina, “Anhedonia Strikes __________!” (riempiendo lo spazio vuoto con il nome della città dove sarebbe apparso l’annuncio). Frattanto il co-sceneggiatore Marshall Brickman tentava di suggerire delle alternative (“A Rollercoaster Named Desire”, “It Had to Be Jew” e “Me and My Goy”) che Allen bocciò (lo stesso regista propose un paio di opzioni relativamente alle quali, però, lui per primo, era poco convinto: “Anxiety” e “Alvy and Me”). Finché il film finì per ereditare il nome della sua eroina (Diane Hall in arte Keaton). La scelta fece risparmiare alla United Artists il budget destinato alla campagna pro Anhedonia. Quel titolo sarebbe costato un milione di dollari.





