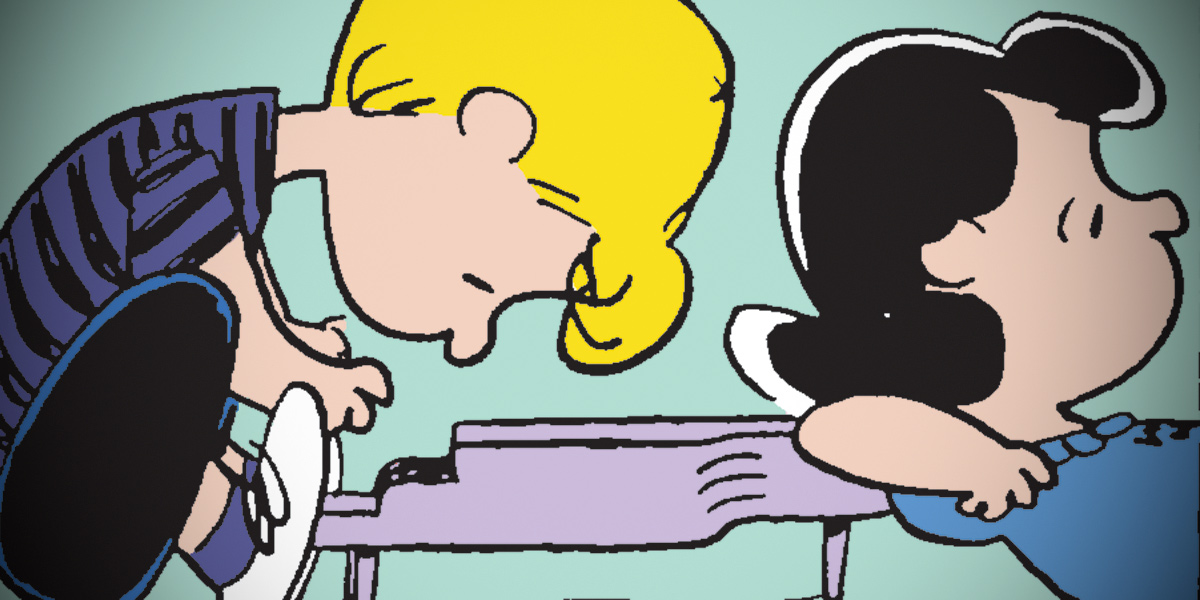Non ci sono più i soprannomi di una volta
Premessa: sto con Ben Harper, quando canta “there’s no place like here, there’s no time like now”, perché l’esaltazione dei bei tempi passati non ha mai fatto per me. Poi però, un po’ alla Joan Baez al netto dei “fiori”, mi domando: “Where have all the (nicknames) gone?”
Nell’universo NBA bloccato dal lockout dell’ultimo mese, due notizie – entrambe a loro modo tristi, una da titolo di pagina, l’altra da nota a margine – mi hanno colpito. Si è ritirato Shaquille O’Neal. Ed è morto Armen Gilliam (chi? Abbiate pazienza ancora un attimo). Del primo si sa quasi tutto: 4 titoli NBA vinti e migliaia di punti segnati gli hanno garantito l’immortalità cestistica (di lui si parla come uno dei più grandi centri di sempre). Del secondo non si ricorda quasi nulla, nonostante 13 stagioni da professionista. Una cosa, però, li unisce: O’Neal era “The Big Diesel” o “Superman” o “Shaq Daddy” o “The Big Aristotele” o “The Big Cactus” piuttosto che “Shaqtus” (a Phoenix) o altri mille nomi ancora. Gilliam era “The Hammer”, Il Martello. Uno un fuoriclasse, l’altro un operaio dei parquet buono per tirare qualche randellata nei pressi del canestro. Entrambi, però, con un soprannome (o più d’uno nel caso di Shaq) a fotografarli.
È stato allora che ho pensato: con il ritiro di Shaq (o con la morte di Gilliam), forse è giusto il momento di dire addio a un’intera epoca – stavolta sì d’oro. L’epoca dei soprannomi NBA.
Pensateci.
E pensate a un bel soprannome nella NBA di oggi (se ci riuscite).
Neppure le stelle più luminose sembrano meritarne uno. Kobe Bryant aka “The Black Mamba”? Per favore. Si è assegnato il nickname da solo – buono al massimo per costruirci un paio di campagne pubblicitarie e far contenti gli uomini del marketing – senza che ci fosse e ci sia nessun tipo di identificazione nei tifosi o riscontro nel linguaggio comune. Dirk Nowitzki, neo campione e MVP delle Finali? Niente, per dirlo nella sua lingua. Dwyane Wade? Veniva chiamato “Flash” (il soprannome gliel’aveva dato – indovinate chi? – Shaquille O’Neal) ma ha fatto sapere di non gradire. LeBron James? Ne ha due, “King James” e “The Chosen One”, con l’unico risultato che nessuno dei due si è imposto realmente e l’identificazione non è mai scattata. Anzi, a peggiorare le cose, se n’è aggiunto pure un terzo, “LBJ”, dalle sue iniziali. E qui l’innocua palla di neve diventa slavina, valanga. Kevin Garnett? Era “The Big Ticket” (Il Bigliettone, quello che valeva la pena pagare pur di vederlo giocare) o “The Revolution” (per come ha rivoluzionato il gioco), è diventato KG. Kevin Durant? Ci hanno provato con “Durantula” (orrendo!), è rimasto solo KD. Tim Duncan? TD. Tony Parker? TP. Poteva valere per Michael Jordan, il più grande di sempre – MJ divenne un marchio, un brand, un mondo – ma non certo per decine e decine di atleti dopo di lui. Tutta qui la fantasia? Iniziale del nome + iniziale del cognome? Suvvia, si può far meglio. No, non basta aggiungerci il numero di maglia (“CP3”, Chris Paul) o provare strane formule aritmetiche (Paul Pierce come “P-Squared”, P², ovvero P al quadrato). Per meglio, casomai, si intende far diventare Paul Pierce “The Truth”, La Verità. La fonte? Ancora una volta lui, Shaquille O’Neal, al tempo ancora ai Lakers. Dopo aver affrontato gli odiati rivali di Boston guidati da Pierce, disse: “Segnatevi le mie parole: Paul Pierce is the motherfucking truth” (il soprannome è rimasto, al netto di quella parolaccia solitamente abbreviata in MF e tanti asterischi).
Oggi “The Truth” è un’eccezione, come lo è “The Matrix” per Shawn Marion, molla umana capace di saltare e risaltare. Perché un soprannome deve identificare, raccontare, svelare.
Oggi non succede più, mentre nella NBA del passato non c’era giocatore vero senza il suo “nickname” capace di racchiudere un mondo (e vi sfido fin d’ora ad aggiungere tra i commenti il vostro preferito). Earl Monroe era chiamato La Perla (Earl The Pearl, splendida assonanza) o addirittura Gesù Nero (“Black Jesus”, basta per immaginare i miracoli di cui era capace su un campo da basket?). Wilt Chamberlain, dall’alto dei suoi 215 centimetri, era Wilt “The Stilt”, La Guglia. “The Big O” era (ed è) per tutti Oscar Robertson, come “Larry Legend” valeva e vale per identificare Larry Bird. Per non dire del suo amico/rivale di una vita, di cui nessuno neppure ricorda più il nome di battesimo (Earvin) perché Magic era l’unica parola degna di essere pronunciata prima di Johnson.
Da bambino ho conosciuto prima “Dr. J” di Julius Erving, eroe del basket di Philadelphia come poi sarebbero diventati anche Charles Barkley e Allen Iverson (“The Answer”, la risposta a ogni problema). Barkley veniva soprannominato “Sir Charles” per una personalità sempre sopra le righe, tutt’altro che nobile e aristocratica, oppure – e qui si rasenta la poesia – “The Round Mount of Rebound”, La Montagna Rotonda Del Rimbalzo, per la sua capacità, pur sovrappeso, di catturare palloni sotto le plance. Ancora: David Robinson era “The Admiral”, L’Ammiraglio, per i suoi trascorsi al college di Navy, mentre il suo rivale nigeriano, centro degli Houston Rockets due volte campioni NBA, era Hakeem “The Dream” Olajuwon, e vederlo giocare era davvero un sogno. Darryl Dawkins (poi ammirato anche in Italia) era “Chocolate Thunder”, soprannome che oggi verrebbe bocciato da una commissione politically correct. La stessa che, forse, ha permesso che Jason Williams – baller dall’anima nera imprigionata dentro a un corpo bianco – venga ricordato più con lo scialbo “J-Will” che con il nick di “White Chocolate”. Al contrario, a uno come Grant Hill, afroamericano super borghese con tanto di mamma compagna di scuola di Hillary Clinton, nei ghetti delle città USA è stato affibbiato il bellissimo “Oreo”, nero fuori (il biscotto), bianco dentro (la cremina). Ma l’elenco potrebbe continuare all’infinito: Vinnie Johnson era “The Microwave”, Il Forno A Microonde, per i Detroit Pistons di fine anni ’80, perché usciva dalla panchina “ed era subito caldo” mentre Clyde “The Glide” Drexler “veleggiava” a canestro cercando di fermare Michael Jordan nei primi anni ’90, impresa poi inutilmente tentata anche nello Utah da “The Mailman”, Karl Malone, Il Postino (perché recapitava palloni a canestro come missive nella buca delle lettere). A volte i soprannomi erano pure collettivi, e allora l’Olajuwon di cui sopra, in coppia con un altro “sette piedi” come Ralph Sampson, costituiva le “Twin Towers” di Houston (ovviamente in epoca pre-9/11), mentre a Washington negli anni ’80 chi voleva far canestro doveva vedersela con due “muscolari” come Jeff Ruland e Rick Mahorn che – sulle orme di John Belushi e Dan Akroyd – si erano guadagnati il soprannome di “The Bruise Brothers”.