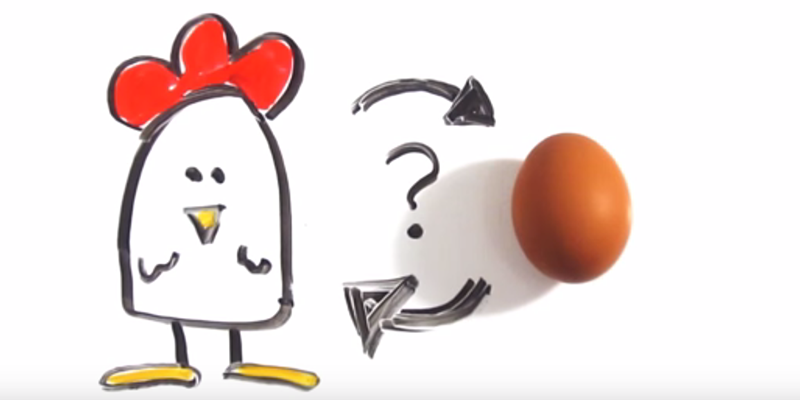Cannes, a rapporto!
Tutti i vincitori, raccontati e valutati dal critico cinematografico Bruno Fornara
“La vie d’Adèle”, di Abdellatif Kechiche
Palma d’oro
In classe si legge “La vie de Marianne” di Marivaux. In una frase si dice di un personaggio che se ne va con un cuore cui manca qualcosa e lui non sa cosa sia che manca. Il film di Kekiche cerca, per quattro ore, cosa manchi al cuore delle due protagoniste, Adèle e Emma, maestra d’asilo la prima, pittrice la seconda. Che si innamorano, si amano, si prendono, si regalano i loro corpi con passione e verità, si spingono in là nel piacere fin dove il cinema non è mai arrivato, provano desiderio nella carne con fierezza potenza e pienezza. Emma quando incontra Adèle ha i capelli blu, è di un’altro pianeta, Adèle si perde in lei e Emma la ricambia in ebbrezza. Kechiche riesce, in una lunga scena di amore fisico, a mostrare quanto la passione possa essere bella ed esaltante. Senza nessuna ombra. È nel perdersi nell’altra, nel corpo dell’altra, che il desiderio si avvera. Adèle e Emma scoprono questa felicità. Poi, dopo l’estasi, tornano sulla terra. È stato Oscar Wilde a dire che la questione irrisolvibile del rapporto sessuale è l’eterna impenetrabilità delle anime. Anche il film di Kechiche deve prenderne atto. Adéle e Emma arrivano a conoscere il dispiacere che sta là dove il corpo non c’è più, dove si entra nelle profondità della psiche e, a una festa, si può incontrare qualcuno che si pensa possa prestarsi a una esplorazione anche dell’interiorità, che si chiami anima psiche mente o sé. Alla fine Emma non ha più i capelli blu, li ha semplicemente biondi, il volto mostra qualche segno del passare del tempo. Adèle resta sempre uguale nella sua innocenza, così come l’ha fissata Emma nei suoi quadri. Emma ha un’altra amica. Adéle si allontana. Film attraente e attratto dal desiderio, dai corpi, dal godimento. Film dentro il tempo che risucchia l’amore. Dentro un guardare insistente, come a voler trattenere i momenti che se ne vanno. Voto 3½ su 5.
“Nebraska”, di Alexander Payne
Miglior attore
Un viaggio da Billings, Montana, a Lincoln, Nebraska, passando per Hawthorne, e ritorno. Cioè a dire un attraversamento di una pianura e un’altra e un’altra fino a ogni orizzonte. Un paesaggio sempre uguale, con paesi allungati su un’unica main street e l’ultima per cui passiamo si chiama, biblicamente, Locust Street. Un film in un bianco e nero dove il nero si sfarina in un quasi uniforme grigio pallido e latteo. Storie di vecchi. Il vecchio Bruce Dern pensa di aver vinto un milione di dollari e vuole andare a Lincoln a ritirare i soldi. Sua moglie: magnifico personaggio con una linguaccia che taglia il ferro. E tutti i parenti e amici o nemici: perché appena gira la voce che Woody ha vinto tutti quei soldi gli amici aumentano e anche i nemici. Woody è fissato, ha sempre bevuto troppo, capisce non capisce finge di non capire. È il figlio a portarlo in macchina a Lincoln. E tra padre e figlio, anzi figli perché ce n’è anche un altro, comincia un altro viaggio, verso una conoscenza e una riconoscenza che prima non c’erano. Dialoghi perfetti. Tante risate. La convinzione che non tutto sia ormai finito, che qualcosa resti pur sempre da fare. Premio per il viaggio: un pickup e un compressore. Film tenero, malinconico, umoristico, autunnale, amorevole. Nota: i due fratelli ciccioni sono gli stessi che facevano i fratelli gemelli che aggiustavano il tagliaerba nel troppo bel film di Lynch “Una storia vera”*****. Voto 4 su 5.
“Le passé”, di Asghar Farhadi
Miglior attrice
Asghar Farhadi insiste. Dopo “About Elly”***½ e “Una separazione”****, compone un altro film che è un esercizio di acrobazia narrativa e di implosione del racconto. Come nei precedenti film, anche questo si apre su una situazione più o meno normale e di relativa irrilevanza, poi di gradino in gradino, di salto in salto, di scivolata in scivolata, di sorpresa in sorpresa, si finisce per trovarsi in un labirinto di fatti e misfatti, piccoli e grandi, da cui non si sa come uscire. Certo, hanno un po’ ragione quelli che dicono che Farhadi deve starci attento ad applicare sempre questa ricetta dell’accumulazione narrativa senza un solo attimo di tregua. Finora, cioè fino a questo film, noi lo seguiamo. Ma mettiamo le mani avanti: dovesse applicare di nuovo nei prossimi lavori la stessa formula, avremmo qualche rilievo da fargli. Qui la situazione di partenza, all’apparenza piuttosto normale, è quella di un uomo che arriva a Parigi dall’Iran per divorziare dalla moglie iraniana che da qualche anno vive in Francia. Arriva sotto l’acqua e sale in macchina con la ormai ex moglie che è venuta a prenderlo all’aeroporto. I tergicristalli vanno e vengono anche sul titolo del film, isolato e piccolo sul nero dello sfondo, vanno e vengono e cercano di cancellare il titolo, “Le passé”. Ma la scritta resiste e il passato infatti terrà duro fino alla “Fine”. Il passato verrà scoperchiato via via ma non solo non lo si potrà più rimuovere: schiaccerà sempre più oppressivamente ognuno e tutti. È un passato che i protagonisti non conoscevano se non in piccola parte: e dentro di esso sprofonderanno. Dicevamo della situazione di partenza: c’è l’ex marito, c’è la ex moglie, c’è una figlia grande (che pensiamo possa essere la loro figlia), c’è un’altra figlia bambina (di chi?), c’è un piccolino che è figlio dell’uomo, un francese, che adesso la donna vuole sposare. Man mano entrano in scena altri comprimari, comunque importanti, ognuno con qualcosa da dire, qualcosa capace di ribaltare quello che i personaggi e noi pensiamo di sapere del passato. Farhadi sembra preoccuparsi poco di farsi vedere come regista: sta addosso a ognuno dei suoi uomini donne bambini, non li molla, non c’è una scena liberatoria in esterni, non c’è un po’ di respiro, due case, una lavanderia e alla fine una camera d’ospedale da dove usciamo perché il film finisce lì, ma senza sapere cosa potrebbe succedere ancora. E in ogni scena, dalla prima all’ultima, c’è una rivelazione. Film ossessivo labirintico prigioniero di se stesso. Asfissiante e attraente. Voto 4 su 5.
“A Touch of Sin”, di Jia Zhang-ke
Miglior sceneggiatura
Che magnifico film! La Cina di oggi. Quella che era, quella che è diventata e quella che prevedibilmente sarà. Inizio folgorante. Bastano tre minuti per capire che: 1) qui il regista sa il fatto suo (questo lo sapevamo, Jia ha vinto il Leone d’oro con “Still Life”, ha diretto “Platform” e tanti altri bei film…); 2) che il regista si sta orientando a fare cose cinematografiche che non aveva mai fatto (scene d’azione, sparatorie, accoltellamenti: e questa è una sorpresa); 3) che il racconto, anzi i racconti saranno la colonna portante di “A Touch of Sin”. Titolo rivelatore: nella Cina di Jia è arrivato il peccato, il male fatto e subito, ne basta un tocco, una briciolina per abbattere idoli, ricconi, politici, funzionari e comunisti consumistico-capitalisti che non è un ossimoro, sono veri. Quattro storie, variamente intrecciate, storie di migrazioni. Dahai, minatore che tutti prendono per mezzo matto, combatte la corruzione dei dirigenti del suo villaggio. San’er si sposta di città in città, lui e la sua pistola, uccide per mandare i soldi a casa e perché gli piace. Xiao Yu lavora nelle saune, ha un amante sposato e scopre un’abilità a lei stessa sconosciuta, sa usare il coltello. Infine il giovane Xiao Hui è costretto a cambiare un lavoro dopo l’altro ed è il solo che non fa male agli altri. Tema comune alle storie che attraversiamo e con le quali percorriamo la Cina contemporanea è lo sviluppo brutale di un immenso paese, sviluppo che significa semplicemente ricchezza e violenza. Sentite e immaginatevi come inizia il film. Prima inquadratura: un uomo seduto ai bordi di una strada di montagna fa saltare riprende in mano fa saltare riprende in mano un pomodoro. Inquadratura larga: un grosso camion si è ribaltato, le cassette e i pomodori sono sparsi sulla strada. Un uomo guida la sua moto, escono fuori tre ragazzotti ognuno con un’ascia in mano, gli intimano di fermarsi, quello si ferma, vogliono i suoi soldi, quello della moto si mette la mano sotto il giubbotto come per prendere il portafoglio, estrae una pistola, ne fa secchi due, il terzo corre via, l’uomo si mette la pistola fra i denti!, lo insegue e lo liquida. Il motociclista riprende con calma il percorso e arriva dove si è ribaltato il camion dei pomodori. Sentiamo subito, fin da questa magistrale apertura, che Jia sta cambiando il suo cinema: resterà fedele alle sue inquadrature pensierose ma adesso ne pensa anche di efficacemente vivaci. In più dissemina invenzioni di tutti i tipi: serpenti di tutti i colori, un fucile caricato a pallettoni fatto su in una coperta con l’immagine di una tigre, la statua di Mao e un quadro della Madonna nella stessa scena!, ragazze in divisa militare scollata e hot pants messe in bella vista per ricchi acquirenti, una Maserati inondata di sangue. Dice Jia che per lui “A Touch of Sin” è un wuxia pian, un film di arti marziali, sulla Cina contemporanea. Tema portante dei film di questo genere è la lotta dell’individuo contro l’oppressione. “A Touch of Sin” mi sembra allora che possa essere considerato l’erede di un capolavoro di King Hu, “A Touch of Zen”*****. Solo che stavolta non c’è lo zen ma il sin. L’individuo, gli oppressori li fa fuori senza pensare a nessun dopo. Voto 5 e lode.
“Heli”, di Amat Escalante
Miglior regia
Una storia di povertà, sfruttamento, droga, polizia, militari, finti militari, narcos, ragazzotti violenti in un Messico desertico e vuoto. Tono oggettivo, storia violenta, personaggi tutti sullo stesso piano, scene esplicite e orribili di sevizie (ma il pubblico in sala si fa sentire solo quando è un cagnolino a soffrire; per gli esseri umani, no, anche quando succede una cosa che al cinema non mi era ancora capitato di vedere, come forma di tortura). Il film ha un andamento regolare, come se tutti i fatti fossero necessari, prevedibili, normalmente ammessi in un Messico in cui lo stato fa finta di esserci quando brucia tonnellate di cocaina e marijuana (ma un po’ è meglio tenerla da parte) e poi si affida una polizia che non si sa a cosa serva. Ho idea che molti film del festival partano dalla constatazione che le cose stanno così e staranno così anche nel domani vicino e in quello lontano. Film che registrano uno stato – disgraziato – del mondo. Voto 3½ su 5.
“Inside Llewyn Davis”, di Joel e Ethan Coen
Gran Premio della Giuria
Noi, coeniani fin dal loro big bang, sappiamo che i Coen si sono aperti e continuano ad aprirsi la strada di film in film, alcuni fondamentali tipo “Il grande Lebowsky”, “Fargo”, “A Serious Man”, altri minori che noi adoriamo come i primi, tipo “Crocevia della morte”, “Mister Hula Hoop”, “L’uomo che non c’era”, “Non è un paese per vecchi”, “Burn after Reading”, infine altri molto meno interessanti – per non dire proprio sbagliati, tipo “Ladykillers” – di cui noi adepti non siamo in grado di afferrare le ragioni che hanno spinto i fratelli a girarli (ma loro potrebbero avercele, delle buone ragioni). Questo “Inside Llewyn Davis” lo posizioniamo nella nostra scala un gradino o due sotto i film grandissimi e uno scalino sopra quelli ‘minori’ e belli. Insomma, è un gran bel film ’minore’. Protagonista un cantante folk nella New York all’inizio degli anni Sessanta, figura ispirata a Dave Van Ronk, un folk singer di allora che influenzò parecchio altri cantanti molto più conosciuti di lui e che non ebbe nessun successo commerciale. Dev’essere per questo che i Coen l’hanno scelto come looser per antonomasia. Llewyn non ha casa, gira per il Village, dorme due notti sul divano di un amico e due notti sul divano di un altro, canta con la chitarra, non ha mai un soldo, viene insultato dalla ragazza che ha messo incinta, il suo vecchio agente si commuove ma gli offre soltanto un mantello per coprirsi. Se ne va a Chicago in macchina con un formidabile John Goodman, gliene succedono di tutti i colori, un tizio lo picchia all’inizio e alla fine del film (nelle stesse identiche inquadrature). Gli succede soprattutto che il gatto rossotigrato della coppia di ebrei che l’ha ospitato scappi dalla finestra e lui debba corrergli dietro, il gatto scompare nei vicoli, altri gatti rossotigrati riappaiono nel film e alla fine il gatto giusto torna a casa. La differenza tra Llewyn e il gatto sta proprio qui: nel fatto che il secondo torna tranquillo a casetta, Llewyn invece la casa non l’avrà mai. Malinconia e umorismo. Grandi prestazioni d’attori: dal protagonista Oscar Isaac a Justin Timberlake, a Carey Mulligan, a Goodmanm fino al gatto che sa andarsene in giro per il mondo e tornare a casa e che perciò si chiama Ulisse. Buon film più che minore, quindi. Perché non un grande film? Perché i Coen non ci mettono, non vogliono metterci quel gusto del ‘filosofeggiar raccontando’ che ha reso superlativi i loro risultati più alti. Ultima cosa: mentre Llewyn viene pestato alla fine fuori dal locale, dentro c’è uno che ha tutta l’aria di quel Robert Allen Zimmerman, aka Bob Dylan, che cambierà la strada della canzone. Voto 4 su 5.
Bruno Fornara fa il critico cinematografico. È stato presidente della Federazione Italiana Cineforum. Scrive su “Cineforum”, “Rockerilla” e “La Rivista del Cinematografo”. Ha pubblicato “Charles Laughton, La morte corre sul fiume” e “Geografia del cinema, Viaggi nella messinscena”. È membro della giuria del premio per giovani critici “Adelio Ferrero” di Alessandria e del Premio internazionale di critica “Maurizio Grande” di Reggio Calabria. Ha fatto parte del gruppo organizzatore di Bergamo Film Meeting e della commissione selezionatrice della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, nel 2000, nel 2001 e nuovamente dall’anno scorso. È condirettore di Ring! Festival della critica cinematografica, e dell’Alba International Film Festival. Tiene molti corsi di cinema in giro per l’Italia e insegna alla Scuola Holden di Torino dall’inizio della sua storia.
Questa è la sua pagina Facebook, costantemente aggiornata con le anteprime dai Festival e con le ultime uscite in sala: https://www.facebook.com/pages/Bruno-Fornara/85215515624