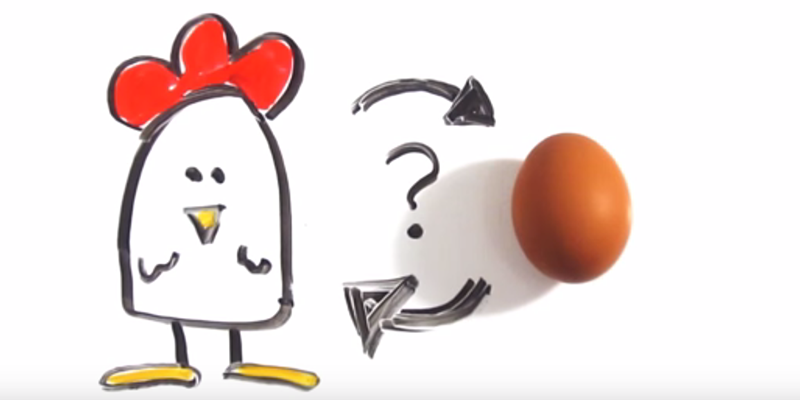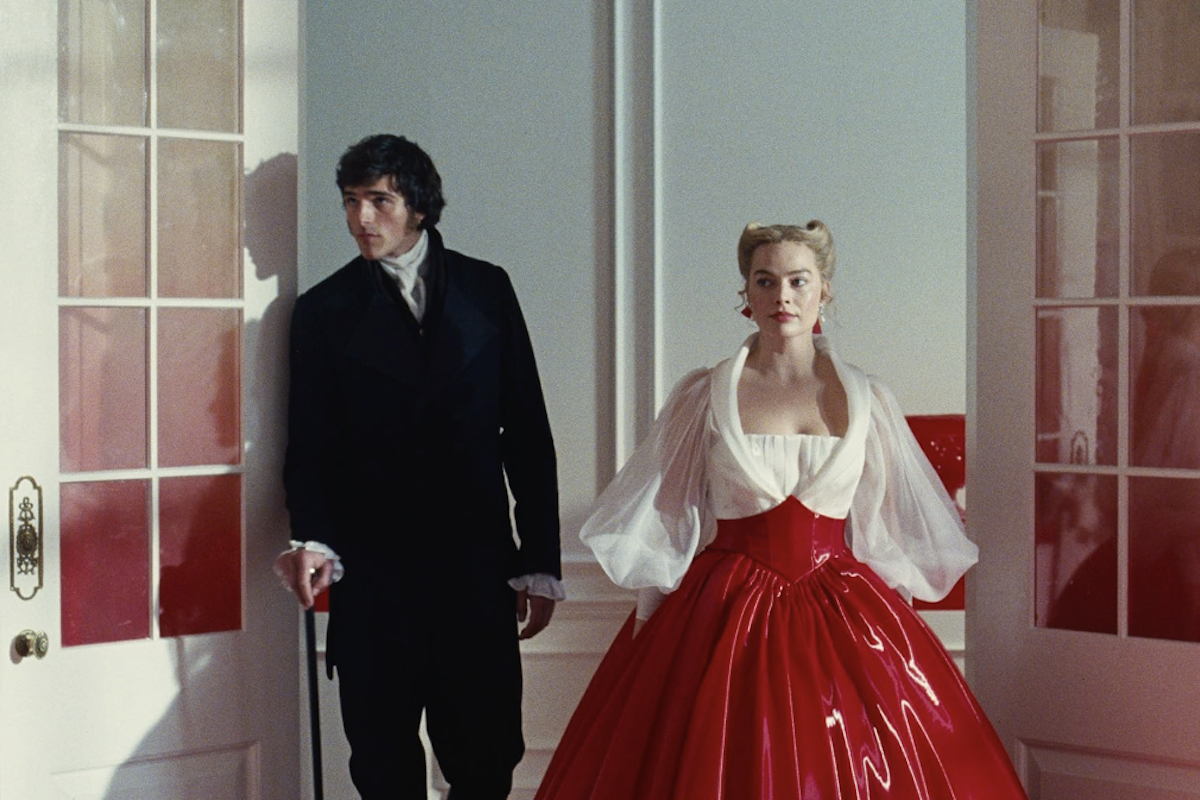Dieci canzoni degli Who
Selezionate da Luca Sofri nella versione aggiornata di “Playlist”, da riascoltare oggi che il loro disco più famoso compie sessant'anni

Il 3 dicembre 1965, sessant’anni fa, uscì My Generation, il primo e più famoso disco della band di rock inglese degli Who, tra le più note e influenti di sempre. Queste sono le dieci canzoni degli Who che Luca Sofri, il peraltro direttore editoriale del Post, ha scelto per il suo libro Playlist: una raccolta di storie intorno a più di tremila canzoni, pubblicata per la prima volta nel 2006 e disponibile ora in libreria in una versione aggiornata e ampliata. Playlist è pubblicato da Altrecose, il marchio editoriale del Post in collaborazione con l’editore Iperborea.
The Who
(1964 Londra, Inghilterra)
La band più rock della storia del rock, escludendo quelli della categoria “hard” rock. Avevano Pete Townshend, che sapeva fare di tutto con le chitarre (spaccarle sul palco, soprattutto) e con le tastiere, e scriveva quasi tutti i pezzi.
Avevano Keith Moon, che era un batterista da urlo e un pazzo formidabile. Avevano Roger Daltrey, per la parte cantante-biondo-capellone incazzato. Avevano John Entwistle, che suonava il basso come se stesse passando di lì per caso. Sono ancora in tour e tutto il rock britannico dagli anni Sessanta a oggi è venuto giù da lì, che li si chiami “i Who” o “gli Who”.
My generation
(My generation, 1965)
La mamma di tutte le canzoni di ribellismo giovanile, con un titolo che non poteva non fare centro. È diventato citatissimo anche il verso “I hope I die before I get old”. Dove Daltrey balbetta “why don’t you all f-f-f-fade away?” (“perché non sparite tutti quanti?”), l’effetto gioca sull’attesa che il “f-f-f” preluda a un “fuck off”. Lo stesso Daltrey ripensò la sua decisione di lasciare la band dopo il successo di “My generation”, che così tenne in vita gli Who.
I can’t explain
(1965)
Gli Who che si allenano a diventare gli Who, con un giovane Jimmy Page pre-Led Zeppelin che suona la chitarra (cosa mai chiarita: secondo alcuni suona solo sul lato B del singolo, “Bald headed woman”). Ce n’è una cover di David Bowie in Pin Ups.
Substitute
(1966)
Raccontò poi Keith Moon: «Io non me lo ricordo di aver suonato su “Substitute”: allora ero sempre così strafatto che quando il disco uscì me la presi con gli altri per aver usato un batterista al posto mio». Che non è male come sospetto, per una canzone con questo titolo.
I can see for miles
(The Who sell out, 1967)
Keith Moon, mitologico batterista degli Who morto a 32 anni, qui in forma smagliante. E un grande cambio di tono nel finale. Si dice che Paul McCartney abbia scritto “Helter skelter” per buttarla nel rock dopo aver sentito “I can see for miles”.
Pinball wizard
(Tommy, 1969)
Pezzaccio scatenato di chitarre e invenzioni, era nell’opera rock Tommy, scritta e musicata dagli Who (nel film che ne fu tratto la cantava Elton John) e celebrava il protagonista divenuto famoso come campione di flipper (“un mago del flipper”, per l’esattezza). L’idea nacque per compiacere il critico musicale Nik Cohn, gran giocatore di flipper.
See me, feel me
(Tommy, 1969)
Grandissima invenzione melodica, eppure semplicissima. Una lunga
introduzione in cui Daltrey ripete infinitamente lo stesso verso sempre più aggressivamente mentre dietro di lui montano batteria e chitarra, e poi tutti si tuffano nel refrain, altrettanto prolungato. È rimasta nella storia del rock l’esecuzione a Woodstock, con il sole che apparve appena attaccata la canzone.
Baba O’Riley
(Who’s next, 1971)
Uno dei dieci capolavori più riusciti della storia del rock, con un prologo leggendario di tastiere e batteria. Il titolo mette insieme i nomi di due fonti di ispirazione di Townshend, il guru Meher Baba e il musicista Terry Riley. L’inatteso violino impazzito in chiusura lo suona Dave Arbus, e fu un’idea di Keith Moon: nelle versioni successive dal vivo, è un’armonica suonata da Roger Daltrey. Per via dell’ingresso teatrale e gasato, ha un certo successo come eccitante da stadio.
Won’t get fooled again
(Who’s next, 1971)
“Meet the new boss, same as the old boss”. Quasi nove minuti sull’esaurirsi dei sogni rivoluzionari. Le cose cambiano, le persone cambiano, eppure siamo sempre al punto di prima, e non è cambiato nulla: “non ci faremo fregare di nuovo”. Con un lavoro strepitoso di Townshend alle tastiere, secondo solo a quello di “Baba O’Riley”, con cui condivide l’idea. Lo stesso Townshend rifiutò di concederla a Michael Moore per Fahrenheit 9/11, dicendosi poco convinto del regista e della sua opera.
Behind blue eyes
(Who’s next, 1971)
Nessuno sa cosa covi dietro quegli occhi azzurri. Pete Townshend scrisse questo pezzo per una sua opera dal parto tormentato, e fu poi fatto rientrare in Who’s next. Una prima parte è quieta e sembra una sbandata progressive (ma che sbandata) degli Who. Poi entra il baccano di repertorio e la chiusa ritorna daccapo. “No one knows what it’s like…”.
Getting in tune
(Who’s next, 1971)
Elogio della melodia, e chi se ne frega del resto: il concetto è “canto questa cosa perché suona bene, non che abbia qualche significato o le parole vogliano dire qualcosa: è intonata, punto”. Intorno a questa semplice esposizione suonano tutti come dei diavoli, a cominciare dall’ospite Nicky Hopkins al pianoforte.