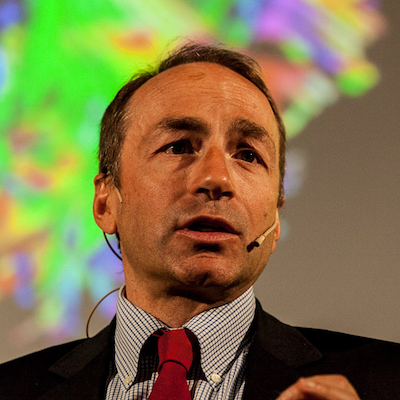Cosa fare per provare a salvare il pianeta, forse
Preparandoci alla COP30 sul clima, un po’ di studi sui modi con cui cooperiamo e ci freghiamo a vicenda, anche a costo di distruggere tutto

Aria, suolo, oceani, foreste: tutto ciò che condividiamo viene saccheggiato come se non ci fosse un domani. È il trionfo della “tragedia dei beni comuni”, l’espressione resa celebre dall’ecologo americano Garrett Hardin nell’omonimo articolo pubblicato su Science. La sua intuizione, tanto semplice quanto profetica, è che quando l’interesse individuale prevale su quello collettivo, una risorsa condivisa finisce inevitabilmente per essere depredata. Alla fine tutti – tragicamente – perdono.
Il gioco dei beni pubblici rappresenta una versione moderna del problema di Hardin. Giocarlo insieme può aiutarci a comprendere la logica dell’azione collettiva. Immagina un economista sperimentale in camice bianco che ti porge una busta con 100 euro in contanti. «Questi soldi sono tuoi – annuncia – puoi infilarteli in tasca e andartene, oppure puoi contribuire a una cassa comune. Qui con te, anche se non li puoi vedere, ci sono altri nove partecipanti, con la stessa identica busta. Fai attenzione: ogni euro che tu o loro verserete alla cassa verrà raddoppiato e poi ridistribuito in parti uguali a tutti, indipendentemente da quanto ciascuno ha effettivamente contribuito». Cosa faresti? Se nessuno mette niente, ognuno se ne torna a casa con i suoi 100 euro, senza colpo ferire. Ma se tutti devolvono l’intera somma alla cassa comune, il totale di 1000 euro verrà raddoppiato in 2000 euro. A testa, 200 euro: il doppio di quanto ricevuto inizialmente. Magia? No, cooperazione.
L’esempio classico è quello di un pascolo pubblico in un villaggio. Ogni pastore, per guadagnare di più, è incentivato ad aggiungere qualche capo di bestiame. Il pascolo si sovraffolla, l’erba non ha più il tempo di ricrescere, e ciò che era un bene comune si trasforma in una terra sterile, inutilizzabile da chiunque. La situazione si configura come un dilemma perché anche se tutti sanno che è meglio limitare lo sfruttamento della risorsa per preservarla, ciascuno è spinto comunque ad approfittarne. L’ottimo individuale produce un disastro collettivo.
E qui arriva il dilemma: perché contribuire, non è meglio lasciar fare agli altri? Conti alla mano, se lasciamo cooperare nove ingenui altruisti e ce ne tiriamo fuori, finiremmo per guadagnare 180 euro, da sommare ai 100 che ci siamo tenuti: un bottino di 280 euro. Benvenuti nel club dei free rider, quelli che viaggiano “a sbafo”; gli scrocconi dei beni pubblici. Ma se tutti ragionano così la cassa comune resta vuota e a ognuno toccano i soli 100 euro iniziali. Cooperare conviene a tutti, ma a te sfruttare il sistema conviene di più!
In realtà questo e molti altri esperimenti simili mostrano che in media le persone contribuiscono con circa la metà della loro dotazione iniziale: non siamo quindi irrimediabilmente egoisti. Ma quando qualcuno smette di contribuire, gli altri si adeguano e, turno dopo turno, la cooperazione crolla. Bastano però due correttivi per riaccenderla: un minimo di comunicazione (anche solo dichiarare le intenzioni) e la riduzione dell’anonimato (rendere visibili i contributi). Quando reputazione e trasparenza entrano in gioco, nessuno vuole passare per il furbetto del gruppo.
Il passaggio dal laboratorio alla geopolitica è diretto. I negoziati internazionali iniziano spesso con dichiarazioni solenni – il pianeta è un bene condiviso – ma si inceppano sui numeri: chi deve tagliare le emissioni, di quanto e con quali garanzie? Un contenzioso strutturale riguarda le responsabilità storiche e quelle attuali.
Le economie avanzate hanno costruito la loro ricchezza bruciando combustibili fossili per due secoli: dal 1750 Stati Uniti e Unione Europea hanno prodotto quasi la metà delle emissioni globali. Oggi però la Cina è di gran lunga il primo emettitore, seguita da Stati Uniti e India. I Paesi in via di sviluppo rivendicano il diritto a crescere e chiedono che chi ha inquinato di più riduca di più; le nazioni ricche, al contrario, pretendono impegni anche dalle grandi economie emergenti. Sullo sfondo, il vero nodo è il free riding: ridurre le emissioni costa a chi lo fa, mentre i benefici sono diffusi. Se ciascuno aspetta che siano gli altri a farsene carico, la cooperazione resta al palo.
– Leggi anche: Cosa aspettarsi dalla COP30 di Belém
La tensione tra interesse individuale e bene collettivo accompagna la nostra specie fin dai primi gruppi di cacciatori-raccoglitori. Nel suo classico del 1961 Il popolo della foresta, Colin Turnbull descrive la vita dei pigmei Mbuti dell’Ituri. La caccia è un’impresa collettiva: le donne battono la foresta, gli uomini presidiano le reti, e la preda viene poi divisa equamente – con una parte leggermente più abbondante per la famiglia del cacciatore più vicino alla cattura. Il sistema funziona finché tutti rispettano le regole. Ma un giorno Cephu, capo famiglia, decise di approfittarsi del lavoro comune, spostando di nascosto la propria rete davanti alle altre per intercettare più selvaggina – un caso da manuale di free riding. Smascherato, al ritorno al villaggio fu ridicolizzato, pubblicamente biasimato e minacciato di esclusione. Venne riammesso nella comunità solo dopo essersi scusato e aver restituito la preda.
Secondo un’ipotesi affascinante, la moralità sarebbe nata proprio per rafforzare la coesione sociale. Promuovendo la condivisione e riducendo i conflitti, le norme morali avrebbero aumentato le probabilità di sopravvivenza dei gruppi umani: le comunità più cooperative ed egualitarie avrebbero prevalso su quelle dominate da rivalità e sopraffazioni. Nel tempo, l’evoluzione culturale avrebbe lasciato tracce anche nel nostro cervello. Come ha rivelato uno studio su Science dal titolo particolarmente evocativo – From Oral to Moral – il disgusto morale attiva gli stessi circuiti neurali del disgusto fisico. Indignarsi di fronte a un comportamento sleale suscita nel cervello la stessa reazione che provocherebbe un cibo avariato: una risposta di rigetto immediata, viscerale. Per una specie che ha costruito la propria sopravvivenza sulla cooperazione, difendere le regole del vivere comune è diventato importante quanto evitare ciò che può nuocere al corpo.
Ma è davvero un cervello così banale quello emerso dalla pressione evolutiva, per cui il tradimento della fiducia è rivoltante e lascia, letteralmente, l’amaro in bocca?
In effetti sì, ma per altri versi anche molto sofisticato. Basti considerare che, in una serie di esperimenti condotti in Svizzera, gli economisti comportamentali Ernst Fehr e Simon Gächter mostrarono che la cooperazione nei giochi dei beni pubblici aumenta significativamente se i giocatori hanno la possibilità di sanzionare i free rider – attenzione – anche a costo di una perdita personale. Nella loro variante del gioco, infatti, era consentito sacrificare parte del denaro per ridurre i guadagni di chi non coopera. Per esempio, rinunciando a 10 euro, possiamo punire il trasgressore facendo sì che ne perda 50! E grazie a questa possibilità, la cooperazione cresce turno dopo turno, invertendo il declino osservato quando la punizione non è contemplata. Poiché chi punisce ci rimette di tasca propria, Ernst Fehr ha chiamato questo comportamento punizione altruistica.
Ma se punire i free rider ci costa e non porta vantaggi personali, perché lo facciamo? La risposta, anche in questo caso, sarebbe rintracciabile nelle nostre strutture neurali. In uno studio successivo, i ricercatori osservarono tramite tomografia a emissione di positroni cosa succedeva nel cervello dei partecipanti al gioco dei beni pubblici quando decidevano se punire o meno i trasgressori. Risultato: punire attiva i noti centri dopaminergici della ricompensa, gli stessi che si attivano per i piaceri della buona cucina (ancora cibo!), il sesso e la cocaina. In altre parole, farla pagare a chi ci vuole fregare è gratificante di per sé. E ciò che dà piacere si trasforma, dal punto di vista evolutivo, in un incentivo naturale alla cooperazione.
Oggi la nostra tribù non è più un piccolo gruppo nella foresta o un laboratorio di economia comportamentale, ma l’intero pianeta. E affrontare una sfida globale come il cambiamento climatico è un compito evolutivamente inedito: per la prima volta nella storia, la sopravvivenza del gruppo coincide con quella della specie. Se vogliamo che il nostro “villaggio globale” regga alla prova, dobbiamo imparare a trattarlo come una comunità, non come un’arena di opportunismi. Mentre il mondo assiste alla COP30, conviene ricordare che la cooperazione non nasce da sola: richiede fiducia, trasparenza e sanzioni credibili per chi defeziona.
Dove l’anonimato è minimo, le azioni sono visibili e la reputazione conta, la collaborazione regge; dove invece le promesse restano vaghe e gli impegni non sono verificabili, prevale l’opportunismo. Serviranno più trasparenza nei dati, più strumenti di verifica e responsabilità condivisa. Solo così il nostro villaggio globale potrà superare la logica dell’attesa e dell’interesse particolare, per agire in modo tempestivo e coordinato, scongiurando – questa volta davvero – che finisca in tragedia.
– Leggi anche: Alla COP30 i popoli indigeni stanno attirando l’attenzione