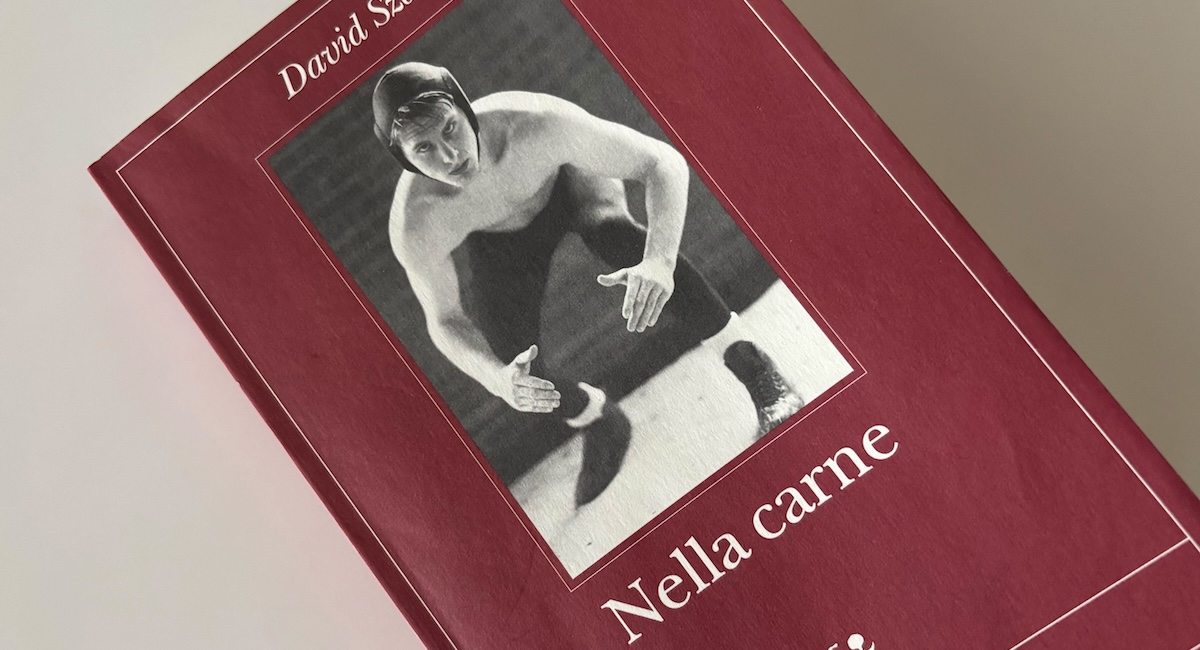Lo chiamiamo covidcore?
«Nella primavera 2020 scacciavamo l’incertezza di un periodo difficile, una canzone alla volta. Molti musicisti girarono video dalle loro camerette, definendo una nuova estetica casalinga, approssimativa e gratuita. Era una rivoluzione musicale di cui presto avremmo conosciuto le implicazioni mainstream»

Siamo da qualche parte nella primavera 2020. Siamo chiusi in casa da un po’. I giorni sono abbastanza simili uno all’altro, e io sono uno di quelli fortunati – ho il permesso di lavorare in presenza e andare in ufficio tutti i giorni, con gli accorgimenti del caso. Passo le serate a scandagliare video che arrivano in diretta su Instagram e posti del genere.
Chris Simpson, ex cantante/chitarrista dei Mineral (un mitico gruppo emocore degli anni ’90) e in procinto di esordire da solista a nome Mountain Time, suona qualche pezzo dalla sua cameretta con una chitarra acustica. Accoglie anche qualche richiesta da quelli che stanno guardando, dall’altra parte dello schermo. Oggi tocca a Slower, una delle canzoni più commoventi della sua band. Racconta la storia della canzone, a quanto pare la prima in cui i Mineral avevano iniziato a diventare la band che erano diventati. Il video lo riprende dal basso, probabilmente in giardino.
Per una persona che aveva ascoltato emocore per anni era una cosa che poteva commuovere fino alle lacrime, ma forse se qualcuno lo sentisse per la prima volta non ci troverebbe nulla di interessante. Era uno delle decine di migliaia di video che stavano girando, in diretta o in differita, sui canali social di tutto il mondo. Scacciavamo l’incertezza di un periodo difficile, una canzone alla volta; e forse c’era un briciolo di mitomania nel farsi guardare e ascoltare così, ma in fondo stavamo tutti facendo la nostra parte per sollevare un po’ l’umore, in attesa di tempi migliori.
Le caratteristiche generali di questi video definivano una nuova estetica: casalinga, approssimativa e gratuita, per le due o tre persone che avevano voglia di ascoltarla. L’impatto totale di tutta questa roba sulla cultura contemporanea era difficile da calcolare, ma sicuramente imponente. A me sembra la forma più pura e identificabile di una rivoluzione musicale che stava coinvolgendo artisti e pubblico a ogni livello percettivo, e di cui presto avremmo conosciuto le implicazioni mainstream: le dirette televisive dal soggiorno di casa delle popstar, gli eventi in streaming esclusivo a pagamento e tutto quello che ci finiva in mezzo. Nessuno ha ancora voluto prendersi il disturbo di dare un nome a questo fenomeno di massa. Io personalmente lo chiamo covidcore, nome con cui identifico qualunque forma musicale che esiste per via della pandemia di Covid-19.
Il covidcore esiste in due principali tipologie. Da una parte c’è il covidcore formale: musica che a prescindere dai contenuti lirici e artistici è realizzata con i mezzi che l’epoca concedeva. Registrazioni eseguite in ‘studi’ improvvisati tra le mura di casa, con le strumentazioni e le attrezzature che erano a disposizione, cercando di massimizzare la loro efficacia. Dall’altra c’è il covidcore concettuale: musica che, a prescindere da come è stata realizzata, riflette lo stato di isolamento di chi l’ha incisa. In questa categoria sono compresi tanto i dischi realizzati all’epoca ma in studi professionali, quanto i dischi realizzati in seguito.
Il più celebre disco covidcore, e probabilmente il manifesto mainstream del genere, è Folklore di Taylor Swift. È un album che appartiene in fondo a entrambe le tipologie covidcore. Swift si trova a lavorare al disco all’indomani dell’annullamento del tour di Lover, disco uscito nel 2019. Coinvolge nella realizzazione delle canzoni il produttore Jack Antonoff, suo abituale collaboratore, e una new entry piuttosto inattesa per il bacino della cantante: Aaron Dessner, chitarrista dei National, di cui ha mutuato la routine compositiva (i National vivono sparsi in giro per il mondo e lavorano alle canzoni scambiandosi i file in remoto). Per ovviare alla chiusura degli studi di registrazione, Swift ne costruisce uno in casa; da lì arrivano le tracce base, che vengono inviate ad Antonoff a New York. L’album che esce dalle session viene pubblicato a sorpresa nel luglio del 2020, viene osannato dalla critica e genera perfino un album-sorella, Evermore, pubblicato cinque mesi dopo.
– Leggi anche: Come è arrivata Taylor Swift ad avere tutto questo successo
Intorno a Folklore ed Evermore fiorisce una selva di album che scavano sul concetto in maniere diverse. Un esempio abbastanza clamoroso in tal senso è how i’m feeling now di Charli xcx, un album che origina da alcuni livestream tenuti nel primo periodo di lockdown e si sviluppa come un progetto in collaborazione non solo invitando amici e ospiti ma anche chiedendo una collaborazione ai fan, invitandoli a dare giudizi sulle tracce e altri contributi. Nella sostanza, un album che prenderà la sua forma definitiva in remoto.
Oppure Idiot Prayer di Nick Cave, registrazione di una performance per piano e voce all’Alexandra Palace di Londra, trasmessa inizialmente in streaming live, a pagamento, e poi evolutasi in un (peraltro ottimo) live album/video che tra le altre cose è all’origine di una storia tra l’artista e l’azienda italiana Fazioli, di cui trovate un resoconto sul Post. La mia opera preferita è Live at the Opera House dei Metz, noise band canadese che aveva pubblicato il suo disco più ambizioso (Atlas Vending) pochi mesi prima del lockdown e, vista l’ovvia cancellazione del tour, pubblicò sulle piattaforme l’unica esecuzione live (a porte chiuse) dello stesso, ospitata dalla Opera House di Toronto. Ma il disco che forse fa di più per codificare l’estetica del covidcore è Microphones in 2020, album-diario registrato da Phil Elverum (forse il più importante musicista indie contemporaneo se si parla di registrazioni in casa) che approfitta del confinamento per chiudere l’ambizioso progetto di raccontare l’intera carriera della sua band (compresi i giorni in cui il disco viene registrato).
In realtà nello scegliere alcuni esempi viene spontaneo chiedersi su quale base selezionarli: quasi tutta la musica uscita negli anni della pandemia ha avuto a che fare con la pandemia, l’ha respirata, o per certi versi l’ha anche rifiutata. E questo che più di tutto colpisce nell’estetica del covidcore: è contraddittoria. L’approccio alle registrazioni domestiche, specie al di fuori dei generi che fanno più affidamento sugli studi (cioè quelli che gravitano intorno agli strumenti) ha molto a che fare con la bassa fedeltà: microfoni, schede audio e strumenti che di solito vengono utilizzati dai musicisti per registrare versioni demo, pre-produzioni su cui poi si lavorerà, che assurgono improvvisamente allo stato dell’arte.
Ma quelle registrazioni sono perlopiù fatte con strumenti di cattura audio-video all’avanguardia, e il progresso tecnologico ha garantito una capillarità della distribuzione di quei pezzi di informazione che sarebbe stata impensabile anche solo dieci anni prima. L’evoluzione delle tecniche di registrazione casalinga (software precaricati sui computer, microfoni disponibili a due lire su Amazon) ha abbassato la soglia d’ingresso del do it yourself, e negli ultimi dieci anni il concetto stesso di pubblicare musica identifica una cosa totalmente diversa da quel che si era inteso nel secolo precedente; oggi per ‘pubblicare un disco’ basta caricarlo su un portale di streaming, potenzialmente pochi minuti dopo aver completato la registrazione. La possibilità di pubblicare musica in tempo reale senza dover sottostare alle logiche dei formati fisici ha generato una furia distributiva ai limiti della psicosi, ed è logico che l’estetica covidcore abbracciasse questo nuovo approccio nel definirsi. Una sorta di hi-tech lo-fi.
E quindi, siccome chiunque voglia pubblicare musica ha la possibilità di farlo, il covidcore è andato a musicare questa esperienza collettiva condivisa, nello stesso modo in cui durante il lockdown normali utenti dei social senza esperienza lanciavano dirette la sera tardi. Anche la musica di quegli anni è la somma collettiva di tante piccole esperienze individuali di autopubblicazione di qualità media accettabile o poco più.
Era normale, tuttavia, che questa estetica ne producesse una uguale e contraria, un gemello malvagio e bombastico. Chiunque avesse la possibilità di distinguersi tramite un cospicuo dispiego di mezzi è stato incentivato a farlo, e il risultato sono state esperienze audiovisive di profilo altissimo e livello tecnico che prima della pandemia sarebbe stato impensabile: streaming “esclusivi” su portali costruiti ad hoc, concerti di Travis Scott su Fortnite, e in certi casi eventi in posti fisici a inviti ultralimitati. In altre parole: il covidcore nasceva come un’alternativa, e come ogni alternativa è stato cooptato dal mainstream, da persone e aziende che non potevano comprenderne la natura grezza e istintiva. L’incarnazione bombastica del covidcore mainstream ha spinto a sua volta i piccoli a differenziarsi, a investire su una cesura estetica ancora più marcata. E quindi su dischi di tastiera-e-voce catturati alla bell’e meglio che scavano dimensioni minuscole e ultraprivate, ai limiti della misantropia. Le inquadrature sghembe dei musicisti e gli screenshot della quotidianità diventano peraltro lo standard con cui vengono realizzate molte delle copertine dei dischi dell’epoca (i già citati how i’m feeling now e Microphones in 2020, ma anche molti altri).
Andrebbe spiegato, ed è difficile farlo, come sia possibile che il covidcore non abbia avuto un’impronta di lungo periodo sulla cultura. È curioso per esempio notare come non ci siano singoli pop di altissimo profilo che venga automatico associare alla vita in isolamento. La prima opera a cui si pensa in questi termini, quella che ha messo tutti d’accordo, è una specie di documentario-musical, Bo Burnham: Inside, performance casalinga dell’attore/autore statunitense uscita su Netflix nel maggio 2021. Canzoni che passano alla radio, invece, non ce ne sono. Lo stesso Folklore, per quanto osannato e riverito ancora oggi, non è necessariamente più osannato e riverito di altri dischi di Taylor Swift. È una cosa bizzarra se consideriamo che tra le ragioni d’essere del pop c’è quello di musicare esperienze comuni, e l’isolamento da pandemia è stata forse l’esperienza più ‘comune’ all’Occidente degli ultimi 25 anni.
All’inizio parlavo di rivoluzione musicale anche per questo: mi sembra che il covidcore abbia sovvertito le regole e rivoltato lo status quo al punto da rendere necessario un processo di restaurazione, uguale e opposto. A cui abbiamo partecipato tutti. Oggi è raro incappare in un articolo che analizzi l’epoca del covidcore e la consideri parte del continuum musicale contemporaneo, come del resto si tende a non considerare il lockdown un vero e proprio periodo della nostra storia. Il processo generale di rimozione della pandemia, in ogni aspetto mediatico e narrativo, ha richiesto la cancellazione del ritratto umano di ognuno di noi che le contingenze di quei giorni avevano dipinto. E quindi, forse, è inevitabile che non si accetti il covidcore all’interno della “musica popolare”, cioè della “musica del popolo”, in quanto colonna sonora di una serie di esperienze collettive. Intendo dire che quando gli appartenenti alla mia generazione ascoltano 50 Special dei Lunapop o Today degli Smashing Pumpkins, per prendere due esempi a caso, le associano naturalmente a periodi delle loro biografie che avevano quelle canzoni come sottofondo: feste private, occupazioni, marce politiche, concertoni estivi, notti prima degli esami. L’isolamento da pandemia ha coinvolto il mondo intero, ma come somma di milioni di individualità, e nessuna di quelle individualità sembra essere interessata a raccontarsi all’interno di un movimento collettivo.
È un peccato. Perché riascoltando how i’m feeling now viene in qualche modo spontaneo associarlo a quei giorni e provare una specie di conforto, abbastanza simile a quello che ci davano le canzoni pop della nostra adolescenza: in mezzo alle righe dei testi cercavamo tracce della nostra umanità. Gli Smiths chiedevano di impiccare i dj, perché la musica che suonavano non ci raccontava niente che riguardasse la nostra vita. Il covidcore, quantomeno, su questo aspetto è stato fin troppo onesto, e spero che un giorno questa onestà, se proprio non vogliamo riconoscerne la bellezza, possa venire riconosciuta in qualche modo.