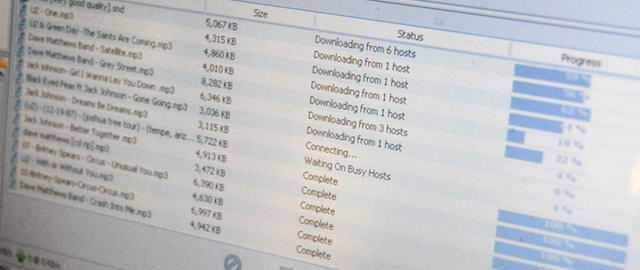Chi sono le persone non binarie
O "non binary" o "enby": rientrano nella definizione di transgender ma non riconoscendosi né nel genere femminile né in quello maschile fanno particolare fatica a farsi capire

Da alcuni anni è diventato più frequente sentire persone, anche famose, che dicono di essere “non binary”, cioè di avere un’identità di genere non binaria. Vale per esempio per Nemo, cantante rappresentante della Svizzera che ha vinto l’ultima edizione dell’Eurovision, ma negli scorsi anni se n’era parlato anche per le dichiarazioni di alcune celebrità statunitensi come Elliot Page, Demi Lovato, Bella Ramsey ed Emma D’Arcy. Rispetto ad altre parole che definiscono l’identità sessuale e che sono ormai da alcuni anni largamente conosciute e usate (come quelle della sigla LGBT per esempio), il termine “non binary” continua a essere per certi versi più difficile da spiegare e capire, e forse anche per questo risulta ancora oggi a molti oscuro o del tutto sconosciuto.
Il motivo principale di questa difficoltà è che il concetto di non binarismo si scontra con l’idea molto radicata nella società secondo cui esisterebbero solo due generi: quello maschile e quello femminile. Le persone non binarie non si riconoscono completamente né nell’uno né nell’altro e questo è per molti particolarmente difficile da comprendere. Rientrano nella più ampia definizione di persone transgender (o trans) perché non si riconoscono nel genere che corrisponde al loro sesso biologico e provano un disagio causato da questa incongruenza, ma hanno allo stesso tempo un’esperienza un po’ diversa da quella delle persone trans con un’identità di genere binaria, che si sentono cioè uomini o donne.
Come spesso accade quando si parla di questioni di genere, i termini più usati, anche in Italia, vengono dall’inglese: si sente dire spesso “non binary” o “enby” (dalle iniziali N e B), più raramente “persone non binarie”.
Nel libro del 2024 Essere non-binary. Taccuino per psicologз contemporaneз di Nadia Santini viene fatta una breve cronologia di come si è diffusa la consapevolezza del non binarismo. Inizia molto di recente, nel 2011, anno in cui l’Associazione mondiale per la salute delle persone transgender (WPATH) aggiornò le proprie linee guida in modo che includessero anche le persone non binarie. Due anni dopo, nel 2013, uscì il DSM-5 (la quinta edizione del Manuale diagnostico e statistico psichiatrico, riferimento per la psichiatria in tutto il mondo): oltre a non citare più il “disturbo dell’identità di genere” come malattia mentale ma solo la disforia di genere (cioè il malessere che provano le persone che non si riconoscono nel genere a loro attribuito), contemplava per la prima volta anche l’esistenza di un’identità di genere non binaria. La bandiera dell’orgoglio non binary invece fu creata nel 2014: è composta da quattro strisce orizzontali che dall’alto in basso sono gialla, bianca, viola e nera.
In Italia il primo blog nato per raccontare e fare informazione «sul mondo non binario» è stato Progetto Genderqueer nel 2009, ma in quegli anni era un tema di cui non si parlava quasi per niente fuori da internet. Naturalmente le persone non binary esistevano anche prima, ma nei primi anni Duemila il web ebbe una funzione fondamentale nell’aumentare la consapevolezza di giovani e non giovani che volevano esplorare la propria identità sessuale, sia perché permise l’accesso a informazioni che altrimenti sarebbero state irrecuperabili, sia perché iniziò a rendere possibile un contatto tra persone lontane con esperienze simili. Nel caso delle persone non binary i forum e le chat online erano anche un luogo dove poter sperimentare diverse rappresentazioni, usando nomi e avatar per trovare quello che li faceva sentire più a loro agio. Internet rimane un luogo fondamentale di esplorazione, conoscenza e accettazione in questo senso ancora oggi.
Nella cultura pop, un momento spartiacque che viene spesso citato quando si parla di aumento della consapevolezza dell’esistenza delle persone non binary è l’introduzione, nella seguita serie tv americana Billions, di Taylor Mason, un personaggio non binary interpretato da Asia Kate Dillon, nel 2016. Altri personaggi non binary sono arrivati poi alcuni anni dopo in altre serie molto seguite, come Cal in Sex Education e Kai Bartley in Grey’s Anatomy. Nella seconda stagione della serie Feel Good, distribuita da Netflix anche se non molto conosciuta, l’artista di stand up comedy Mae Martin racconta la storia autobiografica di come ha deciso di fare coming out (cioè dire pubblicamente) di essere non binary.
In Essere non-binary Santini scrive che in Italia non ci sono dati sul numero di giovani con identità di genere non conforme, ma che mettendo insieme dati raccolti e pubblicati in altri paesi «si può sinteticamente indicare che si riconosce come non binary in media circa il 2% di giovani nella popolazione generale, il 30% nella popolazione transgender non clinica e il 15% tra giovani trans che accedono ai servizi specializzati». Questo genere di stime è comunque spesso messo in discussione e va quindi preso molto con le molle.
Nella definizione di non binary comunque si riconoscono persone con esperienze anche molto diverse tra loro. Ci sono per esempio persone che pur non riconoscendosi pienamente né nel genere femminile né in quello maschile magari convivono in modo tutto sommato sereno col proprio aspetto e col proprio nome, riuscendo a trovare rapporti, contesti e spazi in cui farsi conoscere per come sono. Ci sono però altre persone che hanno esperienze di maggiore sofferenza, perché vivono in contesti in cui il modo in cui si sentono non viene accettato, o si trovano a disagio nel proprio corpo, e come avviene con molte persone trans binarie vorrebbero iniziare una terapia ormonale, magari con dosi ridotte, o sottoporsi a interventi chirurgici per cambiarlo.
Le persone che appartengono a questo secondo gruppo si rivolgono solitamente ai servizi che si occupano della valutazione psicologica che è prevista dalle leggi italiane per chi vuole iniziare una transizione di genere (sia a livello medico che burocratico). Quello che succede spesso però è che decidano di non presentarsi come persone non binarie per il timore di non rispettare i “criteri” considerati necessari per iniziare una transizione di genere. Non è un timore del tutto infondato visto che all’interno di molti servizi e istituzioni c’è ancora una certa ignoranza rispetto al non binarismo. In generale, è più facile che la terapia ormonale venga autorizzata a una persona che mostra di aderire completamente a tutte le caratteristiche associate a uno dei due generi, che non a una che non si riconosce in nessuno.
Questa difficoltà a farsi comprendere può avere un impatto negativo sulla salute mentale delle persone non binary. Nel suo libro Santini scrive che «i risultati delle ricerche sembrano concordi nell’indicare che individui non binari sperimentino difficoltà significative e siano per questo a elevato rischio di esiti negativi in termini di salute mentale; e che tali difficoltà siano più rilevanti sia di quelle sperimentate da persone cisgender che transgender».
Per esempio una persona non binary che voglia sottoporsi a un’operazione di rimozione del seno può farlo in Italia solo insieme a una terapia ormonale maschilizzante, ma ci sono anche persone non binary che pur volendo farsi togliere il seno non vogliono iniziare una transizione con gli ormoni e non vogliono cambiare genere sui documenti. Spesso finiscono con l’andare a fare l’operazione all’estero, in paesi come la Germania dove invece è possibile.
Nella società contemporanea le persone non binarie si trovano a dover fare i conti con moltissime cose che in misure diverse le ostacolano nell’affermazione della loro identità. Oltre al fatto che moltissime persone non sanno cosa voglia dire essere non binary ed è quindi molto difficile spiegarlo e farsi ascoltare e rispettare, un altro grosso ostacolo è il linguaggio. In italiano come in molte altre lingue infatti non esiste un modo per riferirsi a qualcuno in modo neutro, e pronomi, sostantivi e aggettivi devono quasi sempre essere declinati o al maschile o al femminile, cosa che per persone che non sono a loro agio con nessuna delle due cose può essere un problema non da poco.
In inglese una soluzione a questo problema che si è diffusa parecchio negli ultimi anni è quella di usare il they singolare (un pronome neutro che esisteva già ma era poco diffuso nell’inglese contemporaneo): è il motivo per cui molte persone anglofone indicano nelle proprie bio sui social network la dicitura «they/them». Nella lingua inglese però è abbastanza facile perché sostantivi, aggettivi e verbi non hanno quasi mai desinenze che ne indichino il genere: non esiste il problema “stato/stata”, e non bisogna scegliere tra “alto” o “alta”. Il tentativo di introdurre pronomi e desinenze neutre è stato fatto con più difficoltà anche in altre lingue, tra cui lo spagnolo, il francese e lo svedese.
In italiano, nello scritto si usano in molti contesti asterischi, X, U o altri segni neutri alla fine delle parole per evitare di scegliere tra la desinenza maschile e femminile. Sia per lo scritto che per l’orale una delle proposte che ha avuto più seguito negli ultimi anni è stata quella di usare lo schwa (ə), una vocale intermedia, il cui suono cioè si pone esattamente a metà strada fra le vocali esistenti. In certi gruppi, famiglie e contesti alcune persone non binary chiedono che ci si rivolga a loro sospendendo le parole o appunto finendole con lo schwa (amicə, maestrə, simpaticə) ma anche questo in molti casi non risolve il problema, soprattutto nel parlato, dove ci si troverà sempre a dover scegliere tra “le” e “gli”, tra “fratello” e “sorella”, o tra “scrittore” e “scrittrice”, solo per fare degli esempi in cui una vocale neutra alla fine non risolve il problema.
Per questo in molti casi le persone non binary italiane alla fine si trovano a dover farsi andar bene almeno uno dei due tra il maschile e il femminile. Può sembrare una questione solo formale ma non lo è: sentirsi chiamare col genere attribuito dalla nascita sulla base del sesso biologico può creare disforia esattamente come avviene alle persone trans binarie, solo che in questo caso anche usare il genere opposto può creare disagio.
Inoltre le persone trans che fanno una transizione di genere cambiano il proprio aspetto e questo rende più immediato agli altri rivolgersi a loro col genere in cui si riconoscono, mentre le persone non binary hanno continuamente a che fare con persone che presumono il loro genere mettendole spesso a disagio. La cosa migliore che si può fare è chiedere come preferiscono che ci si rivolga loro, e quando possibile formulare le frasi in modo che non prevedano la scelta di un genere (per esempio anziché «sei stanco/stanca?» si può chiedere «provi stanchezza?»: non è sempre fattibile ma in molti casi sì).
In Italia e in molti altri paesi del mondo inoltre le persone non binarie si scontrano con un problema burocratico, e cioè che il genere deve essere necessariamente indicato nei documenti anagrafici e le opzioni tra cui scegliere sono solo maschile e femminile. Recentemente la questione è stata affrontata e risolta introducendo una terza dicitura sui documenti anagrafici in molti paesi del mondo in cui si è diffusa una certa sensibilità al tema. In Belgio e nei Paesi Bassi per esempio è prevista la possibilità di chiedere la cancellazione di qualsiasi riferimento al genere nei documenti d’identità. Sempre in Europa negli ultimi anni è stata introdotta una terza opzione (di solito “non binario” o X) sui documenti in Islanda, Austria, Danimarca, e nei prossimi mesi sarà reso possibile anche in Germania.
Nel resto del mondo succede già in Colombia, Australia, Nuova Zelanda, Argentina, Cile, Brasile, Stati Uniti (con alcune differenze da stato a stato) e Canada. In alcuni paesi come India, Nepal, Bangladesh, Pakistan, Taiwan e Thailandia si riconosce l’esistenza di un “terzo genere” sui documenti perché da tempo sono riconosciute istituzionalmente persone a cui alla nascita è assegnato il genere maschile ma che nel corso della vita assumono un nome femminile (in India si chiamano hijra), e che sono tradizionalmente considerate un genere a parte.