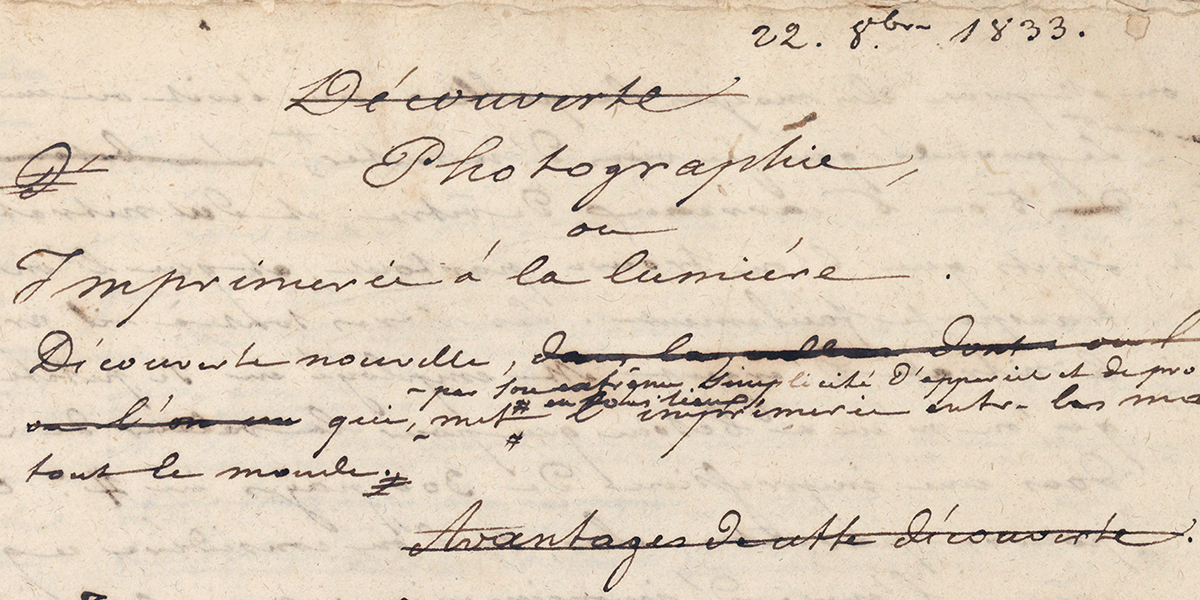Unplugged dei Nirvana, quanto tempo è passato
«Prima di cena, rientrando brillo e incantato verso la città, mi fermai in un negozio e comprai l’"Unplugged in New York", il disco che ho poi più ascoltato, che ho letteralmente consumato, che mi ha accompagnato in tutti i miei viaggi, le mie città, le mie case, i miei drammi, le mie estasi. E che ancora oggi, trent’anni esatti più tardi, mi ispira un'assillante domanda: mi incaponisco a frugare in cosa ci sia nella dolce asprezza di quella voce, di quelle parole, di quella musica, di quel maglioncino verde, di quelle sigarette, di quelle accelerazioni e quei silenzi, che mi fa vibrare così tanto. Anche cosa vibra nel ricordo di me che imparo una delle sue canzoni»

Manco lo volevano fare, quel concerto. Molte delle leggende del rock che erano passate di lì avevano suonato nell’angusto teatro come se fossero in uno stadio, o in uno studio di registrazione, e ai Nirvana pareva che avesse poco senso. Scappa da ridere, a pensarci: non riesco a trovare opera che ancora oggi, trent’anni esatti dopo, abbia più senso; per me, per ciò che sono diventato, e per l’intero mondo che ci siamo costruiti.
Quando Beth McCarthy e Alex Coletti, ideatrice e produttore della serie degli MTV Unplugged, videro la scaletta dei pezzi e degli ospiti si incazzarono: si aspettavano dai Nirvana i loro pezzi più famosi – Smells Like Teen Spirit o Lithium – qualunque dei raggi luminosi che li avevano proiettati nell’olimpo delle più grandi rock band del pianeta. I Nirvana, Kurt Cobain in particolare, volevano invece suonare una serie di pezzi minori, molte cover semi sconosciute, e invece di invitare Eddie Vedder o Tori Amos proposero di portare sul palco Curt e Cris Kirkwood, dei Meat Puppets.
Era il 18 novembre 1993. Era l’anno dell’insediamento di Bill Clinton, del primo attentato al World Trade Center di New York, della bomba in via dei Georgofili, dell’evirazione di John Wayne Bobbitt per mano di sua moglie Lorena, degli sbandierati e farlocchi accordi di Oslo tra Israele e OLP, dell’elezione di Rudolph Giuliani a sindaco di New York e dell’uccisione di Pablo Escobar. Erano da poco crollate le cortine di ferro dei regimi sovietici, si aveva l’illusione che il mondo si stesse trasformando in un grande parco, su cui scorrazzare liberamente. Adesso sembra guardarci negli occhi, quel 1993.
Kurt Cobain non era meno tormentato del pianeta su cui soggiornava, e che avrebbe presto abbandonato. Braccato dal successo planetario del suo secondo disco, confuso dal nuovo album uscito poche settimane prima, piegato da continui dolori allo stomaco e risucchiato dall’abuso di eroina, nei mesi precedenti era sopravvissuto a diverse overdose e tentativi di suicidio. Spesso i due eventi si accavallavano. Il giorno dell’Unplugged non si lavava i capelli da una settimana, dava segni di essere in crisi di astinenza. Usando espressioni che la produzione non capiva, non si sa se per scherzo o meno, continuava a chiedere che gli venisse portata della roba. Quando Alex Coletti disse a Kurt che le candele e i gigli che aveva scelto per il palco facevano sembrare di essere a un funerale, Kurt rispose «Esatto, proprio come a un funerale».
La teoria di William S. Burroughs era che Kurt se ne fosse già andato. Si erano conosciuti la primavera precedente, per lavorare insieme a The “Priest” They Called Him, la registrazione di un racconto di Burroughs con in sottofondo versioni distorte di Silent Night e dell’inno nazionale americano suonate da Kurt. «Kurt non si è ucciso», avrebbe in seguito dichiarato Burroughs a Rolling Stone, «Kurt era già morto». Nemmeno il suo viso, secondo lo scrittore, aveva più il colore dei vivi.
Le prove per l’Unplugged erano state tese, macchinose. I Nirvana non riuscivano a suonare in acustico diversi brani e dovettero accantonarli all’ultimo momento. Erano tutti preoccupati che Dave Grohl, alla batteria, non sarebbe stato in grado di usare la delicatezza che serviva per un unplugged e per un raccolto teatro come quello dei Sony Music Studios di New York. Coletti durante le prove mandò un ragazzo in un negozio dietro l’angolo e fece portare a Grohl un paio di bacchette più leggere, facendolo passare per uno scherzo. Dave finì per portarsele sul palco. «Pensavamo che sarebbe stato un disastro», avrebbe poi detto in una sua famosa intervista.
Eppure, quando arrivò il momento, Kurt – qualunque creatura fosse, viva o morta – salì sul palco, si avvicinò alla brutta sedia da ufficio lasciata da lui stesso davanti al microfono, raccolse la sua Martin e con uno spelacchiato cardigan verdolino appeso alle spalle intonò una delle più struggenti ore della musica contemporanea. I Nirvana furono i soli, oltre ai Live e Crosby, Stills, Nash & Young, a concludere il concerto senza ripetere alcun pezzo. E sì, se ne fregarono, suonarono otto dei loro pezzi meno famosi, in cui incastonarono sei cover, tutte – a eccezione di The Man Who Sold The World di David Bowie – di gruppi e autori mezzi sconosciuti o dimenticati, tra cui Jesus Doesn’t Want Me For A Sunbeam, un antico inno cristiano riarrangiato dai Vaselines.
È questa la prima canzone che ho imparato, a quasi quattro anni dal concerto e tre dall’uscita del disco. Ed è un ricordo talmente perfetto da risultare imbarazzante. Ne conservo un appunto, dunque ho la fortuna di saperlo esattamente piazzare: 19 settembre 1997. Se divertono le assonanze tra i numeri, avevo 19 anni.
Le sgraziate misure dei miei capelli, che nei mesi precedenti mi avevano fatto somigliare a un levriero afgano, si erano finalmente allungate fino a permettermi di portare una coda. Indossavo di continuo un paio di neri pantaloni di pelle, comprati d’estate ad Amsterdam, durante il mio lisergico viaggio di maturità. Adoravo quei pantaloni. Quel giorno indossavo anche una camicia militare a cui avevo tagliato le maniche. Adoravo anche quella. Scrivevo poesie, stavo per partire per il primo dei miei grandi viaggi, facevo robusto uso di sostanze stupefacenti, scrivevo quello che sarebbe diventato il mio primo romanzo. Non mi sarei mai più sentito tanto vicino a ciò che sognavo di essere.
Daniele, un mio strampalato amico, si era offerto di insegnarmi a suonare la chitarra. Ne andammo a comprare una usata nel negozietto del suo paese, alla periferia nord di Firenze, poi montammo sul suo vespino di tre colori diversi e ci avviammo verso le colline. Sulla strada comprammo anche un fiasco di vino.
Eccolo là, l’impeccabile ricordo: io e Daniele in una radura in campagna, la luce del pomeriggio di fine settembre, una vespa scassata di fianco, un fiasco di vino, una chitarra. Ho già ammesso il mio possibile imbarazzo, dunque me ne frego e ci affondo: c’è niente di più incantevole?
Daniele stava scrivendo su un foglio parole e accordi di Knockin’ On Heaven’s Door, gli domandai se conosceva qualche pezzo dei Nirvana. Ci pensò su, disse che nell’Unplugged c’era una cover molto facile, e me la mostrò. Era Jesus Doesn’t Want Me For A Sunbeam. Provai a suonarla, diventò la prima delle sole cinque o sei canzoni che avrei mai imparato. Provammo poi anche noi a scrivere una canzone. Non ne venne fuori granché, ma mi resta quel foglio a quadretti, quei versi sbilenchi, e quella data.
Prima di cena, rientrando brillo e incantato verso la città, mi fermai in un negozio e comprai l’Unplugged in New York, il disco che ho poi più ascoltato, che ho letteralmente consumato, che mi ha accompagnato in tutti i miei viaggi, le mie città, le mie case, i miei drammi, le mie estasi. E che ancora oggi mi ispira un’assillante domanda.
Jesus Doesn’t Want Me For a Sunbeam è il terzo pezzo del concerto. Nel silenzio dopo l’applauso Kurt dice che è sicuro di sbagliare il pezzo successivo, e intona invece una versione di The Man Who Sold The World che sarebbe passata alla storia. Appena finita la cover di Bowie il gruppo scambia un altro paio di battute. Kurt dice che il pezzo non gli è venuto male, gli altri ridacchiano, annuiscono. Lui domanda se farà il pezzo successivo da solo. «Sì, fallo da solo», si sente rispondere. Poi l’epocale battuta: «Proverò a farlo in una chiave diversa, proverò a farlo in una chiave normale. E se suona male… bisognerà che questa gente aspetti». Il pubblico ride. Poi Kurt, lì da solo sul palco, dà vita alla più commovente versione di Pennyroyal Tea di cui si abbia traccia.
Poco prima di lasciare il palco a Kurt, un giovanissimo, magro e sbarbato Dave Grohl si volta verso Pat Smear, lì a fare da seconda chitarra, e gli chiede una sigaretta. Non si sente nel disco, resta solo nelle registrazioni senza tagli. «Do you have a smoke, Pat?». «Hai mica un cicchino?», si sarebbe domandato a Firenze. Eccolo, lo splendore di ciò che sta accadendo davanti agli occhi di chi era lì e poi di tutto il mondo. Tre ragazzi che fino a due anni prima suonavano nei bar di provincia, diventati rock star internazionali, in un piccolo teatro di New York davanti a milioni di telespettatori, terrorizzati prima di salire sul palco che tutto andasse a rotoli, improvvisamente abbastanza tranquilli da scherzare sui loro pezzi acustici e a scroccarsi cicchini come se fossero in uno scantinato, intorno a una creatura che sì, forse è già più morta che viva, e che però forse proprio per questo è capace di farci sentire l’odore dell’immenso.
Ed eccomi qua, trent’anni esatti più tardi, a risentire, riosservare per l’ennesima volta Come As You Are, Polly, i brani appena usciti di In Utero, i tre dei Meat Puppets, Dumb, Something In The Way, quell’incredibile Oh me che ogni volta mi fa venire le lacrime agli occhi e in cui ritengo che sia nascosto il dramma di Kurt, fino al finale, ruvido, quasi stonato grido di Where Did You Sleep Last Night. E non posso fare a meno di notare che non sto soltanto ascoltando un disco, osservando un concerto, che forse non ho mai soltanto ascoltato un disco o osservato un concerto: mi incaponisco a frugare in cosa ci sia nella dolce asprezza di quella voce, di quelle parole, di quella musica, di quel maglioncino verde, di quelle sigarette, di quelle accelerazioni e quei silenzi, che mi fa vibrare così tanto. Anche cosa vibra nel ricordo di me che imparo una delle sue canzoni.
Trattandosi di tempi andati la prima impressione è che si tratti di nostalgia. C’è d’altronde sentimento più diffuso? Eppure la nostalgia è il sintomo della distanza, dell’assenza. E qui invece è tutto così vivo, così presente. Se c’è lì in mezzo un malessere, non è un senso di vuoto, ma un accenno di mal di mare. È come se quel disco fosse una crepa nella crosta dell’esistenza, nella serie di strati che abbiamo solidificato giorno dopo giorno, anno dopo anno, secolo dopo secolo, nell’illusione di proteggerci. Quanto impegno, quante energie, quanto denaro abbiamo speso noi umani per ispessire quella crosta. Adesso non posso fare a meno di domandarmi se è stato un modo per procedere, o se abbiamo fatto casino. Forse è questo che ha ucciso Kurt, forse è questo il suo sacrificio: la resistenza a solidificare quella crosta, la condanna a sentirsi – forse a volersi sentire – sempre esposto. Magma, carne viva, bruciore, infezioni. Chissà se è possibile sopravvivere così, chissà se io stesso sarei sopravvissuto così.
Eppure riosservo il concerto, riosservo il ricordo di me, getto uno sguardo a ciò che ho accumulato, alle mie scartoffie, ai miei figli, ai miei grattacapi, a tutti gli orpelli di cui una buona parte di noi ha riempito la propria vita, e non vorrei fare altro che fissare quella versione di me negli occhi, e Kurt, e domandare se sono fieri di ciò che sono diventato. Ciò che in fin dei conti da trent’anni mi domando, consapevolmente o meno, è se si può vivere così, con niente indosso; se tutto ciò che abbiamo costruito è un successo o una sconfitta.