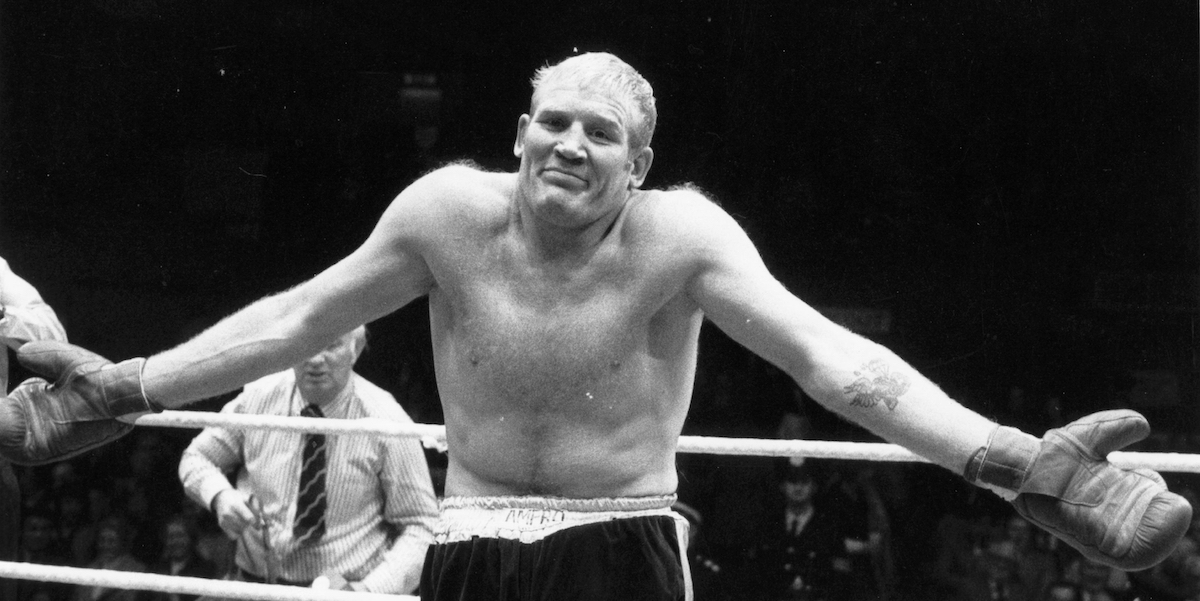Una costellazione / 2
«Mangiamo un falafel, passiamo davanti al Rote Flora, torme di ragazzini con skateboard ci ronzano accanto, scendiamo verso St. Pauli e visitiamo il Jüdischer Friedhof Altona — le tombe ashkenazite spiccano in un sottobosco un po' selvatico, privo di cure; quelle sefardite giacciono orizzontali coperte di una lievissima patina verdastra — e io continuo a rimuginare»

Giunto a questo punto della lista ho un attimo di trasalimento: la mano sconosciuta intendeva il filosofo o il pittore? C’è un piccolo spazio bianco dopo Montaigne, mentre manca fra Bacon e il nome successivo — “Bosh”, un evidente errore per “Bosch”, Hyeronimus, l’artista fiammingo. Più avanti nella lettura, a pagina 215, scoprirò che la mano ha di nuovo scritto “Bacon” di fianco a un passaggio dove si parla di carni squartate: dunque non ci sono dubbi.
5. Bacon
A Stoccolma, dove scrivo queste righe su un blocco note, c’è una sua opera al Moderna Museet: un’ulteriore perfetta coincidenza — se non fosse che Double Portrait of Lucian Freud and Frank Auerbach si trova in una sala al momento chiusa. Lo spio per qualche istante attraverso il vetro, ma non c’è modo di contemplarla realmente: la sua forza primitiva, la “brutalità del fatto” che voleva ritrarre, è depotenziata dalla distanza.
Mi consolo con l’apparente delicatezza morandiana della Sommaren 1970 di Nordström frantumata dall’elicottero di guerra che spunta lassù a sinistra, monito quanto mai attuale; o cercando d’istinto collegamenti in Cluster III — Death, so adjustable di Rosemarie Trockel, un collage di fotografie dei soggetti più diversi, all’apparenza e forse anche in sostanza prive di connessione.
6. Bosh
Un’ulteriore conferma: a pagina 174 la mano ha scritto di nuovo “Bosh”, anzi “J. Bosh”, per commentare un paesaggio dipinto dal protagonista di Gelo. A Gent, dove mi sono recato dopo Stoccolma e Copenhagen e Amburgo e Bruxelles, è conservato uno dei miei quadri preferiti — appunto l’Andata al Calvario del fiammingo. A dire il vero la paternità è dibattuta con buoni argomenti, ma poco importa.
Da ateo, questa tela mi ha ossessionato a lungo; la solitudine di Cristo, direi quasi la sua miseria e impotenza, sono evidenti. Rileggere il vangelo da questo punto di vista provoca una strana inquietudine: nonostante la comunità dei dodici, nonostante l’amore di Maria e l’esultanza delle folle, Gesù appare molto spesso discosto, incompreso, a volte stanco e persino insofferente. Il rimprovero mosso agli apostoli dormienti in Marco 14,37 (“Tornato indietro, li trovò addormentati e disse a Pietro: Simone, dormi? Non sei riuscito a vegliare un’ora sola?”) conserva un tratto di profonda delusione che non è tra le caratteristiche minori del Messia. Egli conosceva bene gli esseri umani: per quanto le sue richieste di perfezione morale fossero talora esorbitanti, non sembra farsi molte illusioni sulla gente.
Ora l’energia espressionistica, quasi grosziana della tela di Bosch fa proprio emergere tale lato feroce, indifferente o vile dell’umanità: la rassegnazione di Gesù colpisce più della dignità che si suole attribuirgli, in mezzo alla calca di grugni che lo sommerge, orribilmente e festosamente. Più ancora che le espressioni dei singoli visi è l’atto stesso di assieparsi a risultare insopportabile: la totale assenza di luce e sfondo, la violenza dei corpi che fremono in vista del supplizio. Come scrive Giovanni nel grandioso incipit del suo vangelo, “Egli era nel mondo, / e il mondo fu fatto per mezzo di lui, / eppure il mondo non lo riconobbe”: e non vi è quadro che rappresenti meglio tale completo fraintendimento del mistero di Gesù.
E anche il sorriso quasi sfrontato di Veronica che sorregge la Sindone, certa della vittoria finale, non placa il senso di disagio che provoca lo sguardo fissato sul velo stesso: Cristo lì ci fissa severo, penetrante, umanissimo, privo di gloria — come a suggerire che il suo sacrificio non è servito a nulla.
7. Poesia!
Il punto esclamativo mi intimorisce. Di ritorno a Milano ho compulsato dubbioso i tre scaffali della mia libreria dedicati alla poesia, e non ho saputo decidermi. Alla fine ho ritrovato il libro di una poeta che non contiene versi bensì lettere — una selezione dell’epistolario di Alejandra Pizarnik, L’altra voce. Ho scoperto questa scrittrice durante un altro viaggio, anni fa, nella sua Argentina: in una di quelle librerie che affollano calle Corrientes a Buenos Aires, città che ho amato come poche altre.
Pizarnik era una figura straordinaria, benché purtroppo poco nota: cosmopolita, in dialogo con scrittori come Cortázar, Cristina Campo e Starobinski, morì suicida a trentasei anni, inghiottendo cinquanta capsule di sodio seconale, il 25 settembre 1972. Più di cinquant’anni fa, realizzo: un’altra coincidenza.
Ed ecco cosa scrive al critico e saggista Rafael Squirru, il 20 febbraio 1970:
“Mi piace il linguaggio esatto, le mot juste, le cose corrette, terribilmente visibili che si sollevano come si sollevano dalla pagina le lettere della poesia di Quevedo che ho appena finito di leggere. Ergo: ci penserò più accuratamente quando saprò il cosa, il come, la modalità, il quanto, il fono a dove, ecc., ecc. Il sogno, sì, ma dotato delle qualità del teorema. La metafora, sì, ma esatta: che non sia possibile modificare un “questo” e renderlo uguale a un ‘quello’ — ma formularlo come chi alza nell’oscurità una mano stretta ad un pugnale”.
Quando spiego ai miei allievi che immagini consunte quali “erba come smeraldo” o “notte nera come la pece” non arricchiscono affatto il testo bensì lo spingono ancora più a fondo nella grama terra del luogo comune, penso proprio a quanto scrive Pizarnik.

Il centro sociale Rote Flora di Amburgo (Tania Madaschi)
8. Joyce?
Il primo dubbio della lista. Decido volentieri di accoglierlo: niente Joyce. Non mi va. Mentre gironzolo per il quartiere di Schanzenviertel, ad Amburgo, e mia moglie si dedica alla fotografia, mi arrovello con chi sostituirlo. Nessuna idea, e peggio ancora nessuna intuizione né doni della sorte.
Mangiamo un falafel, passiamo davanti al Rote Flora, torme di ragazzini con skateboard ci ronzano accanto, scendiamo verso St. Pauli, evitiamo la desolazione domenicale della Reeperbhan, visitiamo il Jüdischer Friedhof Altona — le tombe ashkenazite spiccano in un sottobosco un po’ selvatico, privo di cure; quelle sefardite giacciono orizzontali coperte di una lievissima patina verdastra — e io continuo a rimuginare. Alla fine, infastidito, mi arrendo.
Ma qualche giorno dopo il rientro torno nella biblioteca di quartiere a prendere Il segreto nella Parola di Frank Kermode (non ho ancora restituito Gelo) perché l’ho visto citato in un altro saggio e mi ha incuriosito: con una certa emozione scopro subito la sua attinenza alla mia costellazione; e con ulteriore sorpresa noto che il terzo capitolo del libro parla dell’Ulisse.
Kermode discute dell’enigmatico uomo col MacIntosh, un personaggio il cui ruolo nel romanzo è tutt’altro che chiaro; e si domanda, in particolare, perché preferiamo interpretare. Perché vogliamo risolvere a tutti i costi l’enigma in luogo, come peraltro è plausibile, di ritenerlo un apporto gratuito al testo. Dietro MacIntosh non c’è nulla: al più, le sue apparizioni mimerebbero gli eventi casuali della vita reale. Ma noi pretendiamo cocciutamente che vi sia comunque un senso, in un testo costruito con lo scopo di averlo, e peggio ancora lo pretendiamo anche nella vita stessa: l’idea stessa di coincidenza, il manto di suggestione che la ricopre, è implicita in questo istinto: la gratuità assoluta del mondo meccanicistico ci terrorizza. È un abisso dove ogni particella si muove priva di fini.
La presenza di MacIntosh. Il collage di Rosemary Trockel. Questo stesso percorso. Tutte le letture di tali fatti condividono un bisogno che, a conti fatti, è anche un’ansia — non dissimile da quella avvertita così bene da Pascal. Per farvi fronte le nostre interpretazioni proliferano e a volte aggrediscono il cosmo inutilmente, scambiando il suo silenzio per un’allegoria.
9. Kafka?
Resto sul Segreto nella Parola e torno indietro di qualche pagina. In un punto decisivo, Kermode paragona le parabole kafkiane alle parabole evangeliche narrate da Marco, che sembrano avere lo scopo precipuo di lasciare fuori il lettore non iniziato dal vero senso del testo — proprio come la storia del contadino davanti alla porta della Legge nel Processo.
La storia delle esegesi di questo brano è anche una storia di disperazione, perché cerca di rifuggire l’ipotesi più allarmante e a suo modo plausibile: la pagina non è realmente interpretabile. E se fosse allora un gesto esso stesso di ribellione? La dimostrazione che la Legge è esercitata casualmente, sulla base del capriccio, come il signore che negli Aforismi di Zürau passa davanti alla cella e senza alcuna ragione libera il prigioniero? (Un atto di grazia quasi più inquietante della condanna).
Stando alle sue memorie, il dadaista Raoul Hausmann incontrò Kafka a Berlino nel 1923. Durante una conversazione, lo scrittore gli disse: “forse l’uomo è il prigioniero di una casa paterna. Io ho visto questa cosa e mi sono ribellato al Golem, all’uomo nero, all’eterno erede delle antiche leggi”.
Occorre prendere sempre con una certa diffidenza questi resoconti, ma diamo per buona la versione. Al padre Kafka si ribellò a modo suo — scrivendo senza spedire una lettera fin troppo nota: e già questo dice molto della qualità finzionale della ribellione. Del resto ne cercò anche l’approvazione e l’amore, incapace di strappare il legame con il Golem; e alla sua legge si sottopose comunque fin quasi alla fine dei suoi giorni, pur non traendone la linfa vitale che da essa sgorgava — l’appartenenza a una Heimat — né riuscendo a diventare padre egli stesso.
Allora, forse, parte del singolare ebraismo di Kafka consiste in ciò: egli non possedeva una Terra promessa dove ritornare, ma innanzitutto di un luogo da cui essere bandito, e che lo bandiva nel deserto della scrittura. Concentrò tutte le sue forze per creare un altro mondo, non meno crudo, non meno terribile: ma il gesto stesso della creazione gli offrì una garanzia di rinascita. La sua Terra promessa era la letteratura: non il regno del Padre, ma finalmente il libero regno del Figlio.

Jüdische Friedhof Altona, Amburgo. (Giorgio Fontana)
10. Durrenmatt?
Un altro dubbio. Che fare? Rifiuto e mi prendo una libertà. Quando pesco questo nome dalla lista — senza dieresi nella versione della mano sconosciuta — sono ancora in Svezia: è la patria di un altro scrittore che amo molto e considero uno dei più grandi del Novecento, Stig Dagerman. Anche lui comincia per D: giustificazione ai limiti del ridicolo, ma una nuova coincidenza mi conforta: al Kafe 44, un bellissimo locale anarchico di Södermalm, fra un involtino vegano e una lattina di birra, trovo il numero celebrativo di Arbetaren — la rivista di cui Dagerman fu redattore — con una sua foto in quarta di copertina. (Tornerò l’indomani ad acquistarla, trovando la libreria del locale chiusa; ma loro saranno così gentili da spedirmela a casa).
Quando divenne, molto giovane, uno scrittore famoso, per Dagerman iniziarono grossi problemi. Il successo, che pure apprezzava, rischiava di trascinarlo lontano dalle origini e dal compito altissimo che si era prefisso — è raro trovare uno scrittore più dedito alla causa della letteratura in quanto tale. Il suo talento non bastava a se stesso.
Ora il tema essenziale di Dagerman, come ha sottolineato la sua studiosa Lotta Lotass, è la libertà. Militante anarchico egli stesso, Dagerman scrisse di sperare in una letteratura che combattesse per “la libertà, la fuga e il tradimento”. Ma la libertà e l’odio per il potere implicano una sovra-esposizione alle bruttezze del mondo, al cinismo e alla brutalità del mondo adulto: così il ragazzo protagonista di Ho remato per un lord, così il Bengt “bambino bruciato” dell’omonimo romanzo. E scrivere significa porre in termini radicali la giustificazione dell’opera artistica in un mondo offeso: come ritenere la letteratura un bene essenziale, se si è anche impegnati a rimuovere le cause della sofferenza umana?
Tale conflitto è irrisolvibile, e Dagerman stesso non seppe venirne a capo. Così, la mattina del 5 novembre 1954 si recò alla redazione di Arbetaren per consegnare la sua rubrica quotidiana (la numero 2067, che potete trovare in Breve è la vita di tutto quel che arde). Sono versi satirici sull’indignazione dei benpensanti verso i poveri che vivono di sussidi e mantengono pure un cane: Dagerman suggeriva ironicamente di abbattere gli animali, e quindi anche i poveri, affinché il Comune risparmi. Poi tornò a casa, si chiuse nel garage, accese l’automobile e si uccise con il fumo del tubo di scappamento.
11. Dost (??)
Due punti di domanda addirittura, benché fra parentesi. Decido, stavolta a malincuore, di seguire tale perplessità; e scelgo la testimonianza di un’altra scrittrice russa, una vittima del Novecento che al Novecento reagì con un libro fondamentale: Nadežda Mandel’štam, la vedova del poeta.
Ci sono tanti momenti straordinari nell’Epoca e i lupi (di recente ripubblicato con il titolo originale Speranza contro speranza): la telefonata di Pasternàk a Stalin, la descrizione del terrore quotidiano e della continua disponibilità al compromesso pur di sopravvivere, la totale ignoranza della realtà da parte dei burocrati, la frase di Mandel’štam “Solo da noi hanno rispetto per la poesia, visto che uccidono in suo nome. In nessun altro paese uccidono per motivi poetici”, la fila di donne in attesa di parlare allo sportello della prigione dove sono reclusi i figli e così via.
Io scelgo solo una piccola frase, apparentemente minore, che la scrittrice riferisce a proposito del marito e di Anna Achmatova: “La nostra epoca aveva fatto di tutto per impedire loro di ridere, ma era difficile rieducarli, quei due”.
Mentre annoto queste righe è un tardo pomeriggio a Copenhagen e la luce si frantuma in migliaia di schegge sopra le acque torbide dei canali.

Copenhagen (Tania Madaschi)
12. Proust
Sotto Gelo avevo Sodoma e Gomorra, e poi La prigioniera. Per il centenario della morte di Proust ho pensato di rileggere tutta la Recherche — non una celebrazione particolarmente originale, me ne rendo conto. Ci sarebbe fin troppo da dire, quindi mi limito a un’unica osservazione: fra le varie interpretazioni del concetto di “tempo perduto” vi è anche il tempo delle attività parassitarie tipiche della mondanità che Proust sa ritrarre così bene: il tempo delle chiacchiere, improduttivo, vacuo, volto semplicemente a riprodurre relazioni di meschinità e potere, senza contenuti, senza passione, senza verità — pura vita falsa che gode di se stessa, pura forma esteriore.
La decisione di sottrarsi a questo mondo per entrare in un cosmo privato, notturno, è l’avvento della riconquista del tempo; ma è interessante notare come Marcel ne trattenga i mezzi e le tecniche apprese: il pettegolezzo, l’arte di conoscere e rivelare, l’attenzione al dettaglio, e persino un certo cinismo che verrà tuttavia trasceso dall’agnizione conclusiva, nella celebre matinée Guermantes. Sarà l’arte a redimere il tempo perduto attraverso la creazione di un mondo intemporale, finalmente privo di falsità e belletti: felice utopia, ma che già all’epoca poteva apparire fuori tempo massimo. O forse lo è sempre stata.
13. Kerouac
La voce di Kerouac che declama l’incipit di un testo minore e bellissimo, Ottobre nella terra della ferrovia, sopra lo sfondo del pianoforte di Steve Allen, recitando in perfetto dialogo con la musica, musica la voce stessa: non c’è modo migliore per apprezzare la vera virtù di questa prosa, quando non è afflitta da malintesa spontaneità: non sono le avventure dei beat a contare quanto il paesaggio stesso che scorre al ritmo dell’automobile, la resa fluida e calda del mondo circostante attraverso una lingua che qui si fa pura prosodia bop.
Aveva ragione Paul Goodman — un altro nome su cui tornerò, un altro filo teso — a osservare che in Sulla strada l’intera azione è volta a evitare il conflitto interpersonale; i protagonisti sono molto più conformisti di quel che sembrano. Un po’ di distacco emotivo ci consente di valutare questo libro per quello che è, con tutti i suoi difetti: la voce di Kerouac che legge Ottobre testimonia un genere di grandezza diversa, quasi trascendentalista, che sa fondersi con l’immensa tradizione della musica afroamericana.
– Leggi anche: Una costellazione / 3
– Leggi anche: Una costellazione