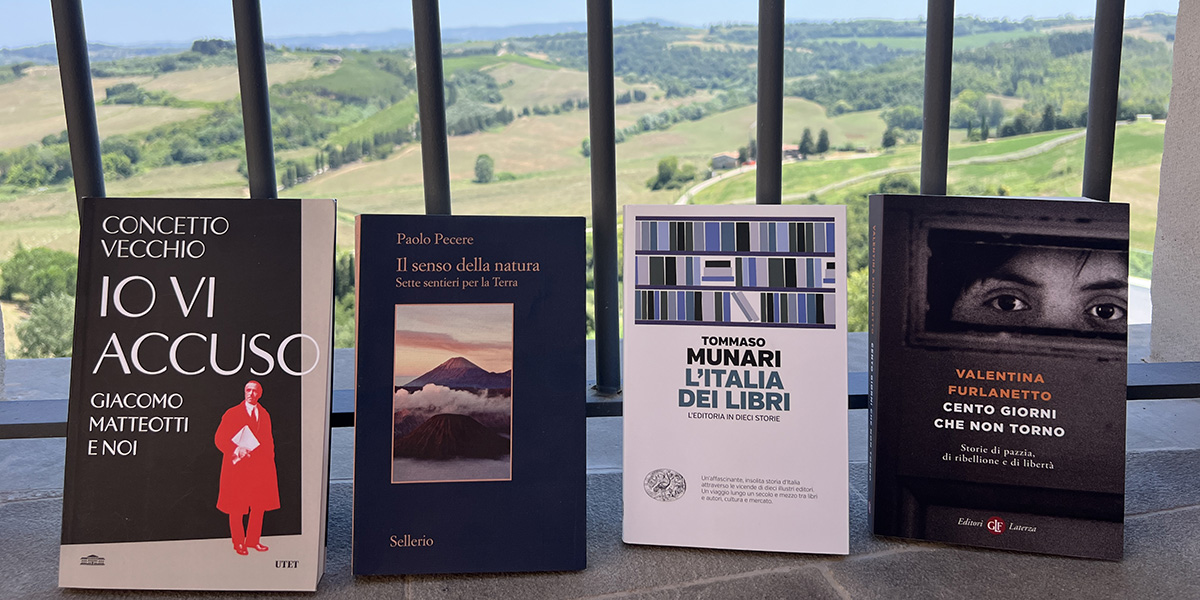«Due giornalisti italiani alla Cnn!»
Uno era Enrico Franceschini di Repubblica, che nel suo nuovo libro racconta l'imprevedibile scoop che ottenne in mezzo al golpe russo di Boris Eltsin del 1993

Come girare il mondo gratis è il nuovo libro di Enrico Franceschini, un’autobiografia professionale di un giornalista e dei suoi 45 anni da corrispondente in «tre continenti, cinque capitali, venti traslochi e mai il tempo di annoiarsi», come lui stesso racconta che avrebbe voluto intitolarla (troppo lungo, però). Franceschini ha 66 anni, è da poco in pensione ma continua a collaborare assiduamente con Repubblica – per cui ha lavorato per quasi tutto il periodo raccontato nel libro – da Londra dove è rimasto a vivere dopo che era stata la sua ultima sede da corrispondente. Il libro è una ricca e densa successione di episodi, incontri, personaggi e successi giornalistici mediati da una costante modestia. Persino quando con un collega ottengono uno scoop internazionale, in mezzo ai tumulti seguiti alla fine dell’Unione Sovietica, come racconta a un certo punto.
***
Il caos che ha sconvolto tutte le Russie negli ultimi due anni di Gorbaciov continua negli anni di Eltsin. I russi scoprono che la democrazia non si mangia. Crescono le diseguaglianze. I salari non arrivano. Oligarchi corrotti accumulano fortune miliardarie con manciate di milioni presi in prestito. È il risultato della privatizzazione selvaggia, ordinata da Eltsin per impedire il ritorno del comunismo: bisogna costruire in fretta il capitalismo, dice il presidente russo. Passerà alla storia come il furto del secolo, sebbene nemmeno la nascita del capitalismo americano fosse stata un pranzo di gala.
Aleksandr Solgenitsyn, il grande scrittore russo a lungo in esilio in America, autore di Arcipelago Gulag, il più impressionante atto d’accusa contro il comunismo sovietico, rientrato in patria diventa presto disilluso sul nuovo sistema: i suoi libri ora possono essere pubblicati senza censure, ma nessuno li compra, la gente preferisce i gialli americani. «La mia anima era in Russia anche quando vivevo in America e non sono pentito di essere tornato», mi dice in un’intervista, «ma il nostro Paese ha perso la testa.»
Due anni dopo, gli irriducibili del comunismo provano a fermare le lancette della storia, con un golpe contro Eltsin. Rivoltosi in armi occupano la stazione centrale televisiva, trasmettono proclami, esortano il popolo a sostenerli: ma il popolo non sembra interessato ad altre battaglie, gli sono bastate quelle del ’91. L’idealismo degli anni della perestrojka è stato sostituito dalla secolare diffidenza e sfiducia dei russi. La politica non interessa più: né a favore né contro nessuno. I ribelli si asserragliano nella Bielij Dom, la Casa Bianca, com’è chiamata la sede del Parlamento in riva alla Moscova, il fiume che attraversa la capitale. Eltsin risponde facendo circondare il palazzo dai carri armati: i rivoltosi non si arrendono, il presidente ordina di aprire il fuoco. Le cannonate bucherellano la facciata candida del Parlamento come se fosse formaggio groviera. Intorno all’edificio, le barricate dell’esercito fedele a Eltsin: i golpisti sono accerchiati, chiaramente non hanno scampo. È un assedio alla russa, confusionario, poco marziale: ci sono anche civili curiosi sulle barricate.
E ci sono anche i corrispondenti stranieri, compresi il mio amico Paolo del «Corriere» e io, che abbiamo entrambi la redazione a due passi. Durante una pausa nel cannoneggiamento, una donnina che pare uscita da un romanzo di Bulgakov mette il naso fuori dalla Casa Bianca assediata, raggiunge la barricata dietro cui siamo nascosti noi e afferma: «I capi dei ribelli vogliono parlare con dei giornalisti stranieri! Hanno un’importante comunicazione da fare. Venite con me». Fossi matto, penso io. Ma Paolo, che fra le sue tante doti è anche di un coraggio temerario, mi strizza l’occhiolino, scavalca la barricata e segue la donna misteriosa. Vedo aprirsi davanti a me due scelte e due destini differenti: seguire Paolo, e probabilmente non tornare più indietro; oppure restare dove sono e sperare di vivere fino a una serena vecchiaia. Penso che l’offerta della misteriosa emissaria dei ribelli sia sicuramente una trappola. E se anche non lo fosse, tra poco riprenderanno le cannonate, finiremo ammazzati insieme ai ribelli.
Ancora più delle cannonate, tuttavia, mi terrorizza un’altra cosa: la reazione del mio direttore, Eugenio Scalfari, se il giorno dopo sul «Corriere» fosse uscita l’intervista con i capi della rivolta e su «Repubblica» niente. Scalfari mi aveva telefonato poche ore prima: «Devi raccontare l’attacco al Parlamento ribelle come Indro Montanelli raccontò l’attacco dei carri armati sovietici a Budapest nel 1956 guardandolo dal tetto della casa di fronte». I carri sovietici del ’56 erano i cattivi, quelli della Mosca del 1993 sono i buoni, se si può essere buoni a prendere a cannonate il prossimo. Ma questo era un dettaglio. Così come era un dettaglio il fatto che, secondo i vecchi del mestiere, Montanelli non aveva affatto visto con i propri occhi le cannonate dal tetto di una casa di Budapest, al massimo ne aveva sentito il rimbombo da una strada della città: ma le aveva raccontate così bene da passare lo stesso alla storia del giornalismo, perlomeno quello italico.
Come che sia, è chiaro che il mio direttore vuole un grande pezzo su questa storia. E io ho l’occasione di scriverlo. Non posso tirarmi indietro. Tutti questi ragionamenti impiegano un nanosecondo ad attraversarmi la mente ed eccomi su per le scale di un palazzo incendiato, affumicato, cosparso di cadaveri, dietro Paolo e la latrice del messaggio. All’ultimo piano incontriamo i capi dei ribelli, Andrej Rutskoj, ex generale dei parà, in tuta mimetica e mitra a tracolla, il vicepresidente russo che ha tradito Eltsin, e Ruslan Khasbulatov, in abiti civili, il presidente del Parlamento. Sono entrambi di un pallore mortale. Rutskoj fuma nervosamente una Marlboro dietro l’altra. «Siamo pronti alla resa, ma soltanto nelle mani di una delegazione di ambasciatori stranieri», ci dice. «Se ci arrendiamo ai soldati di Eltsin, ci spareranno appena alziamo le braccia.» Sopraggiunge un terzo giornalista, il corrispondente di una tivù francese, con il suo cameraman, che filma la scena. Miracolosamente, la pausa nelle cannonate continua. Faccio fretta a Paolo: non è il caso di abusare ulteriormente della fortuna. Lui se la prende calma, ancora qualche domanda, ma alla fine riesco a spingerlo giù per le scale, fuori dal palazzo, in salvo.
Ci guardiamo negli occhi: abbiamo uno scoop mondiale. Ma ben presto ci rendiamo conto di avere due problemi. Il primo è che gli altri corrispondenti non ci credono. Si sparge la voce e nessuno è convinto che due italiani abbiano potuto compiere un’impresa simile. Non hanno tutti i torti: nella categoria delle invenzioni giornalistiche, gli italiani primeggiano. Il cameraman della tivù francese ci ha promesso una copia del suo filmato, che sarebbe la prova inoppugnabile del nostro scoop, ma adesso è al lavoro nel suo ufficio e non può occuparsi di noi. Il secondo problema è che non ci credono, non tanto almeno, neppure i nostri colleghi a Milano e a Roma.
Sia Paolo al «Corriere» che io a «Repubblica», quando comunichiamo per telefono che abbiamo intervistato i capi della rivolta, otteniamo la stessa, scettica reazione: «Va bene, bravo, okay, adesso però non perdere altro tempo, scrivi un grande racconto sulla giornata». Sì, ma l’intervista con i ribelli? «Mettila dentro al pezzo.» Ma no, dai, non è possibile, rispondiamo, è uno scoop mondiale! «Insomma, ragazzo, non fare i capricci, se proprio insisti vedremo di ricavare un boxino a parte per l’intervista, adesso mettiti a lavorare.» Cosa che ci accingiamo a fare, sconsolati, quando Alessio Vinci, siciliano come Paolo e suo caro amico, giovane producer alla Cnn, riferisce il nostro scoop ai suoi superiori che ci invitano immediatamente a essere intervistati in diretta.
La Cnn trasmette dal tetto di un palazzo con vista sulla Casa Bianca in fiamme: più o meno, vedi la coincidenza, la prospettiva che il mio direttore avrebbe voluto per emulare il racconto di Montanelli su Budapest 1956. Non avendo una linea diretta con Mosca, la Rai ritrasmette le immagini della Cnn, con i sottotitoli in italiano. Succede così che a Roma e Milano a un tratto i nostri colleghi vedono me e Paolo intervistati dalla Cnn, a cui raccontiamo la sostanza dell’intervista, la situazione all’interno della Casa Bianca su cui intanto sono riprese la cannonate e la richiesta di aiuto dei rivoltosi agli ambasciatori stranieri, il tutto sottotitolato in italiano.
Facciamo appena in tempo a tornare ciascuno nel suo ufficio, che i telefoni squillano all’unisono sulle nostre scrivanie: che dico squillano, saltano sospinti da vita propria, come in certi cartoni animati. All’altro capo del filo ascoltiamo il medesimo discorso: «Formidabile scoop! Scrivi quanto vuoi. Racconta tutto per filo e per segno. Pezzo che parte dalla prima pagina, ovviamente». Da Washington mi telefona Zucconi, che ha visto anche lui la nostra apparizione alla Cnn, per congratularsi. E per pronunciare, essendo Vittorio, l’immancabile «Zucconism of the day», la battuta del giorno: «Sembravate il principe e il povero, Paolo il principe naturalmente e tu il povero». Spiritosaggine appropriata, come sempre con il grande Vic, perché Paolo ha mantenuto la sua eleganza anche nella Casa Bianca in fiamme, mentre io sono vestito con la mia solita uniforme sgualcita, blazer blu dai gomiti lisi, camicia azzurra con i bottoncini al colletto non stirata e jeans slavati.
Per farla breve: i nostri pezzi vengono pubblicati in prima pagina, il mio viene anche tradotto e pubblicato sulla prima pagina dell’«Independent», quotidiano britannico in quel momento gemellato a «Repubblica». E dopo qualche mese vinciamo insieme il Premiolino, ambito riconoscimento giornalistico italiano, in una serata d’onore al Circolo della stampa di Milano, in cui finisco seduto a tavola accanto a uno dei giurati, il leggendario Giorgio Bocca contro cui ero andato a sbattere, mortificato dall’imbarazzo, una decina d’anni prima nei corridoi dell’«Espresso» a Roma.
Anche questa è una salutare lezione: siamo perfettamente consapevoli, Paolo e io, di avere meritato la prima pagina, i complimenti dei rispettivi giornali e il Premiolino, non tanto per avere rischiato la vita entrando nel Parlamento dei golpisti sotto le cannonate, bensì per esserci fatti intervistare dalla Cnn. «Due giornalisti italiani alla Cnn!», è questa la notizia che circola di bocca in bocca nel nostro Paese per riassumere l’accaduto. In una nazione di irrimediabili provinciali, niente vale di più che apparire alla tivù americana.
© 2022 Baldini+Castoldi s.r.l. – Milano