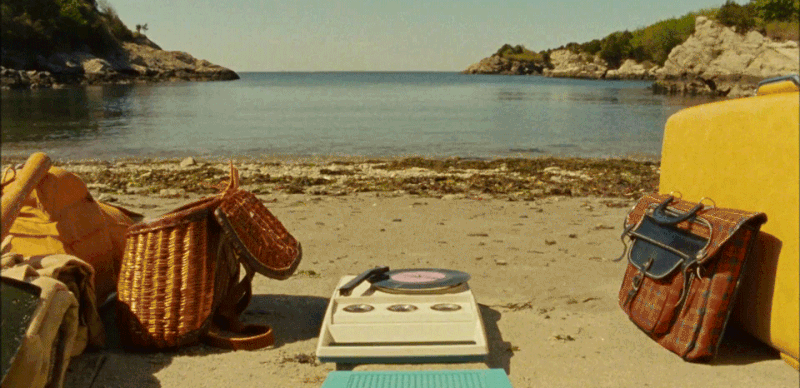Una settimana lavorativa di 4 giorni?
Periodicamente si ritorna a parlare della "settimana corta", tra pro e contro: ora vuole introdurla Unilever in Nuova Zelanda, mentre il governo spagnolo ci sta pensando

Il governo spagnolo del primo ministro socialista Pedro Sánchez e della ministra del Lavoro Yolanda Díaz ha annunciato che prenderà in considerazione l’idea di ridurre la settimana lavorativa a 4 giorni (e 32 ore), a parità di salario. La possibilità di una riduzione era stata citata lo scorso maggio, ma senza molti dettagli, anche dalla prima ministra neozelandese Jacinda Ardern, con l’obiettivo di rilanciare il turismo e l’economia colpiti dall’emergenza sanitaria. A fine novembre, poi, la società Unilever ha annunciato di voler introdurre la settimana di quattro giorni lavorativi nelle sue sedi in Nuova Zelanda, a stipendio pieno.
In molti paesi si discute da tempo sull’opportunità di rivedere il tempo di lavoro: mentre modalità lavorative e impieghi sono cambiati sensibilmente negli ultimi anni, le ore da lavorare sono rimaste pressoché identiche. Ma il confronto politico e sindacale per ora non ha portato a cambiamenti significativi, anche in Italia. Alcune aziende stanno sperimentando soluzioni che vanno in questa direzione, nel mondo: ma un conto è ridurre l’orario in una singola azienda o in un singolo settore, un altro è farlo attraverso delle leggi a livello nazionale.
Qualche dato, intanto
Nel 2018 l’ILO, organizzazione internazionale del lavoro delle Nazioni Unite, ha calcolato che il 31,6 per cento delle persone nel mondo lavora oltre 48 ore settimanali, mentre la crescita degli stipendi è diminuita.
Nel 2019 l’OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) ha pubblicato uno studio sulle ore di impiego dei lavoratori dei suoi paesi membri. Nella zona euro l’Italia è il paese dove si lavorano in media più ore alla settimana, dopo Grecia ed Estonia: 33 ore, 3 in più rispetto alla media di 30 ore. In Germania le ore settimanali medie sono 26, nei Paesi Bassi sono 28, in Lussemburgo, Austria e Francia sono 29. In Belgio e Finlandia sono 30. Al di là della quantità, però, l’Italia è in bassa posizione nella classifica che misura la crescita dei livelli di produttività, calcolata tra il 2010 e il 2016 (la produttività è intesa come PIL per ora lavorata). Secondo Eurostat, l’ufficio statistico dell’Unione Europea, la produttività del lavoro è diminuita dello 0,3 per cento nel 2018 e gli stipendi sono al di sotto della media OCSE, con il livello più basso tra i paesi considerati “avanzati”. La Germania, dove si lavora meno, è invece tra i paesi migliori nella classifica della produttività.
Qualche mese fa sul Sole 24 Ore il ricercatore Andrea Garnero aveva spiegato che lavorare tanto non corrisponde a maggiore ricchezza: «Se mettiamo sotto la lente i paesi OCSE, più una nazione è ricca, minori sono le ore di lavoro (…). La causa di tutto è la produttività». Cioè quanto si produce, effettivamente, nelle ore impiegate a lavorare.
Un po’ di storia
All’inizio del 1800, quando l’orario di lavoro poteva arrivare a 16 ore al giorno per sei giorni a settimana, l’industriale e filantropo gallese Robert Owen, sostenuto dai primi sindacalisti, coniò il motto “otto ore di lavoro, otto ore di svago, otto ore di sonno”, ma ci volle più di un secolo perché le sue idee diventassero la base della legislazione del lavoro in Europa e in Nord America. In Italia, le “8 ore” giornaliere (e le 48 settimanali) vennero introdotte nel 1922, durante i primi mesi del governo Mussolini, come conseguenza di una proposta precedente del Partito Socialista. Ma la lotta era già stata portata avanti dalle mondine, nel 1909:
Se otto ore son troppo poche, provate voi a lavorare. E sentirete la differenza di lavorar e di comandar
Le tendenze storiche globali in materia di orario di lavoro mostrano una riduzione graduale, ma la ragione di questa riduzione, piuttosto che essere motivata da una riflessione sull’opportunità di modificare il bilanciamento tra vita privata, salute e lavoro, ha più a che fare con la capacità contrattuale dei sindacati, con la crescita di forme di flessibilità e con l’aumento complessivo della percentuale di persone che lavorano part-time (e che sono per lo più lavoratrici). Oppure con sperimentazioni avviate a livello aziendale.
Tra gli esempi più recenti c’è quello di Unilever, società olandese-britannica titolare di 400 marchi tra i più diffusi nel campo dell’alimentazione, bevande, prodotti per l’igiene e per la casa, che ha avviato un esperimento in Nuova Zelanda: consentirà ai suoi 81 dipendenti di lavorare per quattro giorni alla settimana per un anno intero pur continuando a essere pagati per cinque giorni. Al termine dell’esperimento Unilever, con la Business school dell’Università di tecnologia di Sidney, valuterà i risultati e di conseguenza la possibilità di un’attuazione diffusa della situazione. Uno dei manager di Unilever ha spiegato che il loro obiettivo «è misurare le performance, i risultati, non il tempo di lavoro».
Come ha ricordato il Sole 24 Ore in un suo recente articolo, il primo esperimento aziendale in questa direzione risale al 1993, quando Volkswagen, in accordo con il sindacato tedesco dei metalmeccanici IG Metall, decise il taglio obbligatorio del 20 per cento dell’orario da 36 a 28,8 ore settimanali in cambio di una riduzione salariale annuale del 16 per cento. E ci sono diverse altre aziende che negli anni hanno avviato progetti simili. La divisione giapponese di Microsoft in Giappone, riducendo la settimana lavorativa a quattro giorni, ha ottenuto di recente un notevole aumento della produttività, così come Perpetual Guardian, un fondo d’investimento della Nuova Zelanda.
Un esperimento di cui si parlò molto, qualche anno fa, fu quello di Göteborg, in Svezia, quando tra il 2015 e il 2017 le infermiere della casa di cura per anziani Svartedalens lavorarono per sei ore al giorno anziché otto, allo stesso salario. Le infermiere dichiararono che la qualità della loro vita era migliorata, la richiesta di permessi per malattia si abbassò, e i residenti della casa di cura dissero di aver ricevuto un servizio superiore. Dall’altra parte, però, il modello di sei ore venne giudicato non sostenibile sul piano economico, visto che l’assunzione di altre lavoratrici aveva alzato i costi del servizio.
Aziende e singoli casi a parte, ci sono diversi paesi che hanno introdotto, nel tempo, forme di flessibilità in materia di lavoro, e altri – sulla spinta dei sindacati – che hanno ipotizzato riforme più strutturali. Nel Regno Unito si parla da tempo della possibilità di ridurre a quattro giorni la settimana lavorativa, una proposta che è tornata attuale ultimamente per affrontare la crisi economica causata dal coronavirus. Lo scorso agosto il sindacato tedesco IG Metall, che rappresenta più di 2 milioni di lavoratori del settore metalmeccanico ed elettrico, aveva dichiarato di voler proporre l’introduzione della settimana di quattro giorni nei negoziati per il rinnovo dei contratti collettivi.
Il paese con una legislazione sul tempo pieno a 35 ore settimanali è la Francia. La riforma – che è sempre stata molto discussa e poi ha subito successive modifiche – venne introdotta in due fasi: nel 1998 con la legge Aubry I e nel 2000 con la legge Aubry II, che generalizzò per tutte le aziende una serie di agevolazioni fiscali, lasciò alle imprese stesse libertà di negoziare gli aspetti applicativi della riduzione e congelò i salari. Sull’esperienza francese, che complessivamente si calcola abbia portato alla creazione di 350 mila-500 mila posti di lavoro, ci sono diverse valutazioni: c’è chi attribuisce l’effetto positivo sull’occupazione alla riduzione dell’orario di lavoro e chi invece alla maggiore flessibilità e alla riduzione delle imposte; alcuni hanno sottolineato l’intensificazione del lavoro e che, a qualche anno dalla riforma, l’orario medio sia tornato a crescere con il ricorso agli straordinari, e il fatto che le 35 ore siano costate e continuino a costare moltissimo allo Stato. Sono state infatti finanziate attraverso una combinazione di agevolazioni fiscali, blocco dei salari e aumento dell’efficienza organizzativa, ma il grosso dell’onere è stato sostenuto dal governo, per via dei minori contributi sociali percepiti.
Dopo la proposta francese, la questione della riduzione dell’orario di lavoro è quasi completamente scomparsa dal dibattito politico, ma anche da quello pubblico in generale. In Italia l’ultima proposta concreta di riduzione dell’orario di lavoro a 35 ore la fece Rifondazione Comunista negli anni Novanta. Simone Fana, autore del saggio Tempo Rubato, ha spiegato il motivo del disinteresse verso questa rivendicazione: «Non è stato più un argomento perché sostanzialmente, per trent’anni, l’idea dominante è stata quella della produttività a tutti i costi. Bisognava lavorare di più per produrre di più, e questo ha ispirato tutte le politiche economiche del lavoro degli ultimi anni. La riduzione degli orari veniva vista come qualcosa che avrebbe ridotto la produttività e che avrebbe compromesso sostanzialmente la crescita. Non è stata considerata una politica efficace perché si è martellato costantemente sul fatto che lavorando di più il reddito da distribuire fosse più ampio, e fosse quindi più utile aumentare gli orari di lavoro piuttosto che ridurli». In questa prospettiva, la riduzione dell’orario di lavoro è stata associata alle crisi e all’esigenza di tagliare costi, piuttosto che alla sperimentazione di nuovi modi di lavorare.
Argomenti pro e contro
Nel 1933 Giovanni Agnelli scrisse a Luigi Einaudi, allora direttore della rivista La Riforma Sociale, sostenendo la formula del “lavorare meno, lavorare tutti” come rimedio contro la disoccupazione: «La riduzione proporzionale e generale delle ore di lavoro risolve il problema di distribuire il lavoro equamente fra tutti gli uomini, dando a tutti due ore addizionali di ozio».
Quello della creazione di posti di lavoro è però solo uno degli argomenti a favore della riduzione dei tempi del lavoro. Il principale ha a che fare con gli effetti sulla salute, ovvero con la riduzione della fatica e della probabilità di incidenti, e sulla qualità della vita, perché lavorare meno migliorerebbe l’equilibrio tra lavoro retribuito e vita privata. Ci sono vari studi che dimostrano questa correlazione. C’è poi chi sostiene che la riduzione dell’orario di lavoro migliorerebbe la parità di genere, perché aumenterebbe la partecipazione al lavoro delle donne, e porterebbe ad una suddivisione più bilanciata dei lavori domestici e di cura.
Un altro argomento a favore della riduzione dell’orario di lavoro ha a che fare con la creazione di un’economia sostenibile, che, almeno secondo alcuni, ha come presupposto la necessità di ridurre la crescita economica. Dall’altra parte c’è chi pensa che la riduzione potrebbe aumentare la produttività, con il rischio però che le giornate lavorative diventino più intense e stressanti.
Come ha spiegato in un documento del 2018 l’European Trade Union Institute, l’istituto sindacale europeo, «è evidente che non tutti gli argomenti sono compatibili tra loro. Aumentare la produttività con una riduzione dell’orario di lavoro non è compatibile con la volontà di costruire un’economia sostenibile o addirittura di ridistribuire l’occupazione. Un’attenzione alla parità di genere e la possibilità per le donne di lavorare di più attraverso una settimana lavorativa ridotta potrebbe essere in contrasto con l’obiettivo di andare verso una società meno incentrata sul lavoro». È quindi probabile, continua il documento, che gli effetti della riduzione dell’orario di lavoro siano molto diversi a seconda di chi la attua, dei motivi che ha per farlo e di come la realizza. E la modalità con cui si realizza la riduzione dell’orario di lavoro potrebbe essere un fattore più rilevante della riduzione stessa.
A seconda dell’approccio, insomma, gli effetti su parità di genere, aumento dell’occupazione, crescita sostenibile, diritti dei lavoratori possono differire notevolmente. Le domande sono tante e aperte: di quanto ridurre l’orario di lavoro? L’introduzione dovrebbe essere graduale o radicale, temporanea o definitiva? Calcolata sulla giornata o sulla settimana o sulla vita lavorativa in generale? I costi della riduzione dell’orario di lavoro dovrebbero ricadere sui lavoratori, sui datori di lavoro o sui governi? E ancora: si dovrebbe partire dalla legislazione nazionale o dagli accordi aziendali?
Marta Fana, ricercatrice in economia e autrice di diversi libri, dice di essere «sicuramente a favore di una riduzione del tempo del lavoro: se però avviene a parità di salario». Ma questa precondizione, spiega, «nel caso specifico dell’Italia pone almeno due grandi problemi: la parità di salario, in un contesto in cui i salari sono già molto bassi, si tradurrebbe nell’incentivo a cercare un secondo lavoro per arrivare a una soglia consona di reddito mensile da lavoro; inoltre si rischierebbe di arrivare a una polarizzazione. Da una parte ci sarebbero settori dove ci si può permettere di lavorare meno perché i salari sono alti, ma sarebbero piccole nicchie; dall’altra ci sarebbero intere filiere che non godrebbero di questo privilegio. Bisogna poi intendersi sul guadagno di produttività: non è solo quella calcolata su determinate mansioni o sul singolo lavoratore, ma è anche quella aggregata, dell’intera filiera». Senza insomma «un grande vincolo al tipo di contratto e alla questione salariale», per Fana la riduzione del tempo del lavoro «rischierebbe di essere controproducente». Fana fa poi notare che in realtà «la riduzione viene già attuata dalle imprese, attraverso il ricorso massiccio al part-time e al part-time involontario, che oggi sta esplodendo», ma senza garanzie.
Anche Daniele Checchi, economista del lavoro, pensa che ci sia una precondizione necessaria alla riduzione del tempo di lavoro: «È molto importante capire se ci si trova in un momento di crisi o di espansione. In questo secondo caso probabilmente si avrà anche un aumento dell’occupazione, mentre se la manovra venisse fatta durante una recessione l’effetto sul numero degli occupati non si verificherebbe. In tempo di crisi, come ad esempio durante una pandemia, per le aziende il problema è duplice: se non aumenta la domanda, ne risente anche la produzione, quindi le imprese non avranno necessità di aumentare i dipendenti. In questo caso, per assorbire le perdite occupazionali, la riduzione di orario non offrirebbe insomma alcun incentivo». Checchi precisa poi che dipende anche da come si fa, la riforma. «Se la riduzione oraria fosse a parità di salario si caricherebbero tutti i costi sull’impresa, in un momento già difficile. E se la riduzione dei tempi venisse accompagnata da una riduzione del salario, l’impresa sarebbe contenta ma il lavoratore no: lo lasceresti a casa ma non gli pagheresti più la cassa integrazione».
Checchi dice infine che la riforma potrebbe essere applicata solo ad alcuni settori, ma tende a pensare che non debba essere introdotta per legge: «Poi succede come in Francia dove dopo qualche anno dalla riduzione imposta per legge, l’orario medio effettivo è tornato di fatto a crescere con il ricorso agli straordinari e ad essere molto vicino a quello pre riforma. Se le persone non sono convinte di avere più tempo a disposizione per loro, faranno straordinari. Servirebbe, insomma, un lungo processo innanzitutto culturale perché questa possa diventare una manovra che porta benefici».