Quelli che scelgono le playlist che ascoltiamo
Lavorano a Spotify, Google Play Music e Apple Music e usano gusti e competenze – non solo algoritmi – per mettere insieme canzoni che stiano bene insieme
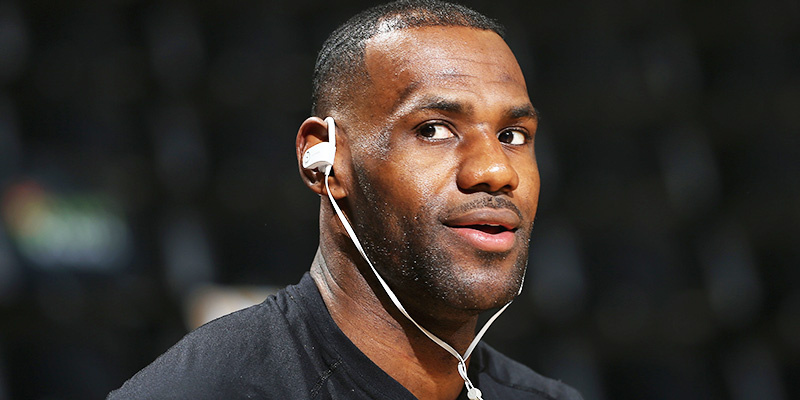
Da un po’ di tempo chi ascolta musica in streaming lo fa soprattutto grazie a tre servizi: Spotify, Apple Music e Google Play Music. Sono comodi, efficaci e gratuiti, se si scelgono le opzioni base, o comunque poco cari se si fanno degli abbonamenti che permettono di avere qualità migliore o nessuna pubblicità. Quando si ha accesso a tutta la musica del mondo il problema è filtrarla e selezionarla: è il motivo per cui i tre più importanti servizi per ascoltare musica in streaming offrono delle playlist già pronte. Alcune sono delle classifica delle canzoni più ascoltate in un certo periodo e in un certo paese, oppure delle canzoni più ascoltate da ogni utente; altre sono scelte da quelle che Reggie Ugwu di BuzzFeed ha definito «piccole squadre di grandissimi – anche se sconosciuti – conoscitori di musica, impegnati nella gara per risolvere il più arduo problema del mercato musicale»: consigliare la musica giusta per ogni persona. Ugwu ha incontrato queste squadre e ha parlato con loro delle “fabbriche di playlist“, quei posti in cui gli sconosciuti espertissimi di musica scelgono le nostre playlist. Ugwu ha scritto:
Per un po’ di tempo abbiamo pensato di poter scegliere da soli la nostra musica. Vi ricordate? Alla fine del secolo scorso abbiamo assaporato il diritto di scegliere da soli tra tutte le canzoni del mondo (tutte-le-canzoni-del-mondo) e mandare a quel paese tutti quelli a cui non piacevano. Ma quando ci siamo resi conto che alla fine erano troppe canzoni (quante vite servono per esplorare a pieno il Memphis soul, o il funk brasiliano?) è nata una nuova categoria di servizi musicali capaci di tirarci fuori dai problemi. Ma quei servizi erano imprecisi […] e potevano raccomandare musica solo in base a quello che già avevamo ascoltato. [Quei servizi] sapevano davvero cosa volevamo? Non si dice forse che ognuno di noi contiene moltitudini?
Su Apple Music, Google Play Music e Spotify ci sono quelle che Ugwu definisce «variazioni di uno schema comune»: playlist già pronte fatte in base alla stagione, al giorno della settimana, ai gusti specifici (“canzoni ispirate a Jeff Buckley”) o al momento specifico (“canzoni da cantare in doccia”). Ne esiste almeno una per ogni genere musicale, attività o stato d’umore immaginabile. Ugwu ha scritto che queste playlist servono soprattutto a due cose: aiutare a trovare le canzoni giuste in un catalogo che ne offre più di 30 milioni e creare differenze in un mercato in cui a tutti piace più o meno la stessa cosa. Il fatto è che ancora non esiste «l’algoritmo capace di giudicare i meriti del nuovo pezzo di Gucci Mane, o capire che qualcuno vuole cantare “A Thousand Miles” di Vanessa Carlton mentre fa la doccia».
Nel frattempo «meno di un centinaio di persone lavorano – per Apple, Google o Spotify – cercando di dare un nome, un contenuto e un costante aggiornamento a tutte le playlist che ascoltiamo. Molti di loro hanno iniziato come DJ, musicisti o esperti di musica; ora fanno i creatori di playlist a tempo pieno. È un lavoro strano perché il loro nome non compare da nessuna parte – «è la cosa migliore per un servizio che deve essere percepito come magico» – ma le canzoni che loro scelgono sono ascoltate da milioni di persone. Spotify ha detto che circa la metà dei suoi 100 milioni di utenti mondiali ascolta le playlist create da esseri umani (di cui non fa per esempio parte la playlist “Discover Weekly”, creata da un algoritmo): mettendo insieme tutti quegli ascolti escono più di un miliardo di “Play” cliccati a settimana. Ugwu ha spiegato che circa una canzone su cinque ascoltata in streaming è dentro una playlist, e questa percentuale sta crescendo velocemente. Jay Frank – vicepresidente della sezione di Universal Music che si occupa del mercato mondiale dello streaming – ha detto: «Tutti i segnali fanno pensare che [le playlist saranno] il modo dominante in cui si scoprirà nuova musica in futuro».
«Abbiamo iniziato a credere che tutti i nostri problemi potessero essere risolti da un codice», ha scritto Ugwu: «Ma forse la musica è una cosa diversa», forse «quel vecchio e stupido rituale umano che prevede di scoprire una canzone e innamorarsi poco dopo» è qualcosa di peculiare. Ed è per questo che «all’interno dei templi di Apple, Google e Spotify ci sono quelli che possono essere definiti – in senso letterale – difensori dell’umanità, al lavoro per soffiare valori intangibili in macchine e computer».
Uno dei difensori dell’umanità si chiama Carl Cherry, ha 37 anni, vive a Culver City, in California, e lavora per Apple Music. Quando Ugwu l’ha incontrato, Cherry era impegnato a decidere se “Jumpman” di Drake e Future potesse andare bene o «aveva saltato lo squalo», era ciò andata oltre a ciò che era bello e interessante, finendo per diventare esagerata o noiosa.
Ugwu ha spiegato che quando Cherry corre su un tapis roulant è impegnato ad ascoltare musica per decidere quali canzoni ascolteremo noi mentre correriamo sul tapis roulant. Cherry si chiede per esempio: «Questa canzone riuscirà a farti andare avanti nonostante la fatica? Questa va bene o parte troppo piano?» Ha spiegato che «è difficile descrivere come si fa a decidere cosa sì e cosa no, è qualcosa di istintivo». Cherry ha iniziato scrivendo di musica per la rivista XXL e nel 2012 è passato a Beats Music (poi diventato Apple Music) come responsabile del reparto Hip Hop e R&B. Cherry è uno dei «grandi esperti di musica, difficili da trovare» di cui parlò Tim Cook, CEO di Apple, quando comunicò che Apple aveva speso 3 miliardi di dollari per comprare Beats, ed è il creatore della playlist che ascolta la cantante Taylor Swift nella pubblicità in cui cade dal tapis roulant.
Rocío Guerrero Colomo lavora invece da New York, dove c’è la sede statunitense di Spotify. Ha 29 anni, è spagnola ed è la persona che in Spotify si occupa dei piani editoriali per l’America Latina. Lavora per Spotify da due anni, da quando diventò una delle prime persone – ora sono circa 50 – a occuparsi della scelta delle canzoni per le playlist. Ora Spotify ha più di 4.500 playlist create da quel team di 50 persone e più di 30 playlist hanno almeno un milione di follower. Colombo suona il violino, parla cinque lingue e spiega di essere diventata responsabile delle iniziative di Spotify in America Latina dopo che disse a Doug Ford, uno dei suoi capi in Spotify: «Stiamo crescendo molto nel mondo, abbiamo bisogno di qualcuno che si occupi di creare playlist per gli utenti che parlano spagnolo. Sono una di quegli utenti, penso che dovrei occuparmene io». Doug Ford disse sì. Da allora Colomo ha creato più di 200 playlist e lo ha fatto in un modo normalissimo, lo stesso usato da chiunque abbia Spotify. La differenza è che le sue playlist sono messe in evidenza da Spotify e quindi ascoltate da moltissime persone.
Colomo ha spiegato che la playlist ideale deve avere uno stile o un target di riferimento specifico, deve durare tra le tre ore e le tre ore e mezza (il “numero magico” di canzoni di metterci è, secondo Spotify, 50) e deve avere un’immagine e un breve testo (titolo e descrizione) che sappia spiegare il contenuto e invogliare l’ascolto. Ma deve essere brevissimo: «Non penso che la gente venga su Spotify per mettersi a leggere», ha detto Colomo. A differenza dei normali utenti, Colomo ha a disposizione dati di ogni tipo – li fornisce un programma che si chiama PUMA, Playlist Usage Monitoring and Analysis – per capire quanto e come funzionano le sue playlist e capita che le modifichi anche dopo averle pubblicate, correggendo qualcosa, aggiungendo o togliendo canzoni. Mentre parlava con Ugwu, Colomo stava lavorando a una playlist intitolata Hip Pop, sulle contaminazioni tra Pop e Hip Hop nella musica latinoamericana. Una canzone che secondo Colomo sarà di certo in questa playlist è “La Ocasión” di De La Ghetto – un musicista portoricano –e di Arcangel, Ozuna e Anuel.
A New York c’è anche la sede di Google Play Music, all’undicesimo piano di un edificio della 8th Avenue. Quelli che scelgono le playlist per Google Play Music sono circa venti, hanno in media trent’anni e quando Ugwu è andato da loro erano impegnati a guardare i risultati della playlist “Blogged Pop Party”: guardavano “Song Score”, il PUMA di Google Play Music, che dice quanto tempo gli utenti sono rimasti su una canzone, quante volte l’hanno saltata e quanti pollici in su o in giù le hanno dato. “Blogged Pop Party” è stata creata da Brad Hayward, che ha 30 anni e arriva da Songza, un’app per creare playlist che Google comprò nel 2014 (per un prezzo che si pensa fu di circa 39 milioni di dollari). Hayward ha spiegato che “Blogged Pop Party” – in cui ci sono canzoni come “Peaches N Cream” di Snoop Dogg o “Tell Em” di Rich Homie Quan e Young Thug – «non è la tipica playlist da festa» perché anziché stare solo su un genere (cosa che fa la maggior parte delle playlist) è una playlist fatta per chi ascolta un po’ di tutto, dai Purity Ring a Justin Bieber, passando per Kendrick Lamar. È una cosa che solo degli umani sanno fare bene: un algoritmo mette insieme canzoni simili, ma un esperto di musica sa mettere insieme canzoni diverse che stanno però bene insieme. Ugwu ha scritto che «l’obiettivo di chi fa playlist è far pensare meno al genere musicale e più al modo in cui le canzoni ci fanno stare», che «tre delle dieci più popolari playlist di Spotify non hanno un genere indicato nel titolo» e che il prossimo redesign di Apple Music punterà molto su canzoni basate sul giorno della settimana, non sul genere musicale.
C’è una semplice ragione economica nel modo in cui queste società cercano di categorizzare la musica in un modo più pratico: è più facile orientarsi. Cercare generi e sottogeneri tra 30 milioni di canzoni è come leggere le uscite dell’autostrada mentre si è in macchina: bisogna sapere prima cosa si sta cercando. Tutti, ovunque, sono invece in grado di capire cosa implica una playlist intitolata “Canzoni per farti rilassare”.







