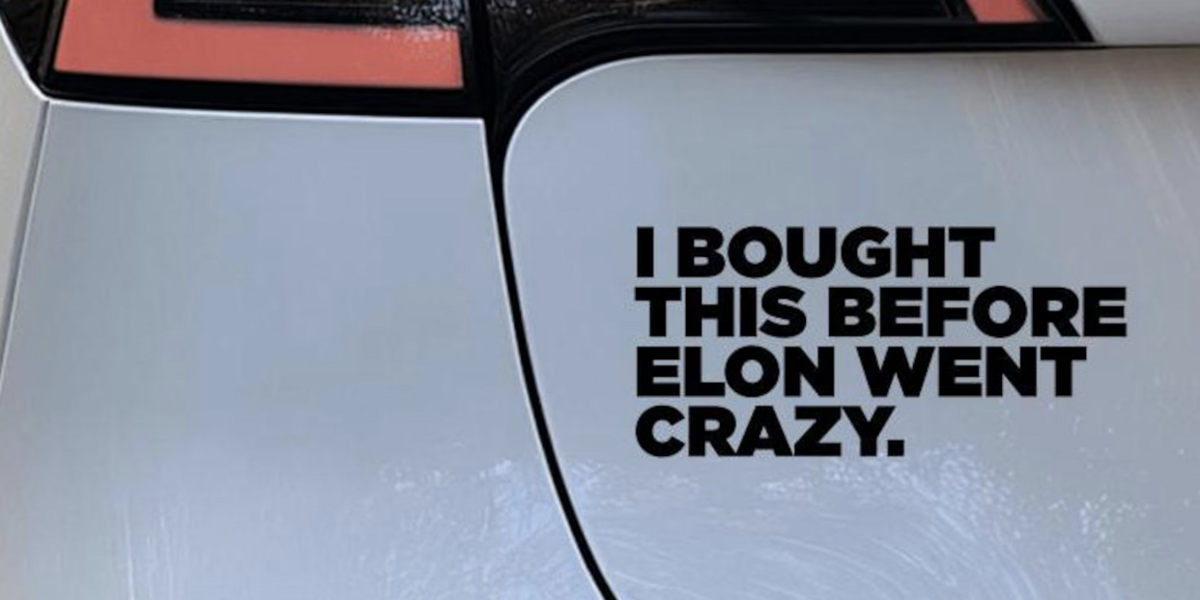I palestinesi e le definizioni della violenza
In Palestina si usano parole molto diverse per definire gli scontri di questi mesi e i loro responsabili, e non è solo questione di linguaggio
di William Booth – Washington Post

Gli israeliani non hanno dubbi: lo definiscono “terrorismo”. I palestinesi, invece, dopo cinque mesi di violenze quasi quotidiane, hanno ancora difficoltà a descrivere l’aumento di attacchi con coltelli, armi da fuoco e veicoli contro soldati e civili israeliani. Si tratta di “rivolte”, “scontri”, un “risveglio”, o è solo “disperazione” personale? Gli assalitori sono “martiri”, “vittime”, o entrambe le cose? Gli adolescenti che brandiscono coltelli da cucina sono da considerare “eroi” o “bambini”? E quando vengono colpiti e uccisi dai soldati israeliani durante gli attacchi, dovrebbero essere celebrati come “guerrieri” per la causa palestinese, o compatiti come persone instabili che hanno perso il controllo?
Se da una parte i civili palestinesi non sono sicuri di come definire le violenze degli ultimi mesi, sembra che la scelta delle parole paralizzi i loro leader. I dirigenti dell’Organizzazione per la Liberazione della Palestina (OLP) − impopolari e sempre più vecchi – sono attenti a non appoggiare né condannare apertamente gli attacchi, contribuendo alla sterile narrazione che viene fatta delle violenze. Gli attacchi stanno aiutando i palestinesi a ottenere uno stato, o a perderlo? La classe politica palestinese è attenta a non contrariare la comunità internazionale, che ha universalmente condannato gli attacchi. Allo stesso tempo i funzionari palestinesi hanno paura ad affrontare il loro popolo, che secondo i sondaggi sostiene la “lotta armata” ed è stanco dei vecchi leader che non sono riusciti a dar loro una nazione. Le parole scelte dai palestinesi per descrivere gli attacchi sono importanti: la lingua rivela il senso e le intenzioni, soprattutto nei conflitti.
Le autorità israeliane bollano la vaghezza dei palestinesi come debolezza o astuzia, sostenendo che non siano in grado di controllare i loro ragazzi e rimangano in silenzio per timore della loro gente, o perché sperano di trarre dei vantaggi tattici dalle violenze. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha recentemente fornito la sua spiegazione: i palestinesi celebrano una “cultura della morte” e per questo accoltellano gli israeliani. I palestinesi, invece, attribuiscono la colpa all’occupazione militare della loro terra che dura da quasi cinquant’anni e che definiscono “un’apartheid del ventunesimo secolo”.
Le interviste del Washington Post ad alcuni palestinesi e ai loro leader hanno rivelato profonde divisioni sull’uso del linguaggio, sia in arabo che in inglese. Dall’inizio di ottobre, i palestinesi hanno ucciso 28 israeliani e quattro persone di altra nazionalità, tra cui un americano. I palestinesi uccisi sono stati oltre 160: 111 durante gli attacchi e 50 nel corso di scontri con le forze israeliane. I palestinesi spesso si rifiutano di descrivere gli accoltellamenti e le sparatorie come “attacchi”, preferendo termini come “azioni”, “episodi”, o “operazioni”, sebbene quest’ultimo implichi un’organizzazione di miliziani e una guida dall’alto, che i palestinesi negano. «Non mandiamo la nostra gente fuori con i coltelli. Non facciamo andare i nostri bambini nei campi a morire», ha detto Mohammad Shtayyeh, ministro del governo palestinese e direttore del Palestinian Economic Council for Development and Reconstruction, «noi incoraggiamo la resistenza pacifica». Quando gli è stato chiesto di definire l’ondata di violenze, Shtayyeh ha attribuito la responsabilità a «iniziative personali».
E gli obiettivi israeliani, come vengono chiamati? La popolazione e i media palestinesi usano i termini “coloni” e “occupanti” per descrivere le vittime ebree nella Cisgiordania occupata, che ospita 400mila coloni ebrei. Hanno però difficoltà a spiegare come una donna ebrea con sei figli accoltellata a morte nella sua cucina possa essere un obiettivo al pari di un soldato israeliano armato a un checkpoint. L’università al-Quds si trova nella periferia di Ramallah ed era frequentata dal primo assalitore dell’ondata di attacchi. Il diciannovenne Muhannad Halabi accoltellò una coppia ultra ortodossa con un passeggino nella Città Vecchia di Gerusalemme, uccidendo il padre e un rabbino che era arrivato in loro soccorso, prima che la polizia gli sparasse uccidendolo. Qualche giorno fa, alcuni giovani studenti passeggiavano per i cortili dell’università tra una lezione e l’altra. Secondo Abdul Ayad, che ha vent’anni e studia giurisprudenza, «Questi atti dovrebbero essere guidati politicamente, ma non è così. Sono attacchi individuali. Non ci vedo politica, ma rabbia. La morte di un giovane è uno spreco: prova ad accoltellare un israeliano e gli sparano. Lo capisco, ma che senso ha?».
Molti palestinesi sottolineano che gli assalitori sono dei “bambini”, nonostante la maggior parte siano in realtà tardo adolescenti e giovani adulti, coetanei dei soldati israeliani. Le loro azioni sono “eroiche” o “coraggiose” e andrebbero celebrate sventolando bandiere e con funerali di massa come ha detto in televisione Jibril Rajoub, ex capo delle forze di sicurezza palestinesi e presidente dell’associazione calcistica palestinese? Quando gli è stato chiesto di definire le violenze in un’intervista con il Washington Post, Rajoub ha risposto: «Vuoi che lo definisca terrorismo e che li chiami martiri? Sono vittime. Ti assicuro che dietro ognuno di questi atti c’è stato un atto da parte di coloni o soldati che ha coinvolto personalmente l’assalitore o uno dei suoi genitori. C’è un motivo». Alcuni funzionari palestinesi hanno detto a diplomatici e giornalisti occidentali che secondo loro almeno alcuni degli assalitori avrebbero perso il controllo a causa delle pressioni dovute alla vita di stenti sotto l’occupazione. Dei traumi psicologici li avrebbero indotti a correre verso soldati israeliani impugnando un coltello per commettere la versione palestinese del “suicidio da polizia“. Secondo Mustafa Barghouti, segretario generale del partito socialdemocratico Iniziativa Nazionale Palestinese, «gli accoltellamenti non sono organizzati. Sono causati dalla frustrazione».
Alcuni attivisti palestinesi hanno definito le violenze come l’inizio di una terza “intifada”, una rivolta di massa. La prima intifada negli anni Ottanta fu caratterizzata dal lancio di pietre da parte di giovani palestinesi; la seconda, negli anni Duemila, da attacchi suicidi; entrambe furono guidate da fazioni di miliziani e sostenute dalla leadership politica palestinese. Molte persone definiscono il termine “intifada” esagerato e rifiutano di usarlo per descrivere le nuove violenze: esistono poche prove che si tratti di una ribellione di massa, come mostrano i numeri relativamente bassi di manifestanti nelle strade. «In passato le nostre ribellioni erano guidate da uomini famosi, mentre ora sono persone che spuntano dal nulla, persone comuni che diventano icone», ha detto Abdullah Khatib, un altro studente di giurisprudenza dell’università al-Quds. Secondo Abdel Khader, studente diciannovenne di ingegneria dei materiali, «non possiamo chiamarla intifada». «La causa è la pressione tremenda sui giovani, che poi scaturisce negli attacchi», ha raccontato Khader, «Inizia con una persona che decide di fare un attacco, e vuole sfogare la sua rabbia, vendicarsi». Con quale obiettivo però? «L’obiettivo è mostrare agli israeliani che se loro ci feriscono, possiamo farlo anche noi», ha aggiunto Khader, che ha negato la tesi secondo cui i giovani assalitori punterebbero a donne e bambini israeliani. «Non partono con quest’idea. Ma sono loro che alla fine muoiono, perché è loro che trovano», ha detto Kahder, che ha scelto la parola “scontri” per definire l’ondata di violenze.
In un discorso di gennaio a Ramallah, il presidente dell’Autorità Nazionale Palestinese Mahmoud Abbas ha definito le violenze come «un risveglio popolare», sostenendo che gli attacchi sarebbero stati compiuti «in risposta all’occupazione continua, le colonie, l’affronto all’onore dei luoghi sacri, e l’assenza di una soluzione giusta per la questione palestinese, di un orizzonte diplomatico, e di speranza per il futuro». Parlando con un giornalista israeliano, questo mese Abbas ha detto che il governo israeliano deve chiedersi «perché un tredicenne dovrebbe lanciare pietre e attaccare altre persone». Secondo Abbas il motivo è che «non ce la fa più». Nessuno sa come si evolverà la situazione, ma i segnali sono preoccupanti: secondo l’ultimo sondaggio del rispettato ente di ricerca Palestinian Center for Policy and Survey Research, condotto a dicembre, due terzi dei palestinesi chiedono le dimissioni di Abbas, due terzi sostengono l’attuale ondata di accoltellamenti, e il cinquanta per cento crede che gli scontri sfoceranno in un’intifada armata. Il sondaggio ha rivelato che i membri della cosiddetta “generazione Oslo” – persone tra i 18 e i 22 anni nate all’alba dell’ormai fallito “processo di pace” e che non ricorda le intifada del passato – sono i maggiori sostenitori delle violenze, e non credono più nella soluzione dei due stati.
© 2016 – Washington Post