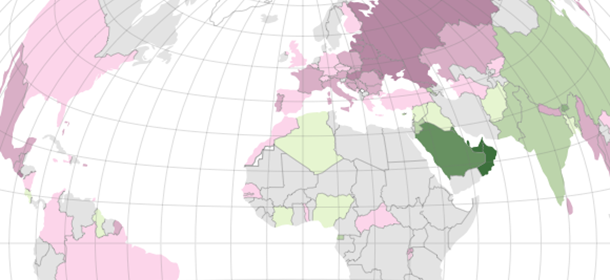C’era l’amore nel Ghetto
Un racconto di Marek Edelman, che partecipò alla rivolta del Ghetto di Varsavia, iniziata settant'anni fa

Il 18 gennaio 1943 gli ebrei del Ghetto di Varsavia occupata dai nazisti reagirono per la prima volta alle le violenze e le deportazioni, che riuscirono a impedire resistendo ai tedeschi. Il comandante delle SS ordinò la distruzione del Ghetto, i cui abitanti organizzarono una rivolta che tenne in scacco i nazisti per un mese tra aprile e maggio, prima che il Ghetto fosse raso al suolo e la rivolta si concludesse con l’uccisione di oltre diecimila ebrei e la deportazione di circa 50 mila. Marek Edelman (1922-2009) fu tra i capi della rivolta e ne raccontò e scrisse in più occasioni nei decenni successivi. Nel 2009 Sellerio pubblicò una sua raccolta di storie provenienti da quei giorni intitolata C’era l’amore nel ghetto. La rivolta del Ghetto di Varsavia è diventata per la storia ebraica e mondiale un episodio simbolico di resistenza alle persecuzioni antisemite.
La signora Tenenbaum, infermiera dell’ospedale Bersohn e Bauman, era amica dell’avvocato Berenson. Tutti i giorni gli serviva il pranzo. Dopo il pasto il signor avvocato si appisolava, allora arrivava la figlia di lei, una diciassettenne garbata, ben pettinata e lisciata, con una camicetta bianca inamidata. Aiutava sua mamma a pulire.
Si concluse la Grande Operazione di sgombero e 44 mila persone ricevettero il numero della vita. Tra loro la signora Tenenbaum. Quando all’ospedale tutti coloro che avevano il numero si misero dal lato «della vita», qualcuno si accorse che la signora Tenenbaum era nel letto, e sul suo tavolino c’erano delle bottigliette vuote di luminal, una lettera e il suo numero. Nella lettera la signora Tenenbaum diceva che il suo numero lo dava a sua figlia e che si toglieva la vita. Non starò a raccontare nei dettagli le divergenze tra i medici sulla scelta di salvare o meno la signora Tenenbaum.
Alcuni erano dell’opinione che bisognasse salvarla, altri invece che no, perché tale era la sua volontà. E così è stato. Deda, era questo il nome della figlia, ebbe dunque il numero della vita. Una ragazzina così timida rimase sola. E d’improvviso s’innamorò di un ragazzo. Si vede che aveva un po’ di soldi, perché il ragazzo riuscì a trovare una casa per loro nella parte ariana della città. Lei sbocciò in quell’amore. Per tre mesi visse con quel ragazzo in grande felicità nell’appartamento della parte ariana.
Solo quell’amore, nient’altro traspariva da lei. Chiunque, senza eccezione, la vide allora, diceva che irradiava felicità. A Marysia, che andava a trovarla, diceva che erano i mesi più felici della sua vita. Il calore che le dava il suo ragazzo le fece dimenticare il ghetto. Tre mesi durò quella felicità. Poi – forse erano finiti i soldi – i padroni di casa consegnarono lei e il suo ragazzo.
Tra le deportazioni di gennaio e l’aprile del ’43 stavamo tornando, attraverso il quinto piano di un grande palazzo con enormi appartamenti, dall’operazione al panificio (ogni panettiere doveva consegnarci 40 pagnotte di pane e questo di solito avveniva verso l’alba alla fine della cottura). Tutte le porte degli appartamenti, anche sui pianerottoli, erano aperte per facilitare il passaggio: entri in un appartamento dalla porta principale, lo attraversi tutto, esci sulla scala di servizio e da lì passi nell’appartamento successivo. In corridoi ed anticamere c’erano sistemati dei letti.
Vidi Z∂otogórski. Era un pezzo d’uomo. Non so perché mi è rimasto negli occhi il suo imponente torace abbronzato (di fatto non era ancora estate e non c’era modo di abbronzarsi). Sul suo braccio riposava una piccola ragazza diciassettenne dai capelli biondi. Dormiva stringendosi a lui e sul suo volto era dipinto un sorriso e una calma beata. Qualche giorno dopo finirono insieme in un’ulteriore retata e vennero deportati a Treblinka.
Una dottoressa quasi quarantenne, anche il marito medico, ufficiale dell’aeronautica, disperso durante la guerra. Lei non sapeva che fine avesse fatto. Oggi si sa che morì a Katyn. Il secondo giorno di guerra la dottoressa venne all’ospedale al suo posto di lavoro e non lo lasciò più. Era molto sola. Ne soffriva. Nacque una relazione amorosa tra lei e un ragazzo più giovane di quindici anni. Il ragazzo s’ammalò improvvisamente, lei lo prese nel suo letto e riuscì per qualche miracolo a salvarlo. Dormì con lui nello stesso letto per qualche giorno. Diceva dopo, che per la prima volta in quella solitudine aveva trovato qualcuno, una persona a cui stare vicina, e che d’ora in poi avrebbe sempre cercato di stare insieme con qualcuno.
Durante l’insurrezione di Varsavia rimase di nuovo sola. Aveva un flaconcino con dentro quattro grammi – una dose enorme! – di morfina. Ingoiò quei quattro grammi e già barcollava quando arrivò per caso qualcuno e di forza le versò in gola un bicchiere di acqua saponata. Lei vomitò e si svegliò nel cuore della notte, ormai cosciente. E allora cominciò il suo grande amore con un ragazzo di vent’anni più giovane di lei. Visse con lui felicemente dalla fine dell’insurrezione fino a novembre, quando fu tirata fuori dal quartiere di Zoliborz, felice, sorridente, pronta ad aiutare tutti.
La guerra finì e lei si stabilì a ∫ód. Un giorno qualcuno va a trovarla. La porta è aperta e il visitatore ha l’impressione che l’appartamento sia vuoto. Invece scopre che in cucina, con la testa sprofondata sotto la coperta, giace la dottoressa. Forse dorme, o magari sonnecchia. Ad un tratto però si mette seduta e dice: «Io non ci sto più qui da sola». E lo dice una persona coraggiosa come lei. «Ho paura, devo scappare via di qua».
Non so come, riuscì ad arrivare in Australia. Una grande specialista nel suo campo della medicina. Ma anche laggiù era sola. Una nave carica di bambini ebrei si aggirava nell’Oceano Pacifico e nessuno Stato voleva farla attraccare. Si fermò al largo, a dodici miglia dalla costa. Gli abitanti accostavano la nave con le barche e ciascuno prendeva qualche bambino. Anche la mia dottoressa uscì in mare. Prese con sé due maschi e una bambina. Uno dei ragazzi diventò architetto e lavorò poi a Shanghai, l’altro fu docente di costruzioni navali, la ragazza diventò un’analista di laboratorio molto qualificata.
Quando uno dei figli della dottoressa fu adulto, lei s’innamorò di lui e visse in sua compagnia lunghi anni di felicità. Più tardi scrisse in una lettera che, anche dopo che ebbe saputo che cosa era stato del suo marito tanto amato, a tenerla in vita era stato l’amore. L’amore e il calore di un figlio che divenne poi il suo uomo. Quando morì, aveva oltre novant’anni. Una ragazza. Sua mamma si ammalò. Lei non aveva che una sorella gemella. La notte, avevano paura di stare da sole a casa con la mamma malata.
Prese a frequentarle un ragazzo, un conducente di risciò. Quando la mamma stava peggio, il ragazzo restava la notte, e la ragazza per paura che potesse succedere qualcosa si stringeva a lui. Dormiva con lui in camicia da notte di batista. Stretta fra le sue braccia si addormentava serena. Forse cominciarono a far l’amore. Non è certo che lo facessero, e nemmeno che sapessero come si fa, però, grazie alla presenza di lui, lei si tranquillizzava. La madre cominciò a riprendersi e la ragazza andò a lavorare.
Un giorno in via Karmelicka ci fu una retata. Quando lo seppe corse a casa, ma la mamma non c’era più. Una folla, un paio di migliaia di persone, veniva trascinata all’Umschlagplatz. Spuntò il suo ragazzo col risciò, raggiunsero il corteo e, procedendo a lato di tutta quella moltitudine, si misero a cercare la madre di lei. La scorsero poco prima dell’Umschlagplatz. La ragazza scese dal risciò, lui restò sul bordo del marciapiede. Gli disse: «Purtroppo dobbiamo separarci, la mamma non può partire da sola per un viaggio così». E seguì sua madre nel vagone. Che fine abbia fatto la sorella, non si sa.
Era la vigilia di Natale. Due nostre staffette abitavano in via Miodowa, nel palazzo in cui oggi ha sede la Scuola d’Arte Drammatica. Erano tornate a casa a sera inoltrata e si misero a scartare i pacchi della spesa. Stavano tirando fuori alimenti vari, quando qualcuno bussò alla porta. Era un signore anziano con una lunga barba. Un ebreo riuscito mezz’ora prima a evadere dal commissariato dove era agli arresti. Difficile dire se si conoscessero già. Forse sì, e per questa ragione si era presentato da loro. Rimase.
Arrivarono altre amiche, per un ipotetico cenone di Natale, e così in quattro o cinque si fermarono per la notte. Dormirono per terra. Una delle nostre staffette fece l’amore con l’anziano ebreo la notte intera, sotto gli occhi di tutte. Può anche darsi che quella staffetta fosse un tipo bisessuale, perché prima era stata amica di una dottoressa più anziana, presa in una retata nella parte ariana e deportata ad Auschwitz. E quel vecchio ebreo con la barba lunga incanutita rimase lì. S’innamorò della nostra staffetta e così vissero insieme fino all’insurrezione di Varsavia del 1944.
Tanto grande era il loro amore che abbandonarono ogni precauzione e insieme, tenendosi per mano, giravano per la città. Avevano l’aria così felice di poter camminare per le strade liberamente, mano nella mano, senza alcuna paura. Venne l’insurrezione di Varsavia a separarli. Lui disse allora: «Non ho più nessuno, sono solo e nessuno mi tenderà più la mano». Resistette per quattro settimane dell’insurrezione rintanato sulle scale nella Città Vecchia. Lei lavorava come infermiera in un ospedale, in un altro quartiere.
S’incontrarono di nuovo in centro, e passarono insieme una settimana. Tornarono a vivere, di nuovo non provavano paura. Lui sopravvisse all’insurrezione, ma venne arrestato dall’Ub, i servizi di sicurezza, e non se ne seppe più niente. Lei rimase a Varsavia, da sola, e più tardi ebbe due bambini. Tutto ciò che provava per lui, lo riversò sui figli, così diceva. Non si sposò mai. Eppure era carina.
Una che aveva un impiego tecnico nell’ospedale nel ghetto. Era bella, ma sciocca. In qualche modo riuscì a passare nella parte ariana. Diventò una nostra staffetta. Aveva occhi azzurri, ma dicevano: «Ha gli occhi di una mucca». Durante l’insurrezione di Varsavia stava nella zona di Z.oliborz. Un giorno, a due passi da lei esplose una granata e ferì gravemente un soldato. Lei si prese cura di lui e ovviamente subito se ne innamorò. Per sei settimane gli curò le ferite alla testa, credendosi una grande specialista, perché prima aveva lavorato in ospedale.
Z.oliborz si arrese, ma lui ancora non aveva la forza di camminare. Rimase con lui nel quartiere, ormai abbandonato dalla popolazione civile. Verso novembre furono trovati da una pattuglia della Croce rossa. Lo portarono via e lei andò dietro alla barella. E vissero insieme fino alla morte di lui. La nostra sciocca staffetta diceva che era valsa la pena sopportare il ghetto e l’insurrezione di Varsavia, perché grazie a questo aveva imparato che cosa era l’amore e quanto si poteva dare di sé all’altro. Quando lui morì, riversò tutto l’amore sul figlio. Ma quel suo amore era follemente difficile.
Cominciava a imbrunire. Mancava mezz’ora al coprifuoco. Lui però aveva ricevuto l’ordine di passare nel ghetto piccolo. Era giovane, sano, svelto. Andò di corsa, sbrigò la cosa. E quando prese la strada del ritorno, era già buio. Saltando di portone in portone, arrivò a casa. Nella scala buia c’era un’ombra. La toccò e sentì due trecce belle spesse. Si abbracciarono e salirono insieme al primo piano. E insieme rimasero per tutta la guerra. Insieme passarono tutto il peggio e il meglio durante l’occupazione.
Dopo la guerra lei andò in America, da sola. Lui rimase. Si erano però conosciuti a fondo, avevano imparato ad essere una cosa sola. Vent’anni dopo s’incontrarono di nuovo. Sebbene durante tutto quel tempo ognuno di loro avesse vissuto un’altra vita, continuavano ad essere una cosa sola. Quando lei fu vicina a morire, la donna che l’accudiva telefonò a lui per chiedere se poteva sospendere le cure.
Via Mylna partiva da via Przejazd e con un percorso a zigzag finiva su uno spiazzo verde recintato adiacente a via Karmelicka. Dall’altro lato dello spiazzo verde arrivava ad arco via Nowolipie che poi, ormai dritta, proseguiva dall’altra parte di via Karmelicka. Via Przejazd oggi non c’è più. Cominciava da via Leszno. Passava oltre via D∂uga dal lato est e formava una piazzetta con la tortuosa via Mylna e l’arcuata via Nowolipie, mentre dopo via Nowolipki girava verso via Nalewki.
Durante la Grande Operazione di sgombero di luglio, passando per caso per via Mylna, alla finestra di un seminterrato del palazzo adiacente allo spiazzo verde prima di via Karmelicka, vidi la faccia di Hendusia Himelfarb. Era una mia compagna di scuola, figlia di un grande attivista sociale e leader sindacale. Durante la guerra Hendusia lavorava al sanatorio Medem a Miedzeszyn vicino a Varsavia. Venivano mandati laggiù i bambini del ghetto minacciati dalla tubercolosi e là, circondati da affetto e calore familiare, facevano la presunta cura.
Hendusia aveva la carnagione chiara e folte trecce bionde. Di solito le raccoglieva a corona sul capo, ora invece le scendevano sulle spalle. «Hendusia, vieni», gridai verso di lei, «c’è una via di scampo per te, per quelli come te. Domani passerai nella parte ariana». Ci divideva il marciapiede e quello spiazzo verde recintato. «Ho qui centocinquanta bambini, non posso mica lasciarli. Non possono andare da soli nei vagoni e partire per quel viaggio da soli», mi gridò dalla finestra del seminterrato, attraverso il marciapiede. In quell’edificio c’era prima un ospedale evangelico. Adesso ci avevano messo i bambini del sanatorio Medem. Hendusia sapeva dove portava la loro strada.
Lo sapeva anche Roza Ejchner, un’anziana insegnante di Vilna che era rimasta con loro. Tutti gli altri insegnanti e educatori si erano dispersi chissà dove durante l’evacuazione del sanatorio di Miedzeszyn. C’era tra loro la moglie di Artur Zygielbojm con il figlio. Si nascosero fra i cespugli tra Miedzeszyn e Wiazowna. Qualcuno però deve averli denunciati e lì, dietro quei cespugli, vennero uccisi. Per Varsavia e poi oltre, per l’ultimo viaggio, partirono coi bambini soltanto Hendusia e Roza. Hendusia avrebbe potuto uscire, salvarsi, sopravvivere. Ma non voleva che i bambini avessero paura, che piangessero.
E rimase con loro, pur sapendo che cosa sarebbe accaduto. Per senso del dovere o per amore dei bambini? All’epoca era la stessa cosa. Una capo infermiera, alta, bella, con una chioma di capelli rossi dorati. Abita nell’ex sala operatoria, dove la finestra occupa tutta la parete. Sta in vestaglia alla finestra e chiama un ragazzo che attraversa il cortile. Gli apre la porta, sfila la vestaglia e mostra il bellissimo corpo bianco latte. Il ragazzo, per quanto sorpreso, entra. La capo infermiera gli inietta una dose di morfina e si stende nuda sul divano, e lui, smarrito, fugge.
Poi arrivò la Grande Operazione di sgombero. S’innamorò di lei un medico, un volksdeutsch6 di remota origine che i tedeschi avevano nominato commissario dell’ospedale. Durante la Grande Operazione, quando sgomberano l’ospedale pediatrico da via Sienna, la portano all’Umschlagplatz insieme coi bambini. Il commissario viene a saperlo la sera, esibisce la sua tessera tedesca e lo fanno entrare sull’Umschlagplatz. La trova tra la folla e la porta via. Al coprifuoco sono già nel suo appartamento.
Si amano follemente per tutta la notte, poi lui porta fuori dal ghetto lei e suo marito, malato di tubercolosi, e affitta per loro un appartamento a S ́wider fuori Varsavia. Va a trovarli tutti i giorni, porta da mangiare. Ogni volta i due se ne vanno insieme per mezz’ora nel bosco. Un giorno, arrivando, trova l’appartamento vuoto. I vicini dicono che poco prima i coniugi sono stati portati via e giacciono fucilati accanto alla ferrovia. Lui va laggiù, s’inginocchia e resta a lungo a pregare. Fugge quando sente arrivare una pattuglia tedesca. Così si concluse quel folle amore.
Foto: National Archives/Newsmakers