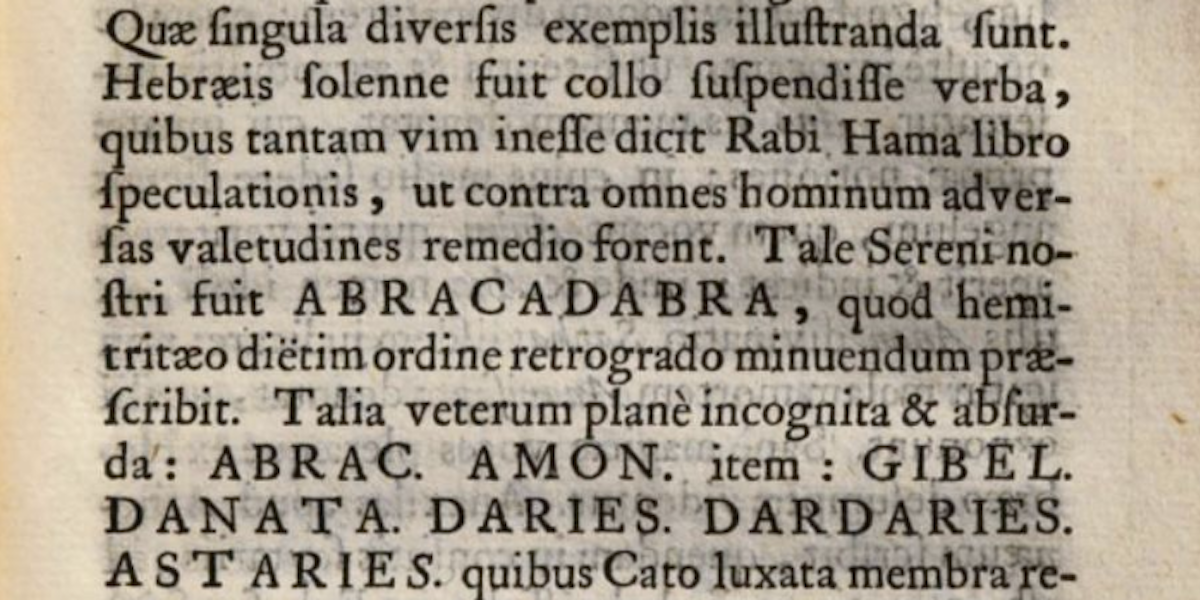«Quando hanno aperto la cella»
Da Pinelli a Cucchi, le storie delle persone morte nelle mani dello Stato, nel libro di Luigi Manconi e Valentina Calderone
di Valentina Calderone e Luigi Manconi

 Stefano Cucchi che amava la boxe
Stefano Cucchi che amava la boxe
Giovedì 22 ottobre 2009 ore 6.15 di mattina. Stefano Cucchi, 31 anni, nella sua stanza all’interno del reparto protetto dell’ospedale Sandro Pertini, dove era ricoverato da sabato 17 ottobre, non «risponde agli stimoli». Gli infermieri di turno quel giorno scriveranno sul diario clinico di aver tentato la rianimazione senza riuscirci. L’autopsia, di cui verranno resi noti i risultati solo qualche mese dopo, stabilisce che il decesso è avvenuto verso le 3 di notte. Stefano Cucchi, quindi, viene letteralmente «trovato morto».
Chi lo aveva in cura se ne accorge quasi accidentalmente e anche la successiva decisione di provare a rianimarlo pare sia più un’occasione per assolvere stancamente il proprio dovere e compilare un diario clinico, piuttosto che un reale tentativo di salvargli la vita. In effetti, non era impossibile salvarlo. La sua condizione clinica non era disperata, non si trovava da giorni in bilico tra la vita e la morte. Fino alla settimana prima non era neanche immaginabile che potesse correre un rischio simile. Il 15 ottobre, la sera del suo arresto, Stefano era un ragazzo sano. Da quando viene privato della libertà, il suo stato di salute non fa che peggiorare. I medici sono perfettamente a conoscenza dell’aggravamento delle sue condizioni. Come è possibile che non si siano preoccupati di monitorare il suo stato durante la notte? Per ore nessuno, in quel reparto, si è reso conto che non respirava più.
La sua vicenda è piena di anomalie come questa, che suscitano domande banali e che necessitano di una risposta: troppe sono state le dimenticanze, le sottovalutazioni, le leggerezze. È stato un iter lungo meno di una settimana, in cui si sono accumulate colpe, negligenze e indifferenze che lo hanno portato alla fine.
La storia di Stefano Cucchi non è una storia di malasanità e neanche una storia di carcere. La sua vicenda è un esempio paradigmatico del fallimento della «macchina della giustizia» e di come questa sia in grado di provocare danni incalcolabili: insinuandosi, espandendosi, coinvolgendo e contagiando tutta una serie di apparati e figure che avrebbero tutt’altra missione rispetto a quella, evidentemente così prioritaria, della repressione e della custodia. Non è solo una storia di prigioni o di ospedali. Dal giorno del suo arresto fino alla sua morte, Stefano Cucchi ha attraversato un numero elevato di luoghi istituzionali e di apparati statuali: due caserme dei carabinieri, le celle di sicurezza, le aule e l’ambulatorio del tribunale di Roma, l’infermeria e una cella del carcere di Regina Coeli, il pronto soccorso del Fatebenefratelli, il reparto detentivo del Sandro Pertini. Complessivamente, si è trattato di un itinerario verso la morte scandito da dodici passaggi: le dodici stazioni di una via crucis, da quella caserma di via del Calice nella tarda serata del 15 ottobre fino all’obitorio, dove viene portata la salma nella tarda mattinata del 22 ottobre.
Sono dodici tappe di un calvario, corrispondenti ad altrettante sedi dove lo Stato è presente con i suoi apparati, le sue procedure, i suoi funzionari (compresi i presidi medici dove opera personale sanitario appartenente all’amministrazione pubblica e i posti di polizia presso il pronto soccorso degli ospedali) e dove Cucchi viene trattenuto e sorvegliato, trattato e costretto e dove subisce abusi e illegalità. E dove, ancora, una lunga schiera (decine di persone) di carabinieri e agenti di polizia penitenziaria, magistrati e avvocati, medici e infermieri, funzionari e operatori penitenziari – dal momento in cui la violenza fisica viene inferta, forse da più autori –, chiudono gli occhi per non vedere, si astengono, omettono, quando non contribuiscono a fare del male, abusando del loro ruolo o mancando ai doveri che quel ruolo impone, negando e falsificando, trascurando e abbandonando.
Bisogna indagare lungo tutti questi passaggi per individuare le cause, le colpe e le complicità di tutti quelli che, a vario titolo e secondo la propria funzione hanno, con i loro comportamenti, contribuito a determinare la morte di Stefano Cucchi: nessuno degli attori intervenuti è riuscito a interrompere (più probabilmente non ha voluto interrompere) il corso degli avvenimenti; ognuno, con le proprie azioni, ha collaborato a che quegli eventi precipitassero, fino al loro epilogo. È questa visione d’insieme che nei primi mesi dopo l’accaduto e nel corso delle indagini ha stentato ad affermarsi e, tuttora, non è patrimonio condiviso da tutti. La morte di Cucchi è stata il risultato di una lunga serie di eventi, la concatenazione e la sommatoria di fatti legati tra loro, il cui nesso di causalità non può venire ignorato. Nesso che è stato chiaramente definito dall’autopsia effettuata dopo la riesumazione della salma dai medici legali nominati dalla famiglia Cucchi, i professori Vittorio Fineschi e Cristoforo Pomara. I consulenti di parte giungono a queste conclusioni circa le cause della morte di Cucchi:
La morte del signor Stefano Cucchi è addebitabile ad un quadro di edema polmonare acuto in soggetto politraumatizzato ed immobilizzato, affetto da insufficienza di circolo sostenuta da una condizione di progressiva insufficienza cardiaca su base aritmica […], intimamente correlata all’evento traumatico occorso e al progressivo scadimento delle condizioni generali del Cucchi.
In particolare, i periti evidenziano che Cucchi non aveva manifestato in precedenza patologie cardiache. Anche dagli esami effettuati nei primi giorni del ricovero non viene rilevata alcuna patologia funzionale, né tanto meno cardiaca. Gli stessi sanitari che lo hanno assistito registrano sempre «frequenze normali e ritmo sinusale». Per i medici legali, all’esame macroscopico «il cuore risulta anatomicamente normale e il successivo esame istopatologico non rivela alterazioni patologiche».
Al momento del suo ingresso in ospedale, quindi, Stefano Cucchi non presentava patologie funzionali di rilievo ma era un soggetto sano, se non per il fatto di avere subito delle fratture. Possiamo leggere dall’autopsia: «Frattura somatica del corpo della terza vertebra lombare (con cedimento ed avvallamento dell’emisoma sinistro) e frattura del corpo della I vertebra sacrale con vasta area di infiltrato emorragico in corrispondenza dei muscoli lombari, del pavimento pelvico e della parete addominale, a dimostrazione della violenza degli effetti lesivi».17 L’unico motivo per cui aveva bisogno di assistenza era, dunque, le conseguenze di quelle fratture che – per guarire – richiedevano solo riposo a letto e immobilità. E, allora, come è stato possibile che nel giro di pochi giorni le condizioni di Cucchi scadessero a tal punto da far scendere il suo peso da 52 chili a 37 chili?
Di Stefano Cucchi, nelle settimane successive alla sua morte, si è detto di tutto: che era drogato, sieropositivo, anoressico. Il tentativo di screditare la sua figura è stato messo in atto più volte, e più volte si è cercato di attribuire alla sua condizione «debole» la principale causa della morte. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Carlo Giovanardi, nel corso della trasmissione Radio mattino su Radio24, dopo aver definito Cucchi «anoressico tossicodipendente […] larva zombie», ha sostenuto che la sua morte è stata causata «soprattutto perché era di 42 chili». La verità, invece, è totalmente diversa da quella descritta dalle parole di Giovanardi e, probabilmente, è ancora diversa da quella che si sta delineando con la conclusione delle indagini avvenuta a giugno 2010.
I pm responsabili del caso hanno rinviato a giudizio tredici persone tra medici, agenti di polizia penitenziaria e un funzionario dell’amministrazione penitenziaria. Per i medici i reati vanno dal falso ideologico all’abuso d’ufficio, dall’abbandono di persona incapace al rifiuto in atti d’ufficio fino al favoreggiamento e all’omissione di referto. Per i poliziotti, invece, i reati contestati sono lesioni aggravate e abuso di autorità nei confronti di arrestato. Il direttore dell’ufficio detenuti e del trattamento del provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria (Prap), Claudio Marchiandi, l’unico ad avere chiesto il rito abbreviato, è stato condannato a due anni per i reati di favoreggiamento falso e abuso in atti d’ufficio nel corso dell’udienza del 25 gennaio 2011 in cui il giudice ha confermato il rinvio a giudizio per tutti gli altri imputati. Qui emerge nitidamente una grave contraddizione: quel nesso di causalità, di cui prima si è detto, non sembra tenuto in alcun conto dagli inquirenti. In altre, e semplicissime, parole: 1) è stata esercitata violenza nei confronti di Stefano Cucchi e quella violenza ha prodotto «lesioni»; 2) nel reparto detentivo del Pertini, Cucchi ha subito una serie abnorme di illegalità e abusi per la quale nove persone sono state rinviate a giudizio e una ha subito una condanna.
Ma tra le due fasi non c’è consequenzialità, non c’è relazione diretta e stringente, non c’è rapporto di causa-effetto. Insomma, Cucchi ha subito comportamenti illegali in due spazi fisici e temporali tra loro distinti e non interdipendenti. La sua storia viene spesso presentata come l’esito di una successione di episodi sfortunati e scissi l’uno dall’altro. Non è così.
Stefano Cucchi il 15 ottobre 2009, trascorre una giornata come tante altre: sveglia alla mattina, il lavoro presso lo studio di geometra del padre, la palestra, dove gioca a boxe, la cena a casa dei genitori. Dopo cena, come d’abitudine, esce a portare fuori il cane. Va verso il parco degli Acquedotti e lì incontra un amico con cui si mette a parlare. Verso le 23.30 viene fermato da alcuni carabinieri della stazione Appia e trovato in possesso di una ventina di grammi di hashish e pastiglie, indicate inizialmente come ecstasy, e poi rivelatisi farmaci per l’epilessia; viene portato nella caserma di via del Calice e da lì accompagnato a casa per la perquisizione. Sarà l’ultima volta che sua madre lo vedrà vivo. La perquisizione non dà risultati e i genitori, che in quel momento lo trovano in buone condizioni, si preoccupano che Stefano sia riuscito ad avvisare il suo avvocato, in vista del processo per direttissima del giorno seguente. I carabinieri rispondono che è stato fatto.
Da questo momento, si verificano le prime anomalie. Stefano viene riportato alla caserma di via del Calice, dove viene compilato il verbale d’arresto e preparati i documenti necessari al processo per direttissima del giorno seguente. Il verbale è pieno di errori: «Cucchi Stefano, nato in Albania il 24 ottobre 1975, in Italia senza fissa dimora, identificato a mezzo rilievi fotosegnaletici e accertamenti dattiloscopici»; l’arresto è indicato alle 15.20 nonostante sia avvenuto dopo le 23; nello spazio riservato alla nomina del legale si legge «il prevenuto, interpellato, dichiara di non voler nominare un difensore di fiducia». Insomma, è tutto sbagliato.
Cucchi nasce a Roma il primo ottobre del 1978, aveva un domicilio (ne è prova la perquisizione effettuata a casa dei genitori quella notte, se non bastassero i due documenti, patente e carta d’identità, che aveva con sé) e, anche in presenza dei genitori, aveva espresso la volontà di essere assistito dal suo legale di fiducia. In quella caserma dei carabinieri passa qualche ora, ma non essendovi là celle utilizzabili, verso le 4 del mattino viene trasferito nella stazione di Tor Sapienza di via degli Armenti. Il carabiniere che lo prende in consegna e procede all’ispezione, privandolo dei lacci delle scarpe e degli effetti personali, riferisce agli inquirenti che Cucchi, quando gli viene chiesto di dare la cintura, risponde «che me devo toglie la cinta che m’hanno rotto?». Il militare constata, effettivamente, che la fibbia della cintura è rotta e non si chiude, ma ritiene di non dover chiedere ulteriori spiegazioni perché l’arrestato «era vestito in maniera piuttosto trasandata». Oltre a questo, nota degli «arrossamenti» sul volto che «sembravano più delle macchie dovute al freddo che lividi, che partivano da sotto le palpebre e si estendevano fino alle guance».
Venti minuti dopo essere stato messo in cella, Cucchi si sente male e viene chiamata un’ambulanza: dal verbale del 118 si legge che «il paziente rifiuta l’assistenza sanitaria e il ricovero in ospedale». Successivamente il medico dichiarerà di non essere neanche riuscito a vederlo: Cucchi si era completamente coperto il corpo con un lenzuolo e non voleva farsi visitare. Qualche ora dopo due carabinieri della stazione di via del Calice vanno a prelevare Cucchi per condurlo in tribunale. Uno dei due riferisce di un colloquio avuto con lui:
Mentre si alzava a fatica dalla branda, ho avuto modo di osservare che sul viso aveva due ematomi che gli circondavano gli occhi, i quali erano particolarmente evidenti a causa del colorito pallido che aveva in viso. A quel punto gli ho chiesto cosa gli fosse capitato e lui mi ha risposto: «M’hanno menato gli amici miei», al che io gli chiedevo quando ciò fosse avvenuto e lui mi rispondeva: «Ieri pomeriggio».
Il carabiniere ricorda che Cucchi lamentava dei dolori alla testa e alla gamba e riferisce anche uno scambio di battute avuto con il militare incaricato di piantonare l’arrestato durante la notte: «Lui ci avvertiva che durante la notte il detenuto era stato particolarmente agitato e che aveva anche dato delle testate al muro». La circostanza che Cucchi manifestasse già dolore la mattina prima dell’arrivo in tribunale e il fatto che ben due carabinieri riferiscano di avere notato «arrossamenti» ed «ematomi» sul suo volto, risulta ignorato dall’indagine. Ci sono anche gli interrogatori dei due detenuti albanesi accompagnati in tribunale con lui, nei quali dicono che Cucchi ha affermato di essere stato picchiato dai carabinieri la sera dell’arresto.
Alle 13 di quel 16 ottobre, nell’aula dell’udienza, è presente anche il padre di Stefano, Giovanni Cucchi, che ha un ricordo molto preciso di quella giornata:
Ho visto mio figlio con il volto gonfio e due segni neri sotto gli occhi. Poiché Stefano era magro, io ho notato questa diversità nel suo aspetto in modo evidente. Dopodiché, egli si è seduto sulla panca attendendo il suo turno e, siccome ha visto presentarsi un avvocato d’ufficio, ha chiesto perché il giorno prima non avessero chiamato il suo legale di fiducia (che è poi lo stesso legale della nostra famiglia). I carabinieri sono come caduti dalle nuvole e di questo lui si è molto adirato, pronunciando queste testuali parole: «Vi avevo chiesto ieri sera di chiamarlo. Perché non lo avete chiamato?». I carabinieri hanno mostrato indifferenza […] e, praticamente, non gli hanno dato risposta.
Attenzione: questo è un punto essenziale. A quattordici ore dal suo fermo, Cucchi ha già sollecitato per due volte l’assistenza del proprio legale di fiducia. Che non risulta avvisato. Tale omissione, che costituisce una vera e propria illegalità, sarà determinante, come vedremo oltre. Il giudice rinvia la causa al 13 novembre e decide per la custodia cautelare in carcere (Stefano aveva dei precedenti poco significativi e potevano essergli concessi gli arresti domiciliari. Quanto ciò che risultava scritto nel verbale di arresto, cioè che Cucchi era senza fissa dimora, ha influito sulla decisione del giudice?).
Il padre non è l’unico ad accorgersi dei lividi sul suo volto, gli agenti di polizia penitenziaria che lo prendono in custodia ritengono necessario farlo visitare dal medico del tribunale prima di trasferirlo al carcere di Regina Coeli. Qui, ora del referto 14.05, vengono rilevate «lesioni ecchimotiche in regione palpebrale inferiore bilateralmente […] e lesioni alla regione sacrale e agli arti inferiori», queste ultime non visionate, ma solo dichiarate da Stefano Cucchi, in quanto lo stesso rifiuta di farsi controllare. La foto segnaletica scattata al momento dell’ingresso in carcere evidenzia chiaramente i segni sul volto e Cucchi, com’è prassi, viene sottoposto alla visita medica di primo ingresso, che darà lo stesso risultato: «ecchimosi sacrale coccigea, tumefazione del volto bilaterale orbitaria, algia della deambulazione».
Le sue condizioni sembrano aggravarsi, il dolore inizia a farsi più insistente, così viene deciso il trasporto all’ospedale Fatebenefratelli, dove potranno essere predisposti ulteriori accertamenti: in particolare radiografie alla schiena e al cranio non effettuabili in quel momento all’interno dell’istituto penitenziario. Il risultato di quegli esami al Fatebenefratelli sarà: «frattura corpo vertebrale L3 dell’emisoma sinistra e frattura della vertebra coccigea». In ospedale gli viene proposto il ricovero, la prognosi è di venti giorni con indicazione di riposo assoluto a letto e immobilità. Stefano rifiuta e, contro il parere dei sanitari, firma per le dimissioni e viene riportato a Regina Coeli.
La mattina dopo, sabato 17 ottobre, i medici del carcere che lo visitano nuovamente giudicano incompatibile il suo stato di salute con la permanenza nell’istituto penitenziario. Viene accompagnato ancora una volta al Fatebenefratelli. I medici ravvisano l’assoluta necessità di trattenerlo e questa volta il paziente non si oppone. Come logica e terapia vorrebbero, Cucchi è destinato dunque al ricovero in un reparto del Fatebenefratelli, nel regime di sorveglianza che il magistrato volesse imporre. Ma, per volere di un funzionario del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (condannato a due anni), che insisterà e firmerà per il suo trasferimento, andando personalmente al Pertini al fine di convincere il personale sanitario, Cucchi verrà ricoverato nel reparto detentivo di quell’ospedale (anche se quel reparto non è il più attrezzato per prendere in carico pazienti con un quadro clinico tanto complesso).
Che la decisione non sia stata lineare né priva di contrasti è provato, oltre che dall’attesa di molte ore prima del ricovero, anche dalle dichiarazioni di una infermiera che confermerà agli inquirenti la singolarità di quell’intervento definendolo «un procedimento assolutamente fuori dall’ordinario. In tanti anni di lavoro qui non avevo mai vista tanta urgenza». I genitori vengono avvertiti solo verso le 22: si precipitano in ospedale, se non possono vedere Stefano, vorrebbero almeno parlare con i medici per sapere cosa è successo, dato che non hanno ricevuto alcun tipo di informazione. Da quel momento e da quel luogo si snodano due vicende parallele: la prima riguarda il travaglio subito in quei giorni dai genitori di Cucchi, sbattuti da un ufficio all’altro e da un silenzio all’altro. Dai loro racconti è facile capire quale sia stato il grado di rigidità e di insensibilità manifestato nei loro confronti. La seconda vicenda riguarda invece gli ultimi giorni di vita di Cucchi, ricostruibili solo attraverso i documenti clinici e le testimonianze di chi, a vario titolo, ha avuto modo di entrare in contatto con lui. Partiamo dalla prima. Rita e Giovanni Cucchi, appena avuto notizia del ricovero di Stefano, vanno all’ospedale Sandro Pertini, vogliono portargli un cambio di vestiario, sperano di poter avere qualche informazione sul suo stato di salute. Alla richiesta di vedere il figlio, il piantone di turno quella sera risponde: «Questo è un carcere e non sono possibili visite». Chiedono come sta il figlio, li fanno aspettare ma l’unica risposta che ottengono è: «Tornate lunedì, dalle 12 alle 14, orario di visita dei medici».
Tornano a casa e, comprensibilmente, passano la domenica in preda all’angoscia, aspettando l’indomani per andare in ospedale e finalmente avere qualche notizia. Lunedì, alle 12 sono davanti alla porta del reparto e citofonano per salire. Li fanno entrare, e dopo la verifica dei documenti di identità sono costretti ad aspettare. Poi una vicesovrintendente dice loro che non avrebbero potuto parlare con i medici, l’autorizzazione non era ancora arrivata. «Tornate domani, sicuramente sarà pronta.» Non riescono neanche a lasciargli la borsa con gli indumenti: viene infatti detto loro che lì, Stefano, ha già tutto quello che gli occorre. Possono solo lasciargli dei cambi di biancheria intima, che, però, Stefano non indosserà mai: nessuno lo ha cambiato e, data l’impossibilità per Stefano di muoversi, pare improbabile che potesse farlo da solo. Stefano Cucchi morirà con ancora indosso gli indumenti con cui era uscito da casa il 15 ottobre. Alle insistenti richieste dei genitori di sapere almeno il motivo del ricovero la donna risponde semplicemente «il ragazzo è tranquillo».
Rassegnati e impotenti, si allontanano. Il giorno dopo, stessa scena. Si ripresentano al Sandro Pertini, come lunedì, all’ora della visita. Questa volta non vengono nemmeno fatti entrare. La risposta che sentono uscire dal citofono li lascia storditi: «Ma quale autorizzazione, qui non è arrivata. Siete voi che dovete andare a fare richiesta al tribunale e poi farvela convalidare da Regina Coeli». Come è possibile che nei tre giorni precedenti nessuno si sia preoccupato di dare istruzioni precise a quei genitori che in più di un’occasione, e insistentemente, avevano chiesto di poter avere informazioni sullo stato di salute del figlio? Chi, tra medici agenti e funzionari della polizia penitenziaria, ha il dovere di informare i congiunti sulle pratiche da assolvere per poter parlare con i medici, per fare i colloqui, per lasciare pacchi o oggetti personali? Il carcere è un mondo difficile da conoscere, chi lo incontra per la prima volta è disorientato da regole, consuetudini, obblighi e divieti a cui bisogna attenersi. Per chi osserva da fuori e non ne ha esperienza è impossibile arrivare intuitivamente a comprenderne i meccanismi e i funzionamenti, ci vuole tempo. E i genitori di Stefano Cucchi quel tempo non l’hanno avuto e mai avrebbero immaginato di doversi procurare un’autorizzazione per ricevere, da un medico, informazioni sullo stato di salute del figlio.
Mercoledì mattina Giovanni Cucchi va in tribunale, ottiene il permesso per il colloquio, non riesce però a farlo convalidare dal carcere di Regina Coeli, l’ufficio preposto a queste pratiche chiude alle 12.45. Il giorno dopo, Giovanni Cucchi si reca a Regina Coeli, sua moglie Rita resta ad aspettarlo a casa, prendendosi cura della nipotina di un anno, figlia della figlia Ilaria, che ha la febbre. Verso mezzogiorno, suona il citofono, la signora Rita risponde a un carabiniere che le chiede di seguirlo in caserma. Lei non può, deve rimanere a casa con la bambina, il carabiniere dice che sarebbe tornato da lì a poco. Sono le 12.30, suonano di nuovo alla porta: «Signora dobbiamo farle firmare dei documenti», Rita li lascia entrare, i carabinieri le dicono di posare la bambina nel box, la fanno sedere, le danno dei fogli. «Cosa devo firmare?» «La notifica del decreto del pubblico ministero che autorizza la nomina di un consulente di parte per eseguire l’autopsia.»
È in questo modo che Rita Cucchi viene a sapere della morte del figlio Stefano, con un foglio su cui c’è scritto che può nominare un perito per l’autopsia. Viene avvertito anche Giovanni Cucchi che nel frattempo – e dopo 111 ore dal ricovero al Pertini – è a Regina Coeli a svolgere l’ultima incombenza per poter ottenere il colloquio. Ormai, non servirà più. Fuori dal reparto protetto del Sandro Pertini incontrano un medico, la fermano, le chiedono cosa sia successo. La risposta che ricevono è agghiacciante: «Vostro figlio si è spento». Un ragazzo di 31 anni, fino a una settimana prima pieno di vita, come può «spegnersi»? Cosa è successo in quell’ospedale per giustificare una morte simile? Vediamo.
Stefano Cucchi presenta una frattura al corpo vertebrale L3 e una frattura della vertebra coccigea. Non riesce a camminare, deve stare immobile e a riposo. Ha difficoltà nella minzione, gli applicano un catetere. In cinque giorni dimagrisce esattamente di quindici chili. Come si può deperire in questo modo in un ospedale, senza che nessuno tra medici e infermieri intervenga? Nel diario clinico, le annotazioni su Cucchi sono molto scarse, come se di lui, in quei giorni, non si fosse occupato seriamente alcuno. L’ortopedico che lo visita il 21 ottobre annoterà sul diario clinico che Cucchi ha bisogno di riposo a letto per quindici/venti giorni e che l’ospedalizzazione non è strettamente necessaria.
Sembra evidente, quindi, che le sue condizioni, il giorno precedente al decesso, fossero non eccessivamente gravi e comunque riconducibili unicamente a un trauma da frattura.
Come è potuto accadere che sia morto? Nel diario clinico, tra le poche cose annotate, troviamo una prima spiegazione: per ben due volte, in quelle pagine, c’è scritto che «il paziente rifiuta di alimentarsi ed idratarsi finché non avrà modo di parlare con il proprio avvocato o con un operatore della comunità terapeutica Ceis» (in una delle note è precisato che questo comportamento viene tenuto dal momento del suo ingresso in ospedale). Stefano Cucchi, quindi, ha deliberatamente e volontariamente attuato uno sciopero della fame per ottenere il rispetto di un suo
fondamentale diritto: quello alla difesa. Che gli è stato negato fin dal primo momento (giova ricordarlo: sin dal primo ingresso nella caserma dei carabinieri). E non ha solo deciso di attuare questa forma di protesta, ma la ha dichiarata, in modo chiaro e comprensibile, a quanti si sarebbero dovuti occupare di lui. Sicuramente non immaginava che avrebbe perso la vita, probabilmente non gli è stato detto quanto fosse pericoloso nelle sue condizioni – e dopo aver subito violenze fisiche – astenersi dal cibo e dall’acqua e nessuno, evidentemente, ha preso sul serio il progressivo peggioramento del suo stato di salute.
Stefano Cucchi stava pacificamente protestando attraverso il rifiuto di ogni trattamento finché non fossero stati rispettati i suoi fondamentali diritti. E invece, leggendo la documentazione clinica, sembrerebbe che il suo decesso sia stato un evento fortuito e imprevedibile. Sul certificato di morte, redatto il 22 ottobre, si legge:
«Si certifica che il signor Stefano Cucchi è deceduto per presunta morte naturale in data odierna alle ore 6.45».24 A distanza di 17 mesi da quella morte, alla fine del marzo 2011, vengono rese note le motivazioni della condanna del dirigente del Prap Claudio Marchiandi. È una lettura sconcertante: Stefano Cucchi «doveva essere necessariamente internato» nella struttura protetta dell’ospedale Pertini per «evitare che soggetti estranei all’amministrazione penitenziaria prendessero cognizione delle tragiche condizioni in cui era stato ridotto» e che il fatto «venisse portato a conoscenza dell’autorità giudiziaria». Al Pertini Cucchi sarebbe rimasto «al riparo da sguardi indiscreti» e sottratto «intenzionalmente a tutte le cure di cui aveva bisogno». Non solo: «Le condizioni fisiche di Stefano» scrive ancora il giudice dell’udienza preliminare, Rosalba Liso «erano palpabili e visibili a ciascuno, erano ben note nel contesto della polizia penitenziaria per la pluralità di soggetti che l’avevano visto ed accompagnato. Non c’era spazio a dubbi di sorta in ordine al fatto che Stefano fosse stato picchiato». Di conseguenza, il comportamento del funzionario condannato mirava a disporre l’ingresso di Cucchi in un reparto in cui «non doveva assolutamente entrare».
Dunque, Cucchi doveva essere isolato in un luogo dove fosse più facile nascondere le gravi condizioni in cui versava. Condizioni ben note a Marchiandi che avrebbe cercato di «eludere le indagini “occultando” la circostanza che Stefano fosse stato picchiato e che aveva appreso con ragionevole certezza, duole dirlo, in primo luogo dal direttore del carcere Mariani». Questa e altre considerazioni inducono il gup ad affermare che la vicenda di Stefano Cucchi «è connotata da indubbia gravità poiché si inserisce in un contesto di generale malcostume sociale e di omertà che […] apparirebbe determinato da mera leggerezza, mentre disvela una condotta allarmante». Fino a far scrivere al magistrato del coinvolgimento di numerosi soggetti, «molti non ancora scoperti per chiara omertà». La conclusione è netta: «Stefano era nelle mani dello Stato e nelle mani dello Stato è deceduto».
In questo quadro, la catena delle responsabilità appare nitida. Stefano Cucchi ha prima subito violenze e poi è stato letteralmente abbandonato a se stesso: innanzitutto dalle istituzioni che lo avevano in custodia e che hanno come dovere imprescindibile e prioritaria ragion d’essere la tutela dell’incolumità di chi viene loro affidato; e, successivamente, da una lunga serie di soggetti e apparati che, quando pure non colpevoli delle condizioni in cui si trovava, avrebbero dovuto operare per rimuovere quelle stesse condizioni. E poi, quei soggetti, dei quali «molti non ancora scoperti». Per concludere una riflessione.
La vicenda di Stefano Cucchi e la sua dolente via crucis attraverso le stazioni rappresentate da ben dodici luoghi istituzionali evidenzia come intorno a lui – e, come abbiamo visto, a tanti altri – si sia saldato un sistema integrato e una sorta di circuito esteso e chiuso, dove finiscono i gruppi e gli individui più deboli, e dove la differenza tra reclusione e vigilanza, sanzione e cura, repressione e assistenza può risultare assai labile. Caserma e carcere, tribunale e reparto detentivo, pronto soccorso e infermeria, camera di sicurezza e – per chi ha la ventura di essere straniero – centro di identificazione ed espulsione. In quel circuito del sorvegliare e punire, ruoli di custodia e repressione e funzioni di disciplinamento e assistenza sembrano intercambiabili, tendono a sovrapporsi e comunque a combinarsi. Il personale sanitario del Pertini rivela, al di là di ogni dubbio, una vocazione custodiale assai più pronunciata di quella terapeutica. E in tante altre vicende – da quella di Giuseppe Uva a quella di Francesco Mastrogiovanni – risulta determi- nante e letale il ricorso abusivo al Tso. Infine, la storia di Cucchi, al di là delle contraddizioni ravvisabili nei rinvii a giudizio, e dell’esito imprevedibile del dibattimento, ha mostrato come sia possibile sottrarre al silenzio (almeno alcuni degli) avvenimenti che accadono all’interno dei luoghi di privazione della libertà. Che restano tuttavia, in gran parte, tenacemente celati al nostro sguardo.
***
Il 5 maggio è uscito per il Saggiatore Quando hanno aperto la cella, di Luigi Manconi e Valentina Calderone
Luigi Manconi (Sassari 1948) insegna Sociologia dei fenomeni politici presso l’Università Iulm di Milano ed è presidente dell’associazione A Buon Diritto. È stato portavoce nazionale dei Verdi, senatore per due legislature e sottosegretario di Stato alla Giustizia nel 2° governo Prodi. Ha scritto per Il Messaggero, il Corriere della Sera, La Stampa e La Repubblica; attualmente collabora con Il Sole 24 Ore e a l’Unità.
È membro dell’assemblea nazionale del Partito democratico e della direzione dell’Associazione Luca Coscioni e di Nessuno Tocchi Caino. Ha pubblicato, tra gli altri: Solidarietà, egoismo. Buone azioni, movimenti incerti, nuovi conflitti; I razzismi possibili
e I razzismi reali (con Laura Balbo); Storie di lotta armata
(con Raimondo Catanzaro), Il dolore e la politica. Accanimento terapeutico, testamento biologico, libertà di cura
(con Andrea Boraschi); Terroristi italiani. Le Brigate Rosse e la guerra totale 1970-2008; Un’anima per il PD. La sinistra e le passioni tristi (Igloo)
.
Dal 2008 dirige il sito Innocenti Evasioni, e Italia Razzismo.
Valentina Calderone è ricercatrice per l’associazione A Buon Diritto.