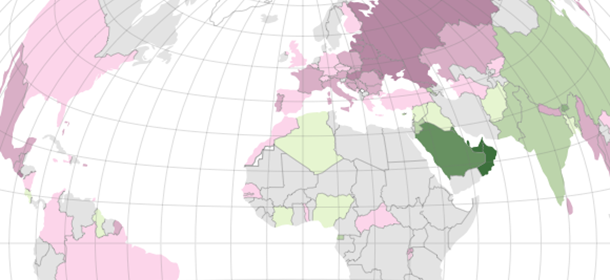A cosa ci serve “Leaving Neverland”
Nel documentario Leaving Neverland, diretto dal britannico Dan Reed e prodotto da HBO e Channel4, due ex amanti bambini di Michael Jackson raccontano come sono andate davvero le cose tra loro e il cosiddetto “re del pop”. Il film è stato presentato al Sundance Festival a gennaio, e da allora sta suscitando reazioni molto accese ovunque sia trasmesso. È normale. Leaving Neverland è molto forte. È una testimonianza di quattro ore che, soprattutto nella prima parte, fa venire i brividi. Voi stessi avete provato un fastidio vicino all’indignazione leggendo le parole “amanti bambini” qui sopra. Lo so. Le nostre coscienze preferiscono che si dica sempre, in modo inequivocabile, anche a costo di non dire nient’altro, che James Safechuck e Wade Robson sono le vittime di un mostro. L’istinto è proprio quello: dire perfino ad alta voce la parola “mostro”; indicare Michael Jackson come disumano, cioè diverso da noi; identificare i due uomini come vittime e solo vittime; esprimere un giudizio inequivocabile di condanna nei confronti del grande, compassione nei confronti dei piccoli, girare la testa dall’altra parte e cercare di prendere sonno.
Partiamo da un presupposto di fondo che riguarda il documentario e noi. James Safechuck e Wade Robson hanno sporto denuncia nei confronti degli eredi di Michael Jackson, e forse un giudice stabilirà che siano risarciti. Il fatto che esista una prospettiva di ritorno economico, come per qualsiasi altra causa civile in cui un diritto negato si trasforma in una compensazione, non rende poco credibile la testimonianza o la denuncia. Questo argomento, che si sente molto in giro, è ridicolo: leviamolo di torno. I due sono effettivamente molto credibili. Di più: dopo anni di verità poco comprensibili, mezze testimonianze, gente pagata per tacere e troppo coinvolta per dire la verità, finalmente ci arriva un racconto dei fatti che è compatibile con quello che sappiamo del mondo. Sono fatti terribili – d’ora in avanti eviterò di ripeterlo – ma sono anche credibili e coerenti. Michael Jackson ha abusato ripetutamente di alcuni bambini. Lo sospettavamo. Adesso lo sappiamo. È successo, e la cosa migliore che possiamo fare è prenderne atto.
Se Michael Jackson ci fosse ancora, avremmo la consolazione di pensare a una “galera” (la versione retorica del carcere), luogo nel quale ciò che ci sembra impossibile da capire può stare rinchiuso al sicuro. Ma, per fortuna nostra, gli sviluppi morali e legali del caso Michael Jackson sono una perdita di tempo. Perché Michael Jackson è morto nell’estate del 2009, solo al mondo e circondato da approfittatori di servizio, di collasso cardio-respiratorio indotto da farmaci oppioidi, cioè di overdose. Le vittime di MJ sono persone adulte, certo sofferenti, che hanno avuto un’infanzia e un’adolescenza incredibili. Hanno deciso di raccontarla per questa ragione, a quanto pare: per la sua incredibilità, la sua incondivisibilità. E se noi adesso prendiamo tutta questa fatica e la usiamo solo per dire “Poverini! Che mostro! Bruciamo i dischi!”, ecco, è uno spreco. Anche perché, per quanto una voce dentro di noi continui a ripeterci che in questa storia ci sono e ci devono essere un carnefice e delle vittime, con i nostri occhi vediamo che la questione non è così semplice.
Leaving Neverland ha, quasi per caso, delle caratteristiche che lo rendono un documento unico. Il fatto che c’entri Michael Jackson, uno sconosciuto che abbiamo avuto in casa per anni, fa sì che siamo curiosi di passare del tempo a sentire storie così difficili da mandare giù. Il fatto che sia un documentario senza voci esterne, approfondimenti, giornalisti e psicologi, toglie di torno le valutazioni, e fa sì che quella voglia di dirsi orripilati si possa mettere un po’ da parte. Il fatto che a parlare siano solo i protagonisti della storia ci permette di ascoltare il loro racconto, non la sintesi dei fatti suffragata dal loro racconto, così che le sfumature e le complessità rimangono tali, equazioni complesse che non sappiamo e forse non dobbiamo risolvere.
La prima cosa notevole è che i due non parlano come vittime: parlano come due persone che si sentono in colpa. Se raccontassero un vecchio reato commesso in gioventù, avrebbero lo stesso tono. Perché quelle raccontate sono delle relazioni abusanti, non degli stupri furtivi. L’abuso, che ci piace pensare sempre come un atto molto riconoscibile e visibilmente violento, non ha nella realtà solo quella forma “facile”, identificabile immediatamente come tale, come fosse uno schiaffo. È più complicato di così. Sentiamo dalle parole dei due quanto si sentissero speciali, amanti, fidanzati, inseparabili superamici, e si comportassero come tali, per quanti brividi la cosa possa suscitarci. Dall’altra parte non c’era una menzogna, una recita: effettivamente erano persone speciali cui Jackson dedicava moltissime attenzioni e affetto. Wade e Safechuck non raccontano solo atti sessuali. Quelli sono un effetto. È un effetto fondamentale per il grande, per i piccoli, per la legge, perché è indubbio che se non ci fossero stati sarebbe tutto diverso. Ma c’è molto altro.
Le immagini che vediamo a copertura delle testimonianze confermano chiaramente l’impressione di un rapporto furtivo e insieme sotto gli occhi di tutti, vissuto come un segreto inebriante. Ma la natura violenta e coercitiva degli abusi è sempre negata da tutti: vittime, carnefici, famiglie e vicini. Un altro me di Claudio Casazza è un piccolo documentario che racconta la terapia di gruppo fatta al carcere di Bollate con i condannati per reati sessuali: un esperimento che puntava a pensare al recupero di queste persone, odiate dentro e fuori, destinate a tornare nel mondo dopo avere scontato la pena, bisognose di essere almeno gestite. La cosa che colpisce di più del documentario è il fatto che siano tutti in negazione. Nessuno sa o ammette di avere violentato. Tutti sostengono di essere vittime del sistema, dei giudici, della macchinazione di adolescenti inaffidabili. Quello che succede qui è una variante vertiginosa, gigantesca, con le telecamere e le esibizioni sul palco davanti alla folla oceanica, dello stesso identico meccanismo.
Legato a questo aspetto c’è un altro elemento della storia di Michael Jackson che può venirci utile: è il meccanismo del gruppo sociale piramidale, con un capo e molti adepti. Molti contesti famigliari o lavorativi possono essere assimilabili a una piramide, e quello di Michael Jackson e i suo seguaci somiglia a una setta. Gli elementi ci sono tutti. C’è un capo carismatico e misterioso che si esprime in modo oracolare, parlando sempre meno e diventando dispensatore di amore puro. Il capo è svincolato dal mondo e dalle preoccupazioni quotidiane di tutti. Molti lo adorano, si vestono come lui, pensano che sia un riferimento quasi irraggiungibile. Non ha nemmeno amici, se non Liz Taylor e una scimmia. Anche qui esiste, come in tutte le sette e i gruppi sociali con un grande capo, come anche nella setta di Osho raccontata nel documentario Wild Wild Country, un cerchio magico. Tutti i seguaci vedono i membri del cerchio magico come qualcosa di più, come una categoria di eletti degni di godere dell’energia diretta che il guru emana da vicino. Chi è parte del cerchio magico deve ritenersi fortunato come lo ritengono tutti. Dire la verità sul capo significa distruggere tutto, fare a pezzi le convinzioni, i riferimenti, la stima, la struttura stessa del gruppo. È proprio come nel film Festen di Thomas Winterberg, dove la denuncia degli abusi in famiglia passa per la distruzione della famiglia stessa. O come il caso di Jimmy Savile, figura di riferimento della BBC e della cultura popolare britannica, che nessuno ebbe il coraggio di smascherare in vita come stupratore seriale, anche se moltissimi sapevano. Insomma o sei pronto a perdere tutto, o stai zitto. E in genere stanno tutti zitti.
Di questo Leaving Neverland bisogna parlare e si parlerà. Ognuno ne parlerà con i propri amici in privato, lasciandosi andare a commenti e gag per esorcizzare quello che ha visto. Gli articoli si occuperanno – si stanno occupando – dei processi, delle testimonianze, delle menzogne, dei soldi e delle canzoni che le radio non suonano più. E va benissimo. Ma quello che più mi ha colpito è vedere, forse per la prima volta senza la nebbia del giudizio morale a offuscare tutto, come una relazione abusante sia perfettamente compatibile con l’innamoramento, con il sesso fatto quotidianamente, con la negazione assoluta da parte di tutti, addirittura con l’adorazione collettiva. Scambiare queste caratteristiche per follie legate al caso Michael Jackson secondo me è un errore. Le scimmie, le giraffe, i concerti negli stadi e l’aereo privato, quelle sì, sono condizioni particolari. Ma a giudicare da quel poco che, per ragioni di tutela delle vittime e tabù sociale, ci raccontano dei casi di pedofilia, ci sono più cose in comune con i casi di abuso normali, che quasi sempre avvengono in famiglia, che stranezze eccentriche da “re del pop”. La cornice, quella sì, è molto pittoresca, ma il quadro faremmo bene a guardarlo con una certa attenzione. Perché è un aspetto dell’umanità che esiste, è sempre esistito, e di cui non vogliamo sapere nulla. Ci conviene invece cercare di capirlo, visto che siamo umani anche noi, per non essere preda degli stereotipi, delle facilonerie polemiche e della nostra stessa paura.
– Luca Sofri: Su Leaving Neverland