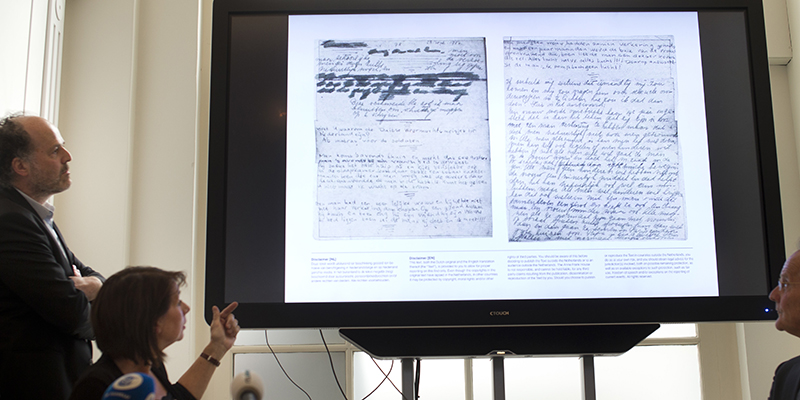La vera storia della parola panettone
Mangiare il panettone, oppure arrivare al panettone. Quante volte abbiamo sentito usare queste espressioni dai media, specialmente dai quotidiani, nel fare previsioni su compagini di Governo o presidenti del Consiglio, ministri o leader di partito, amministratori delegati o allenatori di una squadra di calcio? Riusciranno a resistere, a restare in carica, a conservare il posto – questo il senso – fino a Natale?
La storia del più tipico dei dolci natalizi, che quest’anno ha registrato un boom nel Regno Unito, dove già nel 2016 aveva superato il pudding (il tradizionale budino inglese consumato nelle varie festività), ha il suo punto di partenza, com’è noto, nella città di Milano. L’indiscusso primato meneghino in materia era risaputo (e riconosciuto) già nell’Ottocento:
«Fra le lecconerie squisite della mensa popolare milanese stà in prima linea la classica trippa che, unita al risotto e al panattone, compone il blasone alimentare di quel buon pastricciano che è il Meneghino. Ed almeno la domenica, ogni fedele ambrosiano è obbligato offerirla in sagrificio alla rubiconda Gastrea» (Guido Bazzoni, L’alimentazione e le risorse economiche del popolo minuto di Milano. Di alcune epopee nazionali e del loro processo formativo, Milano, Tipografia G. Bernardoni, 1868, p. 31).
«Idolatra del risotto e della trippa, pacchione per eccellenza fino ad esser fatto segno all’aspra ironia foscoliana, il Milanese […] ha una pingue tradizionale supremazia gastronomica rappresentata dal risotto e dal panattone» (Il popolo italiano. Studi politici per l’avvocato Angelo Mazzoleni deputato al Parlamento nazionale, Milano, Tipografia Francesco Vallardi, 1873, p. 136 sg.).
La parola era comparsa in Foscolo in tre epistole dell’inizio del secolo, indirizzate a tre diversi destinatari:
«Eran più mesi ch’io non rideva tanto, se vuoi eccettuare la novella della Chiesa, per cui la Scimmiotta mi fece ridere quando m’andava mangiando il panattone» (Milano, 1802; ad Antonietta Arese);
«Per me, che fuggo quanto posso dalla mensa degli altri, e che amo di pranzare quando, come, e dove mi pare e piace, non posso nondimeno ne’ giorni di Natale e del primo dell’anno andare all’osteria, o rodere il mio pane ad una tavola solitaria. Non v’è giorno, n[é] sera ch’io mi ricordi delle dolcezze della mia famiglia e del tetto materno con amarissima tenerezza e con desiderio veemente, quanto la vigilia del Natale che mi ricorda la cena fra’ miei parenti, e le gioie fanciullesche, e la contentezza di mia madre nel vedersi i figli d’intorno a lei, e l’illuminazione di tutta la tavola, e il panattone e tutte le usanze famigliari» (Milano, lunedì sera, gennaio 1808; a Marzia Martinengo);
«Oggi è l’unico giorno ch’io mi sia uscito di casa dopo una settimana e più di carcere volontario – e domani ricomincerò. Bisogna pure ch’io termini. Ma oggi s’è fatto baldoria: […] col rito degli avi abbiamo trinciata una pollina arrosto, e distribuito a’ nostri ospiti il panettone» (Pavia, lunedì 26 dicembre 1808; a Ugo Brunetti).
Gli ingredienti del dolce, frutta candita a parte, erano più o meno quelli del panettone odierno:
«Panattón o Panatton de Natal. […] Sp[ecie] di pane di frumento addobbato con burro, uova, zucchero e uva passerina (ughett) o sultana, che intersecato a mandorla quando è pasta, cotto che sia risulta a molti cornetti. Grande e di una o più libbre sogliamo farlo soltanto per Natale; di pari o simil pasta ma in panellini si fa tutto l’anno dagli offellai e lo chiamiamo Panattonin. – Nel contado invece il Panatton suol essere di farina di grano turco e regalato di spicchi di mele e di chicchi d’uva» (Francesco Cherubini, Vocabolario milanese-italiano, Milano, Imperial Regia Stamperia, 1839-1843, 4 voll., III, M-Q, 1841, alla voce).
Inizialmente piatto come una focaccia, diverso da altri pani dal nome simile o perfino identico («Schiacciata alla livornese, dicesi anche panattone , focaccia a forma di pan tondo spugnosa , fatta con birra e anacini, cotta in forno sinch[é] fa la crosta di color marrone scuro», Costantino Arlìa, La parlata fiorentina. Dialoghi degli artigiani, Milano, Paolo Carrara di Carlo Somaschini, 1876, p. 136), il panettone avrebbe via via assunto la caratteristica foggia a forma di cappello da cuoco – o di cupola – con cui oggi siamo soliti consumarlo sulle nostre tavole.
Secondo una storia fantasiosa, che ricava le sue ragioni dal nome milanese dell’uvetta ricordato da Cherubini, a creare il panettone sarebbe stata una suor Ughetta,
«anzi due: la prima, superiora di un povero monastero nel contado milanese, avrebbe visto magicamente arricchirsi il pane in seguito alla sua benedizione; la seconda, maestra cuciniera, lo avrebbe più prosaicamente arricchito per rallegrare le consorelle. In correlazione all’ughett viene scomodato anche Ughetto degli Atellani, un giovane di nobile schiatta che s’inventa un pane speciale, via via più ricco, per far breccia nel cuore della figlia di un fornaio» (Giuseppe Sergio, Il panettone, ovvero Milano alla conquista del Natale, in Massimo Arcangeli, a cura di, Peccati di lingua. Le 100 parole italiane del Gusto, Soveria Mannelli (CZ), Rubbettino, 2015, pp. 201-204, a p. 203).
Un’altra leggenda narra di un tal Toni, che avrebbe inventato il panettone – in una delle tante versioni circolanti – perché il dolce da servirsi alla tavola del Moro, Ludovico Sforza, era andato bruciato. Toni aveva deciso di rimediare preparandone un altro con quel che aveva a portata di mano, e l’operazione gli era riuscita. Il duca di Milano aveva apprezzato e il dolce, da quel momento in poi, si sarebbe chiamato pan de Toni.
Una terza ricostruzione fantastica racconta così la storia del panettone:
«Il panattone nostro deriva da quel vecchio pane rotondo, che fin dal 1000 si fabbricava a Milano, e le cui croste si riponevano per tutto l’anno. Uno scrittore ecclesiastico, Monsignor Macri, nel suo Dizionario, alla parola xerophagia, discorrendo dell’astinenza degli antichi monaci, fa derivare l’origine del pan giallo dei Romani e del panettone dei Milanesi dall’uso di frutta secca, che nei primi tempi del cristianesimo si faceva nei giorni di magro. Il pan giallo è un miscuglio di farina e di zafferano con mandorle, nocciuole, uva passa e fichi secchi.
Il panettone ha soppresso i fichi e le nocciuole, ma ha conservato la dorata uva passa e l’aromatico cedro. – Ecco ora la storia della parola panettone. È noto come gli statuti antichi di corporazione proibissero ai fornai, che impastavano pian giallo o di mistura (de mei) di fabbricare pan bianco (de micca) fuori che il giorno di Natale per darlo in dono ai proprî clienti. Il popolo di Milano chiamava il pane di solo frumento pan de ton, ossia pane di lusso. I fornai che servivano le ricche famiglie non potevano regalare pan bianco a chi lo mangiava quotidianamente, epperò introdussero le focaccie fatte con fior di farina di frumento, condite con burro, zuccaro e zibibbo. Soppressi gli statuti di corporazione, e generalizzato l’uso del pan bianco i compratori tutti furono regalati della focaccia già esclusiva dei ricchi e nobili e plebei divennero eguali almeno un giorno dell’anno nel mangiare il pan de ton, nome che a poco a poco si corruppe in panetton. La focaccia di Natale dei prestinai passò in dominio dei pasticcieri, detti in Milano dal vocabolo latino ofela (focaccia) offellai» (Natale Capodanno Epifania. Usi e leggende. A. P., Milano, Tipografia Lamperti di G. Rozza, 1885, p. 10).
Sulla nascita della parola, su cui si sono (inutilmente) versati i classici fiumi d’inchiostro, credo ora, alla luce degli esiti delle mie ultime ricerche, di poter esprimere un giudizio definitivo. Il panettone non è altro che un “grosso pane”. In un testo del 1805 è presentato, più esattamente, come l’esito della realizzazione di vari tipi di pane fatti di una farina di spighe, pura o mescolata (onde evitare che si “stritoli”) a semi di mais, farina di grano o altre farine:
«Tra le varie sostanze vegetali, che sonosi messe a cimento nella panizzazione, merita una particolare menzione […] quella che forma la spica, altrimenti da noi detta panettone della meliga comune. Già si sapeva che dal fusto di questa pianta si può trar dello zucchero; e di questo il sapore si manifesta ancora di più nelle spiche quando sono tenere ancora. Egli era ovvio in seguito a queste osservazioni il riputare […] che alcuna qualità nutritiva, non disgiunta da sapore non dispiacevole, conservare potesse la spica anco a maturità pervenuta. Nissun per altro finora ne avea preso a considerare questa facoltà nutritiva, e tanto meno pensato ad applicarla alla panizzazione. Un nostro concittadino presentò al Governo alcune osservazioni a questo proposito, che furono trasmesse a noi. […] Dalle ricerche […] risultò che la farina di queste spiche contiene una quantità ragguardevole di amido, e quindi che è assai nutritiva, e può servire di alimento e agli uomini e agli animali. Ma è risultato […] che essa contiene poco glutine; la qual circostanza la rende […] poco atta alla fermentazione, per lo che […] [si] consiglia aggiugnervi un po’ di lievito comune quando si voglia ridur in pane» (“Memorie della Società di Agricoltura di Torino”, VII, pp. 43-44).
Più di mezzo secolo dopo un bisettimanale goliardico milanese avrebbe riportato in prima pagina questa “ferale” notizia:
«Il sacrifizio è compiuto!
Fagiani, pollini, galline, anitre, boccaccie, salsiccie, torrone, panettone, ecco le capre espiatorie del Natale. – Queste innocenti vittime sgozzate, arrostite, stritolate, fecero il loro trapasso nelle rispettive epe dei buoni Ambrosiani, i quali offersero anche in tale occasione un’altra piccola prova al signor di Lamartine che l’Italia non è precisamente la terra dei morti. […] La statistica delle indigestioni dopo i pranzi del Natale è interminabile […]. Un becchino, mio intimo amico, mi confidò essersi aumentata la popolazione del Cimitero di circa diecimila individui, vittime dell’indigestione, fra le quali figurano in prima lista i procuratori, gli avvocati e qualche illustre membro della troppo nota Società delle Indie.
– Mi raccontò altresì il fatto seguente:
Venerdì mattina la serva del signor N. portava, come al solito, il caffè in letto al suo padrone, verso le sette, quando con sua somma sorpresa lo ritrovò morto. – Non sapendo a qual ragione attribuire questo luttuoso avvenimento, fu trasportato il cadavere all’ospitale, e fattagli l’autopsia gli fu trovato l’esofago tutto pieno di panattone e di torrone di Cremona. Il panattone forzatamente ingoiato avea invaso persino le regioni del cervello, le mandorle del torrone erangli entrate nella milza, per cui i medici all’unanimità dichiararono che l’infelice era morto per mancanza di respiro. […] Ad onta di tali sventure viviamo allegramente. Abbiamo in prospettiva il capo d’anno, l’epifania, e il carnovale, tutte occasioni eccellenti per farci onore a tavola!» (“La Cicala politica. Giornale umoristico con caricature”, anno II°, num. 104, 29 dicembre 1861).
Negli anni Venti del ’900 un imprenditore di Gessate, che nel 1919 aveva aperto a Milano un laboratorio di arte pasticciera, comincia ad abbinare il panettone al duomo. Era Angelo Motta, fondatore dell’azienda omonima. Nel 1934, in uno storico manifesto, una grande M avrebbe sancito la “santa alleanza” fra Motta, Milano e Mussolini. Tre M che riunivano, in nome del panettone, l’Italia di allora.