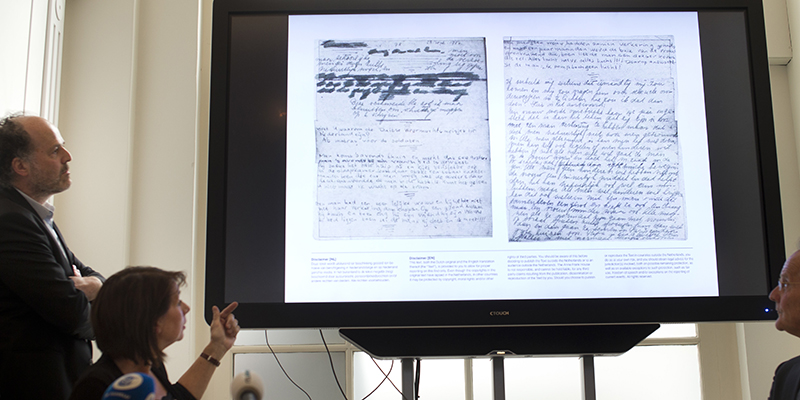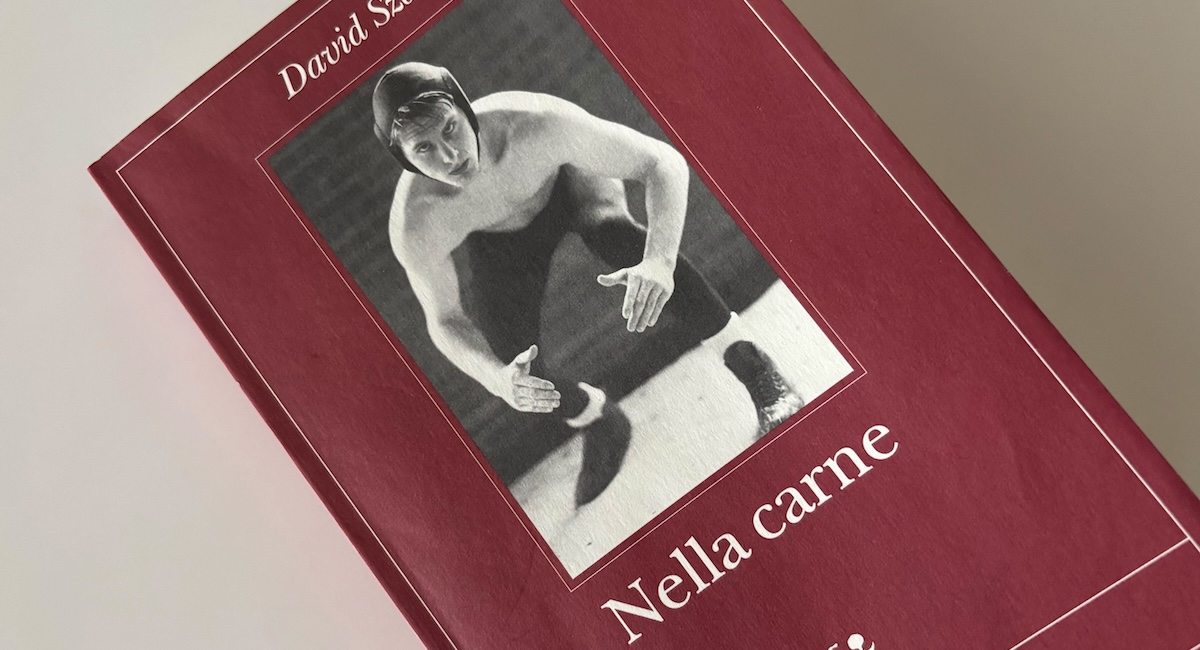Michele Serra e la sinistra
La discussione che si è sviluppata attorno all’Amaca di Michele Serra sul rapporto tra ceto, scuola superiore e educazione è più efficace di cento analisi del voto per capire la fine che ha fatto la sinistra italiana ed europea. Le posizioni sono molto chiare. Da un lato chi accusa Serra e i suoi estimatori di classismo, dall’altro chi accusa i dissenzienti d‘incapacità di comprensione del testo. Non è un dibattito, è una gara di insulti. E, per tornare al punto, ognuno trova nelle posizioni dell’altro “le ragioni profonde della sconfitta della sinistra”, rispettivamente l’elitarismo e analfabetismo funzionale.
Vista rapidamente all’inizio, pensavo fossero i soliti perdigiorno di Twitter, esercizio in cui presunte élite e presunto popolo fanno normalmente a gara a chi è più bravo, dividendosi a caso. Ma poi questo scambio si è allargato fuori dai limiti di 140 caratteri, consentendo di argomentare meglio, gli insulti.
E per provare a individuare un dibattito, ossia tesi contrapposte che non presuppongano classismo o analfabetismo, bisogna fare uno sforzo esegetico, leggendo tra le righe. Ci provo, per vedere l’effetto che fa.
Una critica sensata riguardava l’uso delle categorie di poveri e benestanti. Quando Orwell o Engels puntavano l’indice sulle iniquità, non avevano davanti una popolazione che sta tutta, senza distinzione di censo o letture, davanti a un telefonino – intendo dire: la popolazione oggi condivide parti fondamentali della quotidianità, a differenza di allora. Dunque gli schemi concettuali creati allora, basati su possibilità materiali e stili di vita radicalmente diversi, e facilmente riconoscibili e schematizzabili, forse confondono le idee invece di aiutare a capire i fenomeni se vengono usati su i meccanismi sociali contemporanei. È una critica sensata. Dall’altro canto, si ribatte indirettamente, sarà anche una semplificazione quella di Serra, ma è comunque utile a identificare un problema, la persistenza di un’impostazione classista del sistema d’istruzione italiano, che va prima identificata per poter essere cambiata.
Il dibattito potrebbe continuare perché la contro-obiezione (questa non l’ho letta, me la invento) è che se lo schema per comprendere le disuguaglianze è sbagliato, e la distinzione proletari/borghesi non funziona più, allora si capisce male il fenomeno e non si può neanche intervenire per modificare quelle disuguaglianze. E così via. Ma questo è un dibattito immaginario, che non si è svolto. In un dibattito si può prendere una parte oppure stare in silenzio per imparare qualcosa e magari farsi una idea terza. In realtà, la discussione è stata una gara all’insulto più sottile, alla chiosa piena di aggettivi in cui dare del classista a Serra e “i suoi amici”, o alla ostentata diligenza di chi spiega l’importanza della denuncia sociale lasciando intendere che chi critica non sa leggere per bene o fino in fondo. Menzione agli interventi terzisti che si sforzano di dar ragione a entrambi gli insulti, generalmente nella versione di “si è espresso male”, che detto a Serra onestamente fa un po’ sorridere.
Associandomi a entrambi gli schieramenti per poter essere disprezzato equamente, vorrei ribadire che questa forma della discussione spiega meglio di cento analisi il tracollo mondiale della sinistra perché essa è avvenuta tra persone che nella mia esperienza personale e personalissimo giudizio sono dalla stessa parte della barricata nel momento attuale della lotta del bene contro il male, persone che si considerano (ognuno con la sua personale circostanziata definizione), perlomeno progressiste. Persone che non passano giorno senza stigmatizzare gli hater online e le truppe di Casaleggio.
È questa la sinistra che si è mostrata oggi, intendendo con questo la sua incarnazione fatta di persone, esperienze, idee e vite: una versione meno sguaiata di quegli stessi urlatori da salotto di talk show. Perché è inevitabile che se non esiste alcun dibattito tra tesi, mai e su nessun argomento (mai, e su nessun argomento) si riduce per forza tutto a una questione personale: honestà! Classisti! Analfabeti!
Se finisse qua, aggiungo, anche questo pezzo, di una persona piuttosto scoraggiata che ha passato buona parte della propria età adulta a studiare la sinistra, potrebbe sembrare un discorso moralista: ah signora mia, se solo tutti ci comportassimo bene ritornerebbe magicamente il PCI. Non è così, non è colpa di nessuno, si è tutti in buona fede (tranne quelli in cattiva, normalmente distribuiti). Forse però potrebbe essere utile provare a riflettere sul perché sia ormai questo l’unico modello di discussione pubblica rimasto. Per far questo però non si può rispondere che è colpa del classismo o dell’analfabetismo (anche se suppongo che una buona parte dei sostenitori delle due tesi, a questo punto, mi abbiano relegato a forza in uno dei due campi).
Io tendo a pensare che la sinistra abbia perso le parole, e la capacità di riconoscersi (fatto essenziale per iniziare un dibattito), perché ha vinto, perché dopo l’egemonia dello Stato Sociale come forma di organizzazione capitalista dominante, è arrivata l’egemonia delle parole sulla giustizia sociale. Ormai anche le banche (per fare un esempio!) non si fanno pubblicità promettendo di fare soldi, ma perché lavorano per creare un mondo migliore.
Qualsiasi rapporto di qualsiasi organizzazione internazionale, di qualsiasi lobby, fa proprio il linguaggio e anche gli obiettivi che duecento anni fa erano le isolate proposte dei socialisti utopisti. Ricordiamo chi erano:
Nel 1816, Robert Owen, socialista pre-marxista, veniva udito dal Parlamento inglese a sostegno di quella che quindici anni dopo sarebbe stata la prima legge della storia sull’orario di lavoro. Domanda: “Ritenete che un lavoro di 10 ore e tre quarti nelle fabbriche vada bene per i ragazzi?” , “No, raccomanderei un orario di circa 10 ore o al più 10 ore e mezza”. La legge stabilì massimo 8 ore di lavoro tra i 9 e i 12 anni, e massimo 12 ore dai 12 ai 18 anni: fu una pietra miliare nell’emancipazione degli operai.
Oggi persino il neoliberista antistatalista più incallito giustifica la globalizzazione non sulla base della ricchezza che ha creato, ma perché ha reso possibile una drastica riduzione della povertà. Io trovo siano due cose buone entrambe: che la povertà si sia ridotta, e che non sia considerata una motivazione accettabile per le azioni umane, in pubblico, il puro accrescimento della ricchezza di alcuni, presumibilmente a spese di altri.
Mentre però chiunque si spertica per sottolineare come il progresso sociale sia la ragione principale delle proprie azioni, qualunque esse siano, le disuguaglianze causate dal diverso accesso economico e sociale non solo persistono, ma non si stanno neanche semplicemente aggravando (“i poveri sono sempre più poveri” è una frase che andrebbe bandita): si stanno facendo più complicate.
I sentimenti di maggiore rabbia e disillusione non si trovano negli strati economicamente più deboli: quelli non hanno perso l’energia per cercare la propria emancipazione, i figli degli immigrati sono sistematicamente i primi della classe (ok, è un dato aneddotico, ma corrisponde al 100% degli aneddoti che ho a disposizione). È la classe media a essere convinta di trovarsi in una partita truccata, nella quale non ha più vie d’uscita, e in cui è vittima di ingiustizia. Il sintomo più drammatico non è il voto al Movimento 5 Stelle, non facciamo i provinciali, ma l’epidemia incredibile di morti per overdose da medicinali oppiacei negli Stati Uniti, tipicamente maschi adulti.
Inoltre la disuguaglianza non ha più solo una dimensione economica, altrimenti sarebbe relativamente facile da contrastare, e le elezioni l’avrebbe vinte, in America come in Italia, una sinistra redistributrice, non un demagogismo contraddittorio e improvvisato.
È complicato ma possibile contrastare le attuali dimensioni della disuguaglianza. In un contesto di alto reddito medio, non siamo davanti a milioni di persone in una condizione miserabile come nell’Ottocento, ma milioni di persone in una condizione di sofferenza esistenziale vera, che può e deve essere presa sul serio, non ridotta a un “maggior bisogno di investimenti in formazione”.
Detta in maniera più semplice: a me non pare che in Occidente ci sia un minor bisogno di sinistra, nella definizione di tendenza all’uguaglianza di Norberto Bobbio, tanto che elementi di quella tensione si trovano in tutti i discorsi politici. Tuttavia, la sinistra non si ritrova e non si riconosce più con facilità. E, di conseguenza, non è neanche capace di discutere, come è emerso in maniera forse mai tanto chiara come in questa occasione.
Si parla spesso della perdita di un minimo comune denominatore nel dibattito pubblico, come se fosse una cosa che non riguarda chi osserva il fenomeno. Ma siamo noi a generare il dibattito pubblico, e quella perdita di senso comune riguarda anche – o forse soprattutto – la sinistra. Di conseguenza, nel parlare delle sconfitte, si generano una sequela di liste della spesa prive di gerarchia e prive della capacità spiegare alcunché (Tornare nelle periferie! Le candidature! Il programma! L’empatia!), spesso osservazioni giuste ma che sono al massimo epifenomeni causati da fratture e difficoltà nella ricerca di senso, molto più profonde.