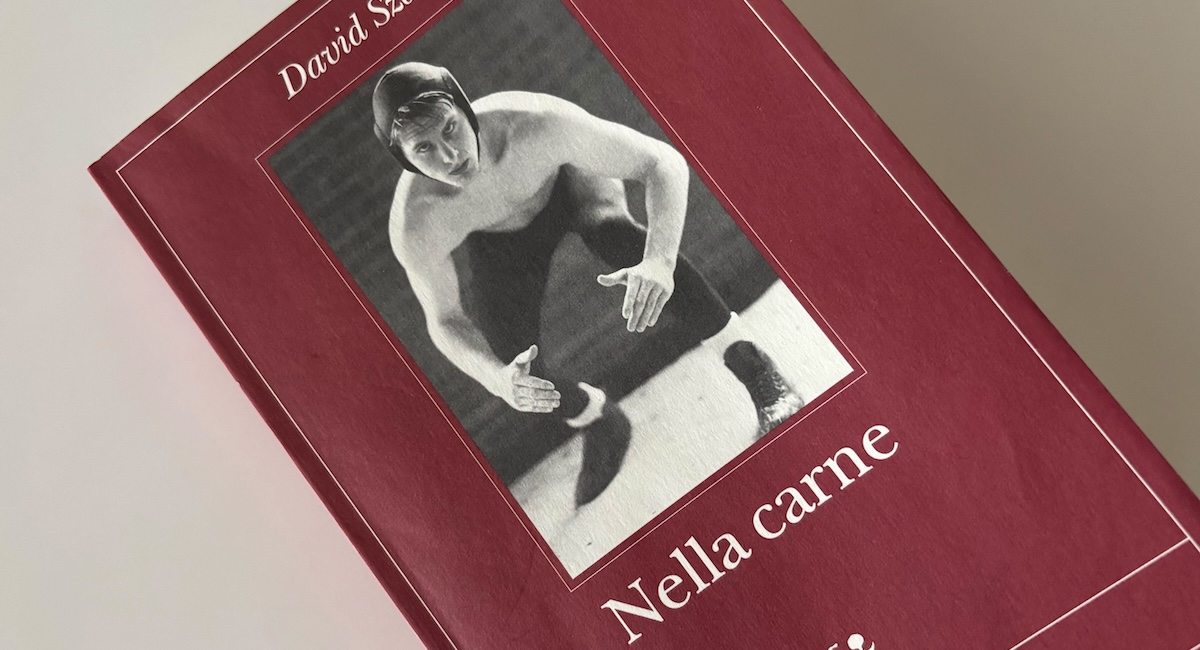Davanti alla rabbia degli altri
Come tutti sono rimasto colpito dalle immagini di Minneapolis. E così ho ragionato su ciò che ho provato e sulle emozioni espresse da chi, come me, ha guardato quelle immagini. Mi è tornato alla mente un ricordo. Riguarda un incontro organizzato da Extinction Rebellion, al quale avevo partecipato lo scorso anno. Un rappresentante di Extinction Rebellion spiegò a tutti i presenti, in modo piano e razionale, perché come organizzazione avevano scelto un metodo di lotta non violento. Non per ragioni strettamente morali, che naturalmente esistono e sono razionalmente argomentabili se si ha un minimo di pazienza e disposizione al metodo dialettico, ma perché la lotta non violenta, nel contesto delle democrazie occidentali avanzate, si è dimostrato un esperimento di gran lunga più efficace di altri, e utile ad allargare il consenso intorno alle ragioni della propria campagna.
Tornando a Minneapolis, mi chiedo: davanti all’immagine di un commissariato in fiamme, che cosa provo? Paura, angoscia. Ma se mi pongo una domanda, devo provare a rispondere con sincerità: e quindi, oltre alla paura e all’angoscia, non posso nascondere a me stesso di sentirmi, anche, inebriato. Ma chi, dentro di me, è inebriato dalle fiamme? Risposta: il piromane che mi abita e condivide lo spazio psichico con altre inclinazioni; per esempio con quell’animale più genuinamente politico, che ha una visione fredda degli eventi ed è in grado di calcolare e pesare le circostanze presenti e future. Del resto, volendo essere sinceri fino in fondo, io sono sempre e da sempre inebriato dalla vista delle fiamme, perché dentro di me vivono un piromane e un casseur, che naturalmente rispetto e con i quali m’intrattengo in lunghe conversazioni. Da questi scambi, credo di aver capito che nel piromane e nel casseur, e quindi in me stesso, il desiderio di giustizia convive con una volontà di distruzione. Ciò non mi vieta di detestare il consueto discorso ipocrita della stampa contro la violenza, i casseur, gli incendi, i bancomat spaccati, ma proprio perché lo detesto e conosco perfettamente la palude dentro la quale trascina, ho capito, con l’esperienza, che la violenza e le fiamme hanno poco da offrire alle ragioni di chi si batte, specialmente nel contesto delle democrazie. Inoltre non mi piace «applaudire» da lontano l’incendio, perché quando si applaude, di solito, ci si rafforza nella posizione (comoda) di spettatori; spettatori alienati e consumatori d’immagini.
Infine: penso alle cose che bruciano, si squagliano, si deformano. Dentro il commissariato, come in qualsiasi altro interno che brucia, sono deflagrati ed esplosi centinaia di oggetti. Che cosa sono gli oggetti? Sono cose costruite dal lavoro umano, sono un computer, una stampante, un portapenne souvenir, dove magari è scritto in caratteri corsivi «Barcellona» o «Rio de Janeiro». Le cose sono impregnate di lavoro umano, sono sature di sentimenti, memorie e connessioni morali alla vita concreta di esseri umani e reti di esseri umani collegati ad altri esseri umani. (Ogni oggetto è un ricettacolo cosmico e un nodo di rapporti storici, umani e metafisici; lo racconta molto bene un film del 2019, Uncut gems, a proposito di una pietra, estratta in Africa, attorno alla quale si svolge tutta la storia, a New York).
Se si comprende la qualità morale delle cose, degli oggetti, diventa doloroso vedere un’architettura carbonizzata. E come piromane comincio a sentire dubbi e imbarazzo per l’eccitazione che ho provato, e a tratti ancora provo, di fronte alla foto di una grande colonna di fuoco. Immagino che da quella distesa liquefatta si sia alzato un miasma feroce e tossico, da tapparsi naso e bocca e fuggire, di cui però non ho avuto coscienza, perché una foto non è in grado di restituire la virulenza e il calore di un incendio. Conviene sottolinearlo, perché le immagini, per natura ingannevoli, spingono a dimenticare ciò che è ovvio.
In «Furore» di John Steinbeck c’è una scena che racconta l’uccisione di un indiano. L’indiano è nudo, stagliato di spalle contro il sole, sopra una collina. Non sa che nascosti tra i cespugli ci sono i soldati dell’esercito americano che lo tengono nel mirino. I soldati lo guardano e sono inebriati dalla bellezza della preda. Sparano. L’indiano cade a terra. I soldati si avvicinano e non trovano il corpo maestoso di un capo indiano, ma solo «un fagotto insanguinato, e piccolo», più piccolo di quanto credessero. La violenza non compensa, al contrario, di solito scompensa, delude. Torna indietro nel corpo e maledice.