Come andò prima di noi
Uno dei pochi vantaggi di una situazione nella quale si è costretti a stare forzatamente in casa, e ridurre al minimo le occasioni di socialità, perché fuori è tutto chiuso, è che si possono leggere tutti d’un fiato libri di grandi dimensioni che, nella vita affannosa di tutti i giorni, costringerebbero a frequenti e spiazzanti interruzioni.
La mia vita di lettore è stata costellata da letture importanti fatte durante un forzato riposo o una malattia: L’uomo senza qualità di Musil, in occasione di una brutta frattura; Don Chisciotte, in compagnia di una misteriosa giovanile malattia; La montagna magica e gli altri capolavori di Thomas Mann durante i noiosi mesi del militare, i classici russi, uno all’anno, durante i febbroni dell’adolescenza.
Nei giorni scorsi mi è capitato tra le mani una specie di Fratelli Karamazov di Fëdor Dostoevskij: Prima di noi, di Giorgio Fontana (1981), un volumone di 886 pagine, pubblicato da Sellerio, dove le vicende, i personaggi, il sesso, le considerazioni filosofiche e politiche, la storia dell’Italia del Novecento, si fondono in un racconto appassionante, scritto con bravura e talento nei dialoghi, con riferimenti frequenti, nient’affatto inopportuni, ai fumetti. L’autore infatti fa di mestiere, oltre alla scrittore (nel 2014 vinse il Premio Campiello con Morte di un uomo felice), lo sceneggiatore per Topolino.
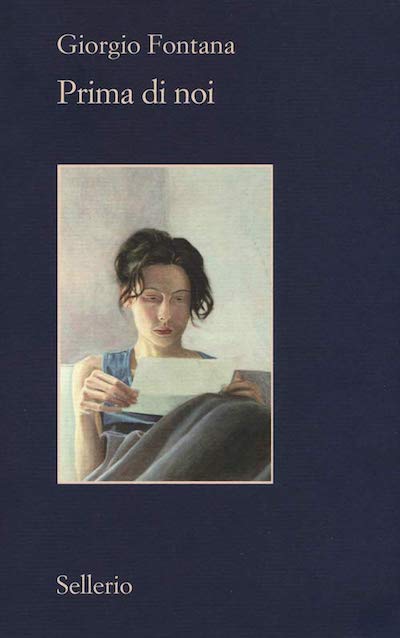
Il riferimento a Dostoevskij, per questo che, a mio parere e con rispetto per gli altri, è il miglior romanzo italiano degli ultimi dieci anni, non è casuale perché, come nel grande romanzo realista russo, la vicenda ha uno dei suoi pilastri in un personaggio buono, fragile, bullizzato, ingenuo, religiosissimo, sgrammaticato. Un mite, quasi un santo: una sorta di Alëša Karamazov friulano.
Domenico (detto Meni), secondogenito del “capostipite” Maurizio Sartori e della forte contadina Nadia Tassan, morirà in un campo di prigionia francese in Tunisia, dopo aver incontrato nel delirio una sorta di “profeta”, sacrificandosi per salvare un altro prigioniero dalla morte per sete. Domenico era il preferito della madre, cosciente che, dei tre figli, lui era il più inadatto a vivere (la differenza tra gli umani e gli animali è che le madri, in genere, proteggono e amano i più deboli della loro prole).
Prima di esalare l’ultimo respiro però, per la prima volta, “Domenico provò una rabbia intensa, odio per il mondo e per Dio e Satana che congiuravano contro le creature, e per le creature stesse che passavano la vita a ferirsi. Almeno lui ci aveva provato, a rimediare a quello sbaglio. Ma perché l’ho fatto, se non ne valeva la pena? Perché non potevi fare altrimenti, gli rispose la voce di sua madre…”.
Il romanzo ripercorre la storia di quattro generazioni (dal 1917 al 2012) della famiglia Sartori che si spostano dal Friuli rurale alla Milano contemporanea. Un ritratto di un secolo italiano attraverso decine di personaggi emblematici fino a un certo punto, perché ciascuno di loro, da quelli principali a quelli di contorno, è molto ben caratterizzato nella sua unicità, come Mara Cavicchio, la pazza che pescava nelle rogge di Udine con la canna senza filo (una presenza muta e smarrita come l’angelo del Decalogo di Kieślowski).
I Sartori, quasi tutti, soprattutto gli uomini, sono gente dura, orgogliosa della propria origine friulana, profondamente religiosa, inclini al bere. Essi si portano addosso un misto di rabbia, frustrazione, infelicità: “Potevano fuggire dove gli pareva o stare fermi, ma la realtà non sarebbe cambiata. Il mondo sembrava fatto per combatterli. Il mondo era più forte di loro, o forse loro erano così testardi e stupidi da non sapere come viverci in pace. Eppure non si arrendevano. Nemmeno difronte alla sventura, alla malattia, alla solitudine…”.
Come, efficacemente, sosterrà, alla fine del romanzo, la fragile e sensibile Letizia (figlia dell’impegnata Eloisa, a sua volta figlia dell’insegnante, e poeta fallito, Gabriele, primogenito di Maurizio e Nadia, e “causa” del loro forzato matrimonio), per quasi un secolo i Sartori avevano costruito una nave partendo dal poco legno disponibile: di generazione in generazione la famiglia era uscita dal fango e dall’oscurità alzando alberi, tessendo vele, rinforzando lo scafo e accumulando cordame. E infine lei, l’ultimo elemento del processo, si sente una sorta di polena, una di quelle decorazioni lignee, spesso figure femminili, che venivano collocate sulla prua delle navi: “perfettamente modellata ma in fondo inutile”.
La storia inizia con la disfatta di Caporetto, e prosegue con gli incerti e violenti anni venti, il Fascismo, il dramma della guerra, la controversa Resistenza, il trasferimento a Milano e la miseria della periferia, le lotte operaie, il Sessantotto, il femminismo, il terrorismo, fino agli anni Novanta quando domina l’amara sensazione che: “la nostra generazione è fregata, godiamoci la vita e tanti saluti. Chi mai si interessava più del futuro? Il presenta era l’unico tempo rimasto…”.
Le vicende storiche non stanno sullo sfondo ma si intersecano nelle pieghe della vita dei vari rami della famiglia Sartori. Ogni tanto Fontana riferisce, riproducendole in maiuscoletto, di scritte sui muri: quasi fossero titoli che sintetizzano il momento storico nel quale i personaggi si arrabattano. La maggior parte degli ultimi rappresentanti dei Sartori, e dei loro compagni e amici, è convinta che: “In tempi miseri non c’era di meglio da fare: restare immobili come animali colpiti da un fascio di luce nel buio…”.
Come si conviene a un ambizioso e potente romanzo, la filosofia zampilla da tutte le parti e ruota attorno a una riflessione, spesso dalle venature quasi religiose, sul rapporto tra Bene e Male. I Manichei erano convinti che il Male esistesse come entità autonoma. Questo però era un problema perché indeboliva l’onnipotenza di Dio (il Bene). Domenico riflette su Sant’Agostino che cercò di risolvere la questione sostenendo che il Male non esiste in sé: è solo assenza del Bene. Nella seconda metà degli anni Settanta, con l’esplodere del terrorismo, i giovani Sartori e i loro amici si interrogano su cosa sia il Bene e come esso possa nascere dal Male, e se il Male possa essere una difesa legittima da un altro Male.
Per capire meglio quale sia la riflessione che sottende l’ ultima parte del romanzo, che è quella più propriamente “autobiografica” di Giorgio Fontana, sarebbe utile leggere un suo interessante testo di qualche anno fa: Crescere nell’assurdo (pubblicato su “Lo straniero”, n. 184, ottobre 2015).
Vi si ragiona su una condizione giovanile di precariato, non soltanto economico ma affettivo ed esistenziale, che provoca un’ acuta mancanza di senso: “vedevo anche negli altri, nei miei amici e nei miei colleghi, la stessa condizione assurda cui mi sentivo crocifisso; ma non vedevo, non sentivo quasi, la possibilità di fare un fronte comune che funzionasse contro questa insensatezza”.
Bisogna dare forma all’assurdo attraverso il racconto: “Quando si attraversano dei momenti così cupi, disordinati e in apparenza totalmente privi di logica e senso, un buon modo è cercare di ridefinirli attraverso un ordine del discorso, quasi correggere in qualche modo il linguaggio che li rappresenta”.
La proposta di Fontana è quella di un ritorno alla comunità di matrice libertaria. È proprio questa mancanza (e un senso della Famiglia assai precario e pieno di contraddizioni; un cattolicesimo più privato che comunitario; l’incapacità di aderire pienamente, persino durante la Resistenza, alle organizzazioni collettive) che fa della saga dei Sartori una vicenda di insensata e infelice frustrazione.
Assai suggestivo è un “filo rosso” (ce ne sono diversi che attraversano questo lungo romanzo) che, a partire dalla fine di Nadia Tassan, attraversa la metà del libro: una lettera che, assieme a un suo autoritratto col marito e il primo figlio Gabriele, lei gli affida dentro una busta chiusa con scritto “Da aprire tra cinque anni”. Gabriele non la aprirà mai, quasi terrorizzato di che cosa potesse esserci scritto.
Lo farà la sua giovane figlia Letizia (quella che si sentiva la “polena” della nave di famiglia) che andrà a leggersela (e a leggerla per noi) in un prato a pochi passi dal casolare di campagna dove tutto era iniziato. Sentirà che quel messaggio era come indirizzato proprio a lei e depositerà il disegno, al cimitero, sulla tomba del capostipite Maurizio con un’invocazione di pietà per tutti quei parenti scomparsi e sconfitti. Una saga dei vinti che li abbraccia tutti in un gesto di grande umanità che dà un senso alla loro storia.
Questo è ciò ci offre questo romanzo. Ognuno ovviamente scrive quello che vuole e si sente. Ma in Prima di noi c’è un tentativo di risposta importante a una sorta di “dovere” che chi scrive ha verso l’umanità. In una lettera al fratello Michail, del 16 agosto 1839, Dostoevskij scrisse: “L’uomo è un mistero. Un mistero che bisogna risolvere, e se trascorrerai tutta la vita cercando di risolverlo, non dire che hai perso tempo; io studio questo mistero perché voglio essere uomo”.



