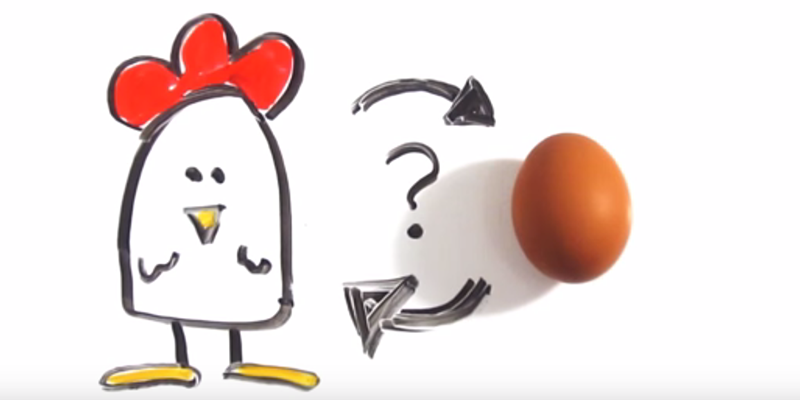Königsberg/Kaliningrad
Non sono mai stato a Kaliningrad e, ovviamente, nemmeno a Königsberg, Królewiec, Kunnegsgarbs, Karaliaučius, Kenigsberg. Ma, in quella che, da quasi un secolo, si chiama “Città di Kalinin”, provai ad andare alla metà degli anni Ottanta. Da Varsavia, dove studiavo, presi il treno per Danzica, in una fredda giornata di pioggia, mosso da un improvviso e inarrestabile bisogno di esaudire un vecchio desiderio, quasi un voto: “andare a trovare Kant”. Quando studiavo Filosofia, a Firenze, con gli amici ci dicevamo spesso, sospendendo per far merenda la lettura della Critica della ragion pratica, che saremmo dovuti andare a portare delle rose rosse sulla tomba del nostro amato filosofo e, nell’occasione, verificare se davvero sulla lapide della sua tomba, nella Cattedrale della sua città, ci fosse ancora scritto: “Due cose riempiono la mente con sempre nuova e crescente ammirazione e rispetto, tanto più spesso e con costanza la riflessione si sofferma su di esse: il cielo stellato sopra di me e la legge morale dentro di me”.
Sceso dal treno a Danzica, mi trovai immerso in una nebbia irreale e a fatica riuscii ad arrivare alla tetra villona, in via Stefan Batory, dove aveva sede l’Ambasciata sovietica. Da lì mi spedirono, un paio di strade più in là, nel maleodorante Ufficio visti. Una corpulenta, e visibilmente annoiata, signora, con un sorriso dorato come un’icona, dopo essersi a lungo rigirata tra le mani il mio passaporto, mi comunicò che non avrei mai ottenuto il visto per Kaliningrad. Alla mia richiesta del motivo, mi rispose laconicamente: “Zona militare, base missilistica”. Uscii di là furibondo e mi andai a ubriacare in una bettola del porto, ingurgitando aringhe dal sapore amarognolo. Le acque di Danzica erano gelate e mi veniva da sogghignare pensando al fatto che Stalin, il 1° dicembre 1943, alla Conferenza di Teheran, aveva preteso Königsberg con questa motivazione: “Un porto che non geli d’inverno sul Mar Baltico è la nostra unica rivendicazione territoriale”.
Nella gelida, e relativamente più meridionale Danzica, durante la notte, rigirandomi nello scomodo letto dello sbocconcellato alberghetto che avevo prenotato da Varsavia in previsione della partenza mattutina per la città sovietica, feci un sogno indimenticabile, forse un incubo: attraversavo la frontiera a piedi, pestando la neve; agguantavo uno sgangherato autobus e mi mettevo seduto accanto a una contadina con una grossa gallina in grembo; arrivavo dopo parecchie ore, e soste, a Kaliningrad tutta ricostruita in stile tetramente sovietico; trovavo facilmente l’asimmetrica e malmessa Cattedrale, senza tetto, che si ergeva tra due canali, un po’ come Notre-Dame; entratovi dentro, nel piccolo mausoleo, all’angolo nord-est, vedevo la tomba di Kant… Mentre, alla fioca luce di una candela, leggevo l’epitaffio in tedesco, la lapide si apriva come due sportelli di un armadio, spuntava un grosso missile che rapidamente prendeva quota nel cielo scuro, lasciando una nube azzurrognola di gas e polvere.
Sul treno del ritorno, stemperai la mia delusione, ripetendomi come un mantra quelle che, che secondo le testimonianze, furono le ultime parole di Kant: “Es ist gut” (“Va bene”). Negli anni successivi mi misi il cuore in pace e, anche dopo la fine dell’Unione Sovietica, non mi è più tornata la voglia di andare a visitare quel luogo che quell’antipatico di Curzio Malaparte aveva definito: “piccola città dell’Occidente, in riva allo sterminato oceano della pianura slava”.
Il mio era stato un fallito progetto di pellegrinaggio filosofico. Oggi, grazie al bel libro di Valentina Parisi (Una mappa per Kaliningrad. Una città bifronte, exòrma edizioni) sono riuscito finalmente, seppur ancora con la fantasia, a trovarmi a Kaliningrad/Königsberg. Il suo è un pellegrinaggio reale, in diciotto stazioni, attraverso la città di Kant, per verificare, se poco più in là, fosse ancora in piedi o ci fosse qualche traccia dello Stalag 1 A di Stablack, il campo di lavoro coatto dove era stato rinchiuso, sul finire del secondo conflitto mondiale, il padre di sua madre (“Mio nonno è stato prigioniero lì durante la guerra”). Liberato dai sovietici nell’aprile del 1945, come Primo Levi, ci mise dei mesi a tornare in Italia. Odissee all’incontrario: viaggi assurdi attraverso l’Europa in rovine.
Molti anni dopo la morte del nonno, Parisi lo va a ricercare, sempre passando per Danzica, nei luoghi della sua giovanile prigionia. Ed essendo una valente studiosa del mondo sovietico e traduttrice dalle lingue slave, sceglie come data simbolica per arrivare a Kaliningrad il 9 maggio, il Den’ pobedy, il Giorno della Vittoria dei sovietici sui nazifascisti, festeggiato, come si conviene, con parate e canti. Così, praticamente nell’anniversario, una settantina di anni dopo, un cerchio si chiude. Ma questo è anche il pretesto per raccontarci una città che ha cambiato nazione e, impropriamente, nome (se proprio si doveva, avrebbe potuto chiamarsi Kantgrad!). Mescolando racconto di viaggio, interessanti storie di luoghi e personaggi, e anche vicende personali del passato e del presente, il libro è un prezioso viatico per un luogo troppo spesso dimenticato. Per me è stato la bella occasione per andare, con la fantasia, nella Montagna del re: così infatti si chiamava la città dalla quale mai si mosse Kant e dove non sono riuscito mettere piede.