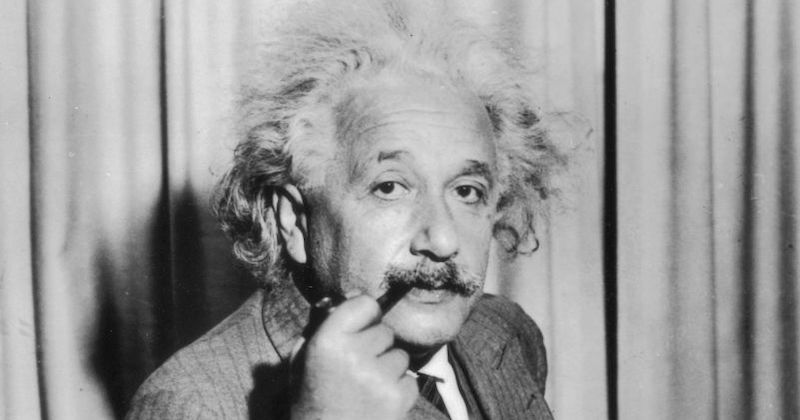I mezzi e i Fini
C’è una cosa che interessa pochissimo a tutti, appassionati come sono – tutti – solo al futuro della legislatura. E’ questa: se Gianfranco Fini, cioè, domenica abbia semplicemente detto il vero o no, questione che viene messa in secondo piano rispetto alle conseguenze delle sue parole e all’opportunità che le pronunciasse. In linea di massima io penso di sì, penso che abbia detto sostanzialmente il vero al netto delle sue libere opinioni: poi nel suo discorso ci saranno state delle omissioni, ma vere e proprie balle secondo me non ne ha dette. Anzi. Ci sono parole e parole, certo: dire che il Pdl sia morto, per esempio, implica che sia mai nato. Difficile sostenerlo: la forza politica più grande del Dopoguerra, appunto il Pdl, non si è neppure mai avvicinata a una sintesi formidabile di pluralità, estrazioni, radici e realtà che fossero davvero cementificate in un progetto comune: non si è avvicinata perché probabilmente non interessava a Berlusconi. Correnti e fondazioni culturali sono rimaste una bestemmia o un ornamento, il dissenso era visto come una stravaganza, la disciplina e il metodo hanno ovviato alla difficile convivenza tra il forcaiolo e il garantista, il liberista e lo statalista, il laicista e il baciabile, il nuclearista e l’ecologista, il berlusconiano e il finiano. Il Pdl è un partito populista e plebiscitario (non sono parolacce) anche perché questo interessa a Berlusconi, convinto com’è, per molte ragioni, che il suo charme carismatico e il consenso di cui gode siano l’unico possibile escamotage che possa risvegliare questo Paese addormentato. Direzioni nazionali, uffici di presidenza, probiviri e altri orpelli di partito: sono sempre stati una farsa, si sa. A dirla tutta, il famoso Parlamento dei «nominati» doveva rappresentare la parallela e formidabile macchina da legiferazione che spazzasse via ogni intoppo – democratico, ma terribilmente lento – che il Governo incontrasse lungo le vischiose strade della vecchia politica, laddove i decreti legge, purtroppo per Berlusconi, non si potevano proporre e approvare tutti i giorni. A dirla proprio tutta, però, sono tutte cose che Gianfranco Fini sapeva benissimo anche prima che decidesse di confluire nel Pdl, suo evidente e forzato errore che in breve gli ha restituito un’Alleanza nazionale meno che dimezzata. Questa orrenda e antidemocratica legge elettorale, allo stesso modo, la votò anche lui. Se sono stati errori, non lo sono stati da poco.
Detto questo, è vera anche un’altra cosa: Fini è stato cacciato. Paradossi a parte (Fini non era neppure iscritto al partito, dunque è come se un circolo avesse cacciato un socio che non era socio) i passaggi-chiave sono stati la direzione nazionale di aprile e l’ufficio di presidenza di luglio: in nessun partito normale viene espulso chi voti contro una mozione di maggioranza. La tesi che si sia fatto cacciare non sta in piedi, che poi lo potesse intimamente desiderare resta affar suo. E’ stato cacciato.
Altre cose rientrano nel soggettivo: l’opinione di Fini sul quoziente familiare, o sul processo breve, o sul lodo Alfano, era solo il condimento di ben altra pietanza politica. Anche il fatto che la Farnesina paia perlopiù una succursale del ministero del Commercio estero, ancora, sembra quasi un’evidenza, così come è un fatto innegabile che il nostro Paese intrecci degli affari con paladini dei diritti civili come Gheddafi e Putin e Lukashenko. Ma di tutte queste cose, per quanto doloroso, non importa a nessuno. A qualcuno magari interessava che Fini parlasse di Montecarlo e dintorni: ma era impensabile che potesse farlo. Piaccia o meno, il discorso di domenica potrebbe restare un importante giro di boa: difficile che volesse metterci in mezzo la cucina Scavolini e suo cognato. Gianfranco Fini del resto ha diritto di non rispondere a nessuna domanda, esattamente come poteva non farlo – e non lo fece – Silvio Berlusconi per il caso Noemi. Se poi a Fini convenga, in termini di immagine e di voti, è affar suo anche questo.
Ma il fatto che il leader di Futuro e Libertà possa aver delineato un quadro impietoso e reale – e il fatto che abbia rivendicato un ritorno della politica con la P maiuscola – non è che renda Fini più credibile in sé e per sé. Questa è un’altra cosa da dire. Una persona, cioè, potrebbe anche rigettare il cesarismo berlusconiano e condividere per filo e per segno le velleità «democratiche» di Fini: ma chi ha detto che sappia o voglia davvero realizzare ciò che dice? Il punto non è solo che Fini è stato appresso a Berlusconi per 16 anni, aspirando palesemente a sostituirlo e però senza successo. Il punto è che Fini e i finiani si appellano a un paese più evoluto di come la politica berlusconiana lo rappresenta: e si candidano a farsene ambasciatori non è chiaro tuttavia da quale pulpito. Non è chiaro, cioè, se i «contenuti» politici che loro oppongono a Berlusconi – su federalismo, economia, diritti civili eccetera – siano davvero il fine e non solo il pretesto per giustificare lo strappo col Pdl. L’esempio migliore, per capirci, resta quello dei temi eticamente sensibili, tipo testamento biologico, immigrazione, lacità eccetera: domenica, davanti al cuore pulsante dell’ex Msi, Gianfranco Fini non ne ha proprio parlato. Non l’aveva fatto, pure, alla direzione nazionale dell’aprile scorso: questo dopo che il suo interventismo su questi temi aveva scatenato discussioni infinite. Da quanto risulta, poi, in Futuro e Libertà non ci sono più laicisti o baciapile di quanti ne siano rimasti nel Pdl, e lo stesso potrebbe dirsi, forse, per altri importanti temi e distinguo politici: non è che nella neonata compagine di Fini, per dire, ci siano più sudisti, meno federalisti, più legalisti e insomma ci sia una destra intrinsecamente diversa da quella che ha lasciato. Da qui il più semplice dei timori: che le idee possano essere soltanto la scenografia di una banale, banalissima lotta di potere. E nient’altro.