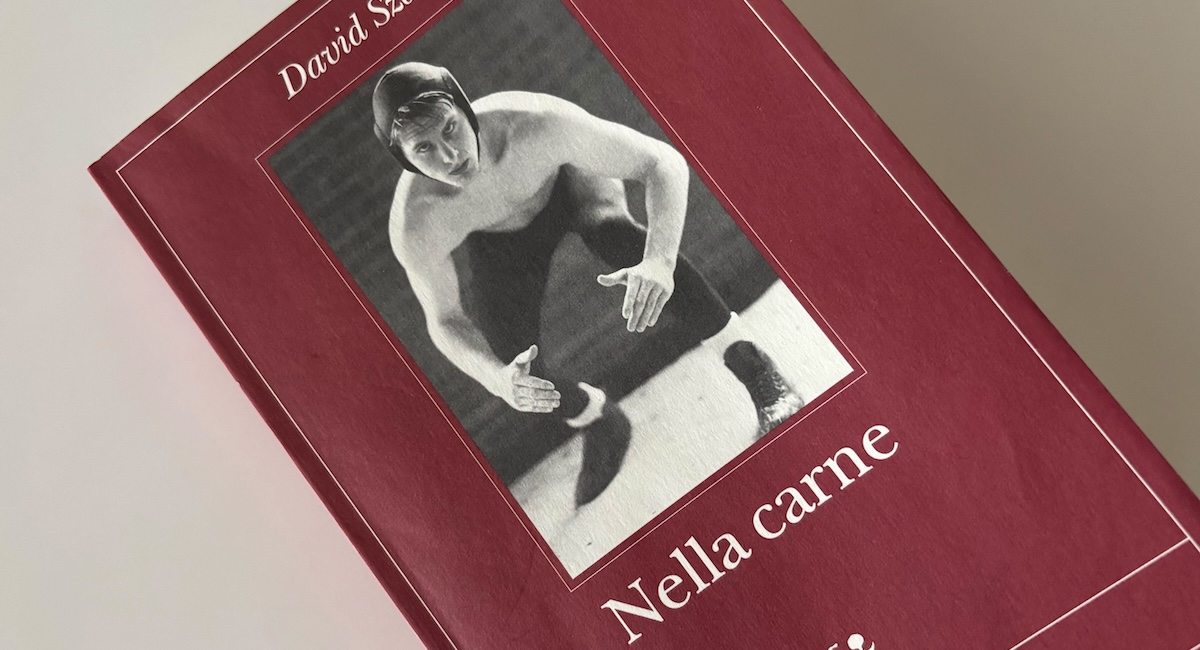Archivum Secretum Vaticanum
E così al mezzogiorno meno qualche minuto di martedì 28 febbraio mi siedo sul Freccia Rossa 9627, carrozza 11 posto 68, con il mio zainetto da viaggio e un sacchettino con dentro una bottiglietta d’acqua comprata al supermercato sotto casa assieme a una piadina e un’insalata di quelle con il condimento incluso. È una bella giornata, mi appoggio allo schienale e ricapitolo cosa farò prima di sera.
Il treno mi deve portare da Milano a Roma in tre ore secche, dopodiché da Termini devo andare a un hotel in zona Gregorio VII, dietro al Vaticano, dove ho appuntamento con un piccolo gruppo di giornalisti prevalentemente stranieri e con i funzionari di Emc, azienda americana specializzata in un’ampia serie di prodotti informatici e infrastrutture digitali per aziende: un bestione da 20 miliardi di dollari all’anno che nel 2011 è cresciuta non poco. Lo scopo dell’appuntamento è presto detto: i funzionari italiani ed europei di Emc ci porteranno a visitare in esclusiva un luogo che nei secoli non è mai stato aperto al pubblico, solo di recente agli studiosi. Si tratta dell’Archivum Secretum Vaticanum, l’Archivio Segreto Vaticano.
Emc ha sponsorizzato sia la conservazione in formato digitale di documenti contenuti nell’archivio che la mostra che per la prima volta ne porta 100 sotto gli occhi del pubblico generalista, per festeggiare i 400 anni dall’istituzione dell’archivio del Papa. Per la prima volta dall’epoca di Napoleone i documenti scelti da una commissione di esperti lasceranno la cittadella del Vaticano per essere esposti al Musei Capitolini dal primo marzo fino a fine settembre di quest’anno. L’esibizione si chiama “Lux in arcana”, luce sui misteri.
Come succede con le grandi esposizioni (ad esempio quando Enel o Telecom Italia sponsorizzano il restauro di questa o quell’opera d’arte) anche qui un’azienda ha sponsorizzato una istituzione affinché si possa lavorare al recupero e preservazione di documenti antichissimi. Rendo a Cesare quel che è di Cesare, ma voglio cogliere anche l’occasione per andare a vedere qualcosa che si prospetta come molto particolare. Non faccio in tempo a finire di mettere la mia coscienza deontologica a posto che sono praticamente già arrivato a Roma. È impressionante la velocità dei Freccia Rossa (e in prospettiva degli altri treni che solcheranno i binari dell’alta velocità nostrana). Per dire: il bus che mi porta a Gregorio VII (il 64) impiega una percentuale significativa del tempo che c’è voluto per arrivare da Milano.
Nella hall dell’hotel c’è il banco con l’accoglienza di Emc e i primi giornalisti che arrivano alla spicciolata. Sono pochi quelli che provengono da fuori Roma: nella capitale hanno gli uffici di corrispondenza tutti i principali quotidiani del mondo, Monti sta tenendo la politica italiana in soporifero relax e la possibilità di andare a curiosare gli archivi segreti del Vaticano solletica i caporedattori di tutto il pianeta. Alla fine, contando anche quattro o cinque tra accompagnatori e personale di Emc, siamo in 23. Un bel gruppetto che un valente autista di pulmino accompagna all’entrata del Vaticano.
Qui confesso il mio provincialismo: non ero mai stato dentro il Vaticano e, nonostante gli studi classici e un abbondante numero di letture (senza contare l’educazione dai Barnabiti che a qualcosa deve pur valere) l’unico che mi viene in mente è Angeli e Demoni di Dan Brown. È la potenza della narrativa americana: nonostante Brown cucini i suoi romanzi con i piedi e affoghi la narrazione in didascalie degne di un opuscolo per turisti del dopolavoro, segue il metodo del grande romanzo verista americano e coglie i particolari che contano. Così, all’ingresso di Sant’Anna sono preparato e capisco che al cancello ci sono le guardie svizzere, con le loro uniforme da lavoro avvolte da una cappa blu scuro e il saluto d’obbligo, mentre più avanti, armati ma con discrezione, ci sono i funzionari del corpo della gendarmeria del Vaticano.
Parcheggiamo, scendiamo e ci prepariamo ad entrare passando dal cortile della Pigna, che in realtà è il soffitto dei due piani di bunker voluti da Paolo VI per conservare i documenti. Veniamo affidati a una guida, un funzionario con modi curiali e un inglese veloce anche se dall’accento italiano molto marcato. Lo segue il responsabile del servizio informatico dell’Archivum, un giovane ingegnere elegante nel suo completo su misura.
Dobbiamo lasciare borse, borsette e zainetti. Fare le foto è seccamente vietato. L’ambiente però rimane cordiale. Sembra di entrare in un pregevole istituto per le opere pie, dall’ampia portineria con legni chiari e vetrinette che espongono pubblicazioni d’archivistica e gadget come il raffinato porta-graffette magnetico con orologio al quarzo o il prezioso tagliacarte con la riproduzione delle firme di papi a piacere o, per un’ironia della storia che sul momento mi pare secondaria, di Galileo Galilei.
Si scalpita per iniziare il giro; anche se, devo ammettere, sono uno dei più giovani in una squadra di giornalisti e giornaliste d’esperienza più che matura, e il termine scalpitare mi pare una forzatura. La guida ci conduce rapidamente in un’ampia stanza con un lungo tavolo per riunioni e scaffalate di grandi volumi antichi. È una delle sale di consultazioni, foderata di indici (tra un attimo se ne riparla) e, dopo un’introduzione dei nostri ospiti di Emc, la nostra guida si lancia in un articolato discorso che può essere riassunto in tre punti. Il primo: se pensavate di vedere i “segreti”, avete fatto un viaggio a vuoto, perché in latino “secretum” vuol dire privato, personale. In questo senso, l’Archivio “segreto” del Papa è in realtà l’archivio “personale” del sommo pontefice. Di archivi come questo l’antichità è piena, a partire da quello del Granduca di Toscana del quale lo scrivente ignorava l’esistenza ma sul quale mi prendo un appunto mentale e mi riprometto di fare indagini più approfondite quella volta che scopro di avere una giornata da bruciare senza rimpianti.
Secondo punto, questo è un archivio, non una biblioteca. E quindi, non solo è difficile calcolare il quantitativo di documenti qui conservato, perché in ogni scatola si possono trovare da uno a decine e decine di fogli, ma è anche necessario sapere che qui i documenti che si conservano sono quelli tipici di un archivio: documenti amministrativi e legati all’attività di stato del Vaticano. Lettere delle nunziature apostoliche, suppliche di chi aveva bisogno, vagonate e vagonate di altre carte il cui interesse nella mia mente comincia a farsi via via più fumoso. L’immagine di Dan Brown nel retro del mio cervello evapora.
Terzo punto, la storia di questo posto. Che è pazzesca, perché si spalma su più secoli. E adesso comincia un balletto di nomi, di dati e di posti che, oltretutto mitragliato in un inglese imparato a memoria da guida turistica, diventa difficile da seguire. Applicando il metodo suicida di non registrare le conferenze, mi perdo numerosi passaggi. Ma tanto sono già depresso: niente segreti da rivelare al pubblico nelle segrete del Vaticano. Che, per adesso, ha ambienti che ricordano in maniera impressionante l’ufficio del preside del mio collegio dei Barnabiti. Ufficio in cui, sia detto per inciso, venirsi a trovare durante l’orario di scuola non era mai un buon segno.
Il numero che mi colpisce (letteralmente, perché verrà tirato fuori almeno una dozzina di volte e scagliato come una pietra verso di noi) è che qui ci sono 85 chilometri di scaffalature tutte messe a documenti. Raccoglitori e raccoglitori di documenti. Il paradiso del faldone. La sagra della filza. A Travaglio verrebbe un infarto. E poi, altra informazione, è che in realtà l’archivio è frutto della convergenza di altri e più numerosi archivi, compreso quello di Castel Sant’Angelo dove l’umido stava facendo strage di documenti risalenti almeno all’ottavo secolo. Questo Archivum enne fondato da Paolo V nel 1612, con la nomina del suo primo custode, Baldassarre Ansidei, e l’assegnazione dei primi spazi. Dentro, quello che più modernamente si dovrebbe chiamare “l’archivio di Stato”, se solo all’epoca fosse esistita l’espressione.
Adesso è passata una mezz’ora, si avvicina il momento di cominciare a vedere qualcosa. E parte una lunga camminata su e giù per scalette alquanto ristrette. Prima tappa: sottosuolo. Ci sono i due piani di bunker ben ventilati. Dentro, con un soffitto di due metri e settanta al piano di sotto e di tre e trenta a quello di sopra, sono allineate decine e decine di scaffalature in metallo. Un camminamento di almeno 18 file profonde una decina di moduli. Si tratta di intelaiature in metallo, verniciate di un pessimo grigio, realizzate dalla Strafor Italiana Spa, che li definisce (secondo quanto si legge in una pregevole etichetta sul retro della porta blindata che dà l’accesso al bunker) «impianto scaffali “compact”» realizzati in Milano nel 1980. Giovanni Paolo II ha inaugurato l’opera in vero cemento armato a vista proprio in quell’anno, mentre una legione di archivisti si è poi occupata di ridare forma all’archivio. L’unica cosa che mi viene in mente è la scontatissima immagine di Indiana Jones e del capannone dove viene archiviata la cassa con l’Arca dell’Alleanza alla fine del primo film. Avete presente? L’infinito leopardiano che incontra la burocrazia sovietica.
Ci incamminiamo tra le scaffalature, l’aria è gradevolmente fresca e non umida, i passaggi alquanto angusti.
C’è da sapere che in questo periodo sto cambiando libreria a casa mia. Ho la brutta abitudine di accumulare libri e oramai lo spazio si è fatto ristretto, tanto da costringermi a investire in una Bestå (made in Ikea, ovviamente) che unisce a un prezzo ragionevole anche prestazioni in fatto di carico sopportabile di tutto rispetto, scaffalature generose e profonde, design minimalista che scompare senza creare spiacevoli forme di esibizione della struttura che a casa mia sarebbero fuori luogo. Prima di arrivare a selezionare quella che in famiglia chiamiamo amabilmente “la nostra bella Bestå” o “guarda là che Bestå, eh?”, ho passato fin troppo tempo a vagare per i meandri delle due Ikea milanesi, con l’aggiunta di qualche raid a casa di amici che mi osservavano perplessi con l’aperitivo in mano mentre mi arrampicavo sul divano del soggiorno per misurare la scaffalatura e cercare di saggiarne la resistenza ai carichi verticali. Un armadio, come diceva sempre Steve Jobs, deve essere fatto bene anche dove non si vede. Secondo me la regola vale anche per le librerie e questo mi ha autorizzato a smontarne qualche modulo a puro scopo di carotaggio, anche se mi sono probabilmente giocato un paio di amicizie di vecchia data.
Comunque, un lungo panegirico per dire che in questo particolare periodo della mia vita sono alquanto sensibile al tema dell’archiviazione, della logistica, delle soluzioni per movimentare e lasciar poi sedimentare i documenti e i libri. Subìto il colpo basso per cui di libri nell’archivio segreto del Vaticano non ce n’è manco l’ombra (oltretutto la gran parte sono manoscritti, neanche dattiloscritti), inizio a muovermi tra le file di armadiature a vista: è particolarmente emozionante e al tempo stesso stimolante. Ne saggio la resistenza, ne apprezzo il semplice ma elegante meccanismo che consente di ruotarle in avanti o di far traslare i cinque vasconi su ogni lato, i doppi fermi e i rinforzi che permettono loro di reggere senza timore alcuno parecchi quintali di carta vecchia e vecchissima. Apprezzo i sessanta centimetri scarsi di passaggio tra una fila di armadi e l’altra, mentre cerco di prendere anche qualche appunto sulla Moleskine, ascoltare le mitragliate in inglese maccheronico della guida e non perdermi o, peggio ancora, battere un frontale con qualche scaffale smosso magari buttando giù un lustro di pratiche del tribunale del Sant’Uffizio. Per certe cose dice che c’è la scomunica istantanea: tu lo sai, non c’è bisogno che te lo dica nessuno. Il risultato è che i miei appunti non riuscirebbe a leggerli neanche Nostradamus. Ma c’è di peggio.
Qui, spiega la guida, da dieci anni si procede alla sostituzione dei vecchi faldoni e scatole, con nuovi raccoglitori più adatti alla conservazione. Il sotterraneo non ha fine, il materiale che vediamo è tutto consultabile perché il termine ultimo è a cavallo della guerra; vengono “liberati” i documenti di un papato alla volta, con l’eccezione dei documenti del Concilio Vaticano II che Giovanni Paolo II ha reso subito consultabili. In fondo al bunker, però, là dove la geometria dell’ambiente non è certamente più euclidea, c’è una grata di metallo che copre un’altra sezione (minoritaria) del bunker: là ci sono i documenti non ancora consultabili. Si possono vedere i titoli attraverso la grata ma non aprirli o, se è per questo, toccarli con mano. Così vicini eppure così lontani.
In un paio di improvvisati scambi di battute, comincia l’assalto della stampa straniera, soprattutto quella anglosassone, alla torre vaticana. La nostra guida, oltre che maestra nell’uso dell’idioma albionico, si dimostra anche capace di non fornire neanche per errore risposta puntuale a domanda precisa e diretta. Evita, scantona, scivola via, più doroteo che moroteo. Domani c’è la conferenza stampa di presentazione della mostra assieme al cardinale, e di questo poi si può parlare con i tecnici, e di quest’altro con gli esperti, e infine chi può dire quanti documenti siano conservati qui o chi scelga quale vedere? Ci sono 85 chilometri di scaffali, impossibile dire, impossibile sapere. Anche alla mia innocente domanda sul perché in tutti gli uffici che abbiamo passato campeggino vecchi Macintosh d’annata (soprattutto iMac di prima e seconda generazione) risponde con vaghezza, abilissimo nel cambiare tempo e aprire pause dove l’analisi logica chiederebbe un predicato, un complemento oggetto, sicuramente non uno iato. C’è per certo una ragione, chiosa, prima di ripartire con un altro discorso che forse era la premessa a quanto diceva prima sulle stanze superiori.
A quel punto, tramite una scaletta a chiocciola che si arrampica attorno a un ascensore impostato in una infinita griglia di ferro battuto a trame fitte, da vecchio palazzo libery, ma con il gusto e la consistente fuga verticale di un faro oceanico, partiamo per una vera e propria tappa di montagna. Il quadro dei comandi dell’ascensore presenta un piano terra e altri tre livelli. Peccato che qui si sia ridefinito il concetto di “ambiente dai soffitti alti” e che probabilmente tra uno e l’altro si sarebbe potuto soppalcare in altezza una villetta bifamiliare comprensiva di mansardina per il figlio. L’impatto sul gruppo “stagionato” di professionisti della comunicazione è devastante. Durante la seconda metà della visita si sentono fischi, sibili, qualche rantolo, almeno un fenomeno patologico che suona come un mezzo enfisema. Siamo una categoria di travet sedentari, non c’è dubbio.
Passiamo alla parte dove si archiviano i documenti in armadi storici e dove si possono anche consultare. Non possiamo andare al “piano nobile” per via di improrogabili lavori, andiamo allora a quello superiore, detto “diplomatico”. Le sale hanno più storia della maggior parte di quelle in cui ci potrà mai capitare la ventura di entrare: ci sono secoli di documenti diplomatici che provengono dalle nunziature apostoliche di mezzo mondo. Tutti lì, davanti a noi. La nostra guida osserva che, caso unico nella storia, l’Archivum contiene anche moltissimi documenti internazionali, vista la particolarissima postura geopolitica dello Stato Vaticano. Gli archivi di Stato sono infatti solitamente molto autoreferenziati: tutti documenti amministrativi interni, al massimo qualcosa che viene dalle vecchie colonie. Per il Vaticano, tutta un’altra musica: si suona una tastiera molto più lunga, globale, sconfinata. Larga quanto il mondo.
Nel bunker mi ero appuntato un paio di segnature dalle coste dei faldoni. Qui ne vedo altri con una doppia numerazione: la seconda, spiega la guida, risale a quando Napoleone Bonaparte prese Roma e si portò via fino a Parigi tutti i documenti, come era solito fare nelle terre conquistate. Fu un duro colpo, ma ancora più duro quello che venne dopo la caduta di Napoleone: per recuperare le carte, e ci vollero almeno trent’anni, non bastavano i sodi. Fu quindi deciso di lasciarne in Francia un quarto del totale, tutti quelli giudicate i meno importanti. E ci si decise a bruciarli sul posto, per evitare che finissero in mani sbagliate (si trattava pur sempre di documenti di Stato). Un quarto del totale. Tutti bruciati. Penso se qualcuno mi chiedesse di bruciare un quarto dei libri della mia nuova Bestå e il sudore sulla schiena mi si gela con un brivido.
Nell’Aula XX, voluta da Alessandro VII, c’è in bella mostra la scritta peraltro spesso ricorrente “È vietato rigorosamente di fumare”, che fa pensare come, nell’era della digitalizzazione di tutto, la carta sia ancora e con preponderanza il mezzo che contiene la nostra memoria. Sicuramente quella del Vaticano. Nel mio piccolo, anche la mia.
Riprendiamo la salita. Questa volta la ginnastica è ancora più difficile. Dev’essere l’acido lattico. Arriviamo in una serie di stanze alquanto strette e ben affrescate. Piccoli capolavori. Difficile valutare gli ambienti, anche perché abbiamo passato letteralmente un dedalo di corridio e scale senza mai una finestra. È sempre vietato fare fotografie. Adesso siamo in una stanza che è stata in origine una loggia poi chiusa. C’era l’anemometro a soffitto (prodigio rinascimentale) e soprattutto la meridiana che gli studiosi agli ordini di Gregorio XIII utilizzarono per calcolare quanto giorni si dovessero saltare partendo da una certa data del 1582. Era il momento in cui si decise di lasciare il conto dei giorni voluto da Giulio Cesare più di 15 secoli prima, detto calendario Giuliano, e passare a quello detto calendario Gregoriano. Bella responsabilità, mi chiedo se Obama o Putin oggi se la sentirebbero di imporre un tale cambiamento epocale rivoluzionando il calendario. In cambio verrebbero ricordati per qualche decina di secoli. Mentre mi distraggo con questi pensieri oziosi, mi perdo la spiegazione scientifica fatta di solstizi e anni bisestili che dopo quattrocento anni si devono saltare. Invece raccolgo solo l’indicazione per vedere un piccolo buco nel muro, in alto, nell’affresco del Pomarancio che impreziosisce la stanza dove poi dormirà anche la regina Cristina di Svezia. È da lì che entra il sole a mezzodì, facendo funzionare la meridiana.
Finiamo di salire e arriviamo alla terrazza in cima alla torre dei Venti, il secondo edificio più alto del Vaticano dopo la cupola di San Pietro. La vista è da mozzare il fiato. La città eterna è distesa ai nostri piedi, i gabbiani volano attorno a noi come se fossimo sulla più alta scogliera di un mare di luci e di palazzi traversati da fiumi di macchine e dall’urlo lontano delle sirene che punteggiano un mare di clacson e di motori imballati nel traffico dell’ora di cena. Strane le associazioni che una simile vista porta a scattare nel cervello. Il collega pisano accanto a me coglie l’attimo e mi racconta di quanto, giovane studentello in cerca di un appartamentino nella città toscana, si vide offrire dallo scafato agente immobiliare un prestigioso immobile con ampia vista su piazza dei Miracoli. Una vista tale che, osservò l’agente in questione, “se la porti quassù poi te la deve da’ pe’fforza”.
Rasserenati dalla vista, ci disponiamo a tornare dabbasso. Una volata di 176 metri, a quanto mi è dato capire, che termina nella sala degli indici. Ci viene spiegato che qui sono conservati i differenti metodi usati nel corso dei secoli per cercare di mettere ordine nel materiale infinito dell’Archivum. Sembra impossibile, ma c’è stata un’epoca – prevalente rispetto alla durata dell’umana cultura scritta – in cui non era possibile cercare dei testi se prima non si era provveduto manualmente a creare indici e cataloghi dei loro contenuti. Addirittura, di pezzi oramai andati distrutti a causa del “trasloco forzato” voluto da Napoleone, ne rimane traccia solo negli indici e da questi si può cercare di interpolare parte di contenuti altrimenti obliati per sempre.
Per darci soddisfazione ci vengono fatti vedere quattro documenti presi “a caso” ma con cura dagli 85 chilometri di scaffalatura che ci circonda. C’è una lettera di Galileo Galilei datata 1630 che chiede al Papa di avere accesso all’Archivum (negata), una di Leibniz del 1702 che vuole venire a consultare alcune carte scientifiche (acconsentita), una di Garibaldi che scrive alla nunziatura apostolica di Montevideo spiegando che c’è stato il perdono papale e che lui gradirebbe rientrare in Italia (avallato ma inutile), e infine una del 1569 della regina Elisabetta I che chiede al segretario di stato dell’epoca, cioè Tolomeo Galli, di liberare un mercante italiano arrestato per problemi di tasse ma per lei essenziale nel commercio di allume, materiale estratto a Tolfa e preziosissimo per la conservazione di tessuti e cibo. Il mercante non venne liberato ma la scrittura dell’anziana regina è straordinariamente ordinata e precisa, la firma un gioco di svolazzi geometricamente ordinati e il pensiero in un attimo è alla mia difficoltà innata nel dare ordine continuo alle stanghette orizzontali e verticali fin dalla prima elementare. È probabile che anche qui si siano dette cose che ho completamente perso.
Entriamo nel vivo. Si parla di conservazione, di archiviazione, di recupero dell’informazione. Il Vaticano sta assaggiando le acque digitali con attenzione ma anche con una certa diffidenza. Da una ventina d’anni nella cittadella si è capito che l’informatica non è una moda passeggera e così gli sforzi di questa gigantesca macchina si sono concentrati nel tentare di individuare i percorsi da seguire. Anche gli iMac dell’Archivum hanno una spiegazione razionale: i computer di Apple sono stati scelti a partire da metà anni novanta per la loro capacità di rappresentare immagini raster, gestire più alfabeti e per la semplicità d’uso. Presa l’abitudine, nessuno ha pensato fosse necessario cambiare fornitura: quindici anni per un’istituzione che va avanti da quattro secoli sono un battito di ciglia o poco più. E poi i Mac arredano, tema al quale il noce massello e il palissandro lucido dei tavoli e delle cattedre nelle sale di consultazione, con ciascuna postazione illuminata da una piccola lampada Tolomeo ancora scintillante, tradiscono una certa predisposizione – verrebbe da dire debolezza – curiale. Dopotutto, uno dei più alti scopi dell’esistenza umana non è forse quello di tenere il brutto lontano da noi?
Torno ancora una volta con la mente alla conferenza. Siamo alle strette finali, la visita sta per finire. Viene spiegato che sono stati digitalizzati due milioni e mezzo di documenti, si usa una fotocamera digitale (dorso e ottica) per scattare immagini che possono arrivare sino a 200 megabyte, e in tre anni sono circa 50mila le pergamene e altro che hanno visto una nuova edizione digitale. In totale, il tesoro digitale è di 48 terabyte di dati, che viene gestito in una serie di dischi in Raid forniti da Emc e poi con un backup su nastro che viene parcheggiato “in cassaforte”. Sentendo usare questo termine qui, a due passi dal bunker secolare dell’Archivum, non oso immaginare a quale struttura si possa fare riferimento. Nuova distrazione questa volta evitata.
In tre anni tutto l’Archivum è stato cablato, ci sono server che forniscono accesso ai documenti in miniatura ovunque nella struttura, mentre il file in alta risoluzione viene salvato in Tiff ed è conservato al sicuro nei dischi di cui sopra. Si procede anche alla sostituzione dei documenti digitalizzati con la loro versione elettronica, mentre l’analogico viene messo finalmente in condizioni di sicurezza. L’operazione è complicata dal fatto che molti di questi documenti vengono costantemente richiesti per la consultazione (ogni anno alcune centinaia di studiosi accreditati di qualsiasi confessione religiosa utilizzano l’Archivum). La mole di lavoro è infinita, le persone impegnate sono solo dieci, mentre ci sono 1700 indici, 85 chilometri di scaffalatura (ancora!), 630 fondi archivistici diversi, milioni e milioni di potenziali documenti da scannerizzare. In un anno, su 1.200 indici di cui si prevede la digitalizzazione, si è riusciti a procedere sino al numero 259. L’opera si presenta senza fine. Ma non c’è fretta.
Quest’ultima fase è rallegrata da un grazioso esercizio di giornalismo anglosassone: il corrispondente di un noto quotidiano londinese, un orso alto quasi due metri di una cinquantina d’anni, folti capelli brizzolati e un intrigante cappotto di spigato grigio chiaro che copre il gessato con panciotto di cotone rosso molto Fleet street, continua a cercare risposte a due pressanti domande. La prima: ma quanti documenti ci sono qui dentro? (La risposta: impossibile dirlo. Sono 85 chilometri di scaffalatura, lei capisce, non si può sapere). La seconda: quali documenti vengono resi pubblici, chi lo decide, insomma quali segreti si celano in questi archivi? Cosa viene tenuto nascosto alla pubblica opinione? (La risposta è ineffabile e inafferrabile. Un silenzio che sfuma letteralmente nel niente).
Ma i documenti andranno mai online? E chi può dirlo. Quali aziende lavorano al progetto di digitalizzazione? Nessuna, facciamo tutto internamente. Ma i nuovi documenti generati dall’amministrazione pontificia sono già in digitale o nascono ancora cartacei? Massimamente cartacei, ma non si può mai dire.
Si è fatto tardi, è tempo di tornare in hotel, dove ci attende un momento conviviale e poi via, i romani tornano a casa e gli altri hanno il pernotto in attesa di ripartire verso le rispettive destinazioni domattina.
Mi porto a casa l’immagine di un uomo, Giuseppe Garampi, prefetto dell’Archivum dal 1751 al 1772 che, con pochi valorosi, setacciò l’intero l’intero archivio, segnandosi date, nomi, luoghi, argomenti particolari, comprese le schede contenenti notizie relative alla storia di tutte le diocesi e i vescovi del mondo al fine di scrivere l’opera struggente di un titanico genio: quell’Orbis christianus (il Mondo cristiano) che avrebbe dovuto non solo dargli il primato nel settore dell’archivistica, ma anche un podio di primo piano per quanto riguarda la storia. Purtroppo il Garampi non gliela fece. L’Orbis christianus non è mai stato scritto. È rimasto solo un titanico indice, in un’unica copia, che serve da base per fare ricerca in un archivio che in buona parte non esiste più. Centoventicinque grossi volumi, 800mila schede: un gigantesco elenco del telefono del Vaticano ma anche di Atlantide, di una città che in parte non esiste più, in parte sembra non essere mai neanche esistita.
Stamani, sul Freccia Rossa 9622, carrozza 11 posto 86, mentre passavamo attraverso la pianura padana con una furia quasi illuminista, da Rivoluzione industriale, fantasticavo di chissà quante cose mi erano passate accanto senza che me ne potessi accorgere. Milioni di pezzi di carta racchiusi in scatole e faldoni, l’architrave amministrativa di una intera civiltà. A 300 chilometri all’ora, sbandando leggermente sotto il peso di due possenti locomotive, una trainante e l’altra spingente, non mi è parso che la mia curiosità iniziale fosse stata appagata. Mi sono sentito, invece, particolarmente ignorante. A tal punto abituato a trovare tutto quel che cerco già bell’e pronto e in formato digitale, nell’arco di pochi decimi di secondo, da giudicare inesistente la più gran parte della enorme mole di informazioni attorno a me solo perché posta un po’ più in là, nel buio.
Lux in arcana?